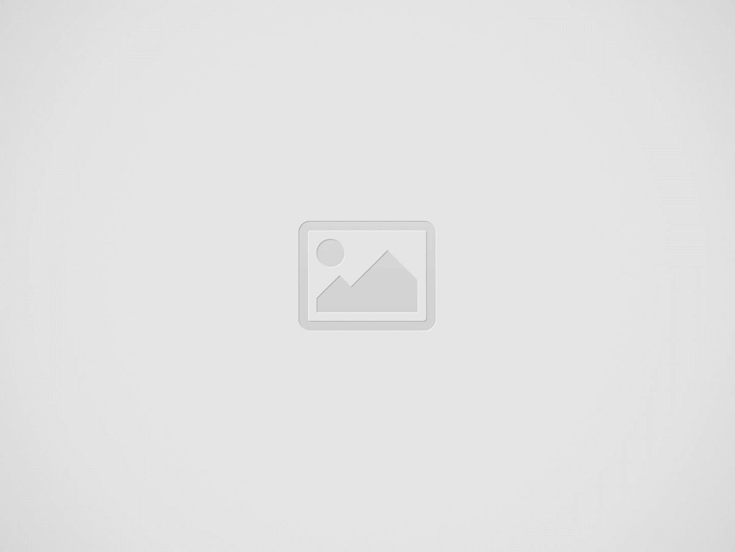Con un candidato di 82 anni al voto presidenziale americano nel novembre 2024 e l’altro di 78 se sarà Donald Trump lo sfidante, sarebbe facile prefigurare un grande spettacolo con apoteosi della quarta età. Ma la posta in gioco è molto alta. Non solo per gli americani, cosa che ci interessa indirettamente, ma anche per un’Europa che ha confermato ampiamente con la vicenda ucraina la propria dipendenza strategica dalla Nato e quindi da Washington, e che deve inoltre decidere come schierarsi nella grande partita a scacchi fra Stati Uniti e Cina per la supremazia globale.
La politica estera nella campagna elettorale Usa
La politica estera sarà meno secondaria del solito nel dibattito elettorale americano 2024, e non solo per i rapporti pessimi con Mosca. Pesa molto il riallineamento economico globale, la fine della globalizzazione, il decoupling, cioè lo sganciamento (relativo) tra economia americana e cinese, la possibilità di un reshoring, cioè di uno spostamento di attività oggi in Cina, o addirittura di un friendly-reshoring o friendshoring, cioè di investimenti in Paesi amici come proposto dal ministro del Tesoro, Janet Yellen. Il tutto mentre giganteschi aiuti all’industria americana suonano invece per ora le melodie del protezionismo. Siamo ormai alle mosse decisive, e il tutto sarà al centro del dibattito elettorale americano, date le ampie ricadute in politica economica interna dei rapporti con Pechino.
Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato che nel caso cinese l’Europa non può replicare le posizioni americane. Ma resta tutto da vedere.
È dal 2020 che l’America sta preparando la risposta al MIC 2025, il piano Made in China con cui Pechino prevede tre tappe: meno dipendenza dall’estero, creare campioni nazionali per dominare il mercato interno, lanciare questi campioni sul mercato globale. Fu messo a punto nel 2015, dopo che nel 2010 la Cina era diventato il primo Paese manifatturiero mondiale per valore aggiunto, e ha già fatto sentire i suoi effetti su vari gruppi internazionali, anche italiani come la Danieli (siderurgia), che stanno differenziando rispetto al passato e concentrando meno sulla Cina.
L’Europa resta con le spalle al muro
La guerra in Ucraina ha messo con le spalle al muro un’Europa incapace di superare le dimensioni nazionali. Tanta storia ma scarso presente, impari tra l’altro, da soli, a gestire il revanscismo russo. Si potrebbe applicare all’intero consesso europeo ciò che Dean Acheson, già Segretario di stato americano, diceva nel 1962 della Gran Bretagna: “Ha perso un impero, e non ha ancora ritrovato un ruolo”. Più volte l’euro-americano Henry Kissinger ha gettato oltre lo sguardo. “Gli Stati Uniti” scriveva nel 2014 in World Order, “hanno ogni motivo storico e geopolitico per sostenere l’Unione Europea e prevenire il suo scivolamento in un vuoto geopolitico; gli Stati Uniti, se separati dall’Europa in politica, economia e difesa, diventerebbero infatti geopoliticamente un’isola sulle sponde dell’Eurasia, e l’Europa stessa si ridurrebbe a un’appendice alle sfere di azione dell’Asia e del Medio Oriente”. E aggiungeva: “L’Europa, che aveva un quasi monopolio nel disegnare l’ordine globale meno di un secolo fa, rischia di tagliarsi fuori dalla ricerca contemporanea di un ordine mondiale identificando la propria costruzione interna come la sua definitiva missione geopolitica”. Una contemplazione insomma del proprio ombelico, e questo mentre l’America, i bianchi americani meno scolarizzati soprattutto, si sentono più figli degli isolazionisti che non dei grandi diplomatici che crearono 75 anni fa il sistema occidentale e il legame con l’Europa. Quelli kissingeriani sono giudizi pesanti ma realistici, più consoni al modo di pensare di Joe Biden e del tutto estranei a quello di Donald Trump, che riassume come noto il proprio pensiero nello slogan MAGA, Make America Great Again. Come, non si sa.
Trump: sottovalutato o sopravvalutato?
Nel 2016 gli europei, più ancora di molti americani, sottovalutarono Trump, che già a gennaio di quell’anno se non prima dimostrava buone possibilità di farcela. Per due motivi sostanzialmente: la debolezza di Hillary Clinton, candidato poco adatto per una stagione anti-Washington, e la delusione subita da vari strati popolari tipo i bianchi senza istruzione universitaria con Obama, populista anti-establishment da candidato, difensore dell’establishment (finanziario, prima di tutto) non appena eletto presidente, nel bel mezzo del grande crack bancario del 2008; non va mai dimenticato che delle 700 contee americane (in totale sono 3143) che avevano votato Obama nel 2008 e nel 2012 più di 200 premiarono Trump nel 2016, e questo fece la differenza nel Midwest ex industriale.
Comunque Trump vinse in modo risicato per 80mila voti in tre Stati-chiave, conquistando i loro electoral votes. Così come per non molto, nell’electoral vote, vinceva Biden quattro anni dopo. Oggi molti osservatori europei sopravvalutano invece Trump, fermandosi a considerare quel 30% scarso dell’elettorato repubblicano che, secondo i più attendibili sondaggi, gli resta fedele o fedelissimo nonostante tutti gli scandali, il tentativo di rovesciare i risultati del voto 2020 in vari Stati, l’assalto delle sue bande al Congresso, i procedimenti giudiziari che tra l’altro ne fanno un martire, lo stile a dir poco disordinato e maniacale di governo. Con questo appoggio di base Trump è e resterà a lungo nel 2023 il frontrunner, il candidato numero uno, per i repubblicani. Ma i giochi si faranno fra 10-12 mesi.
Biden ha annunciato ora l’intenzione di chiedere un nuovo mandato e sarà certamente il candidato democratico, se la salute lo sorregge in questo anno e mezzo. Nel voto di metà mandato, nel novembre scorso, i democratici si sono difesi meglio del previsto in una tornata che in genere penalizza il partito del presidente. E non è detto che Trump sia lo sfidante, anche se si è candidato a inizio gennaio in tempo per comparire come candidato davanti alla magistratura, a New York e altrove.
Repubblicani alla ricerca di un candidato alternativo a Trump
Il vertice del partito non lo ama, anche se i gruppi parlamentari, soprattutto alla Camera, non vogliono alienarsi i suoi sostenitori. “Ha dimostrato di essere un perdente”, dice di lui l’ex presidente repubblicano della Camera, Paul D. Rayan. Qualche senatore influente lo appoggia. I più tacciono. Mentre da sondaggi discreti fatti tra i 168 membri del National Committee repubblicano, riuniti tre mesi fa in California, risulta secondo il New York Times che da 120 a 140 propenderebbero per un candidato diverso da Trump, un risultato sorprendente, se confermato, visto che molti sono stati nominati nell’era Trump.
Questo candidato diverso non emergerà presto, si veda in proposito la prudenza del governatore della Florida Ron De Santis, perché è noto che fu la pletora di candidati repubblicani alle primarie del 2016 a far emergere Trump con un blocco di circa un quarto dei voti che surclassava però qualsiasi consenso raggiunto dagli altri. Il partito cerca un candidato credibile, capace di non alienare il voto populista, ma anche capace di assicurare un migliore stile di governo. E anche più giovane, per giocare meglio la carta dell’età di Biden. Se poi Trump dovesse optare per una candidatura autonoma, temendo di non ottenere la nomination e togliendo così alcuni milioni di voti al partito, sarà lui ad avere garantito la riconferma di Biden. È ben capace di farlo, con il suo ego smisurato, per dimostrare quanti milioni sono pronti a seguirlo fino all’inferno.
Se così sarà, l’anziano attuale presidente dovrà sovraintendere, già adesso e ancor più nel suo secondo mandato, a una delicata operazione di diplomazia economica che va al cuore dei nuovi equilibri geopolitici globali, che coinvolge pienamente l’Europa, e che non può ignorare i Paesi terzi di Asia Africa e America Latina, se non si vuole regalarli più di quanto non sia già avvenuto alle sfere della Russia e, molto più, della Cina. Tra il 1944 i primissimi anni 50 Washington creò, con l’aiuto non sempre scontato (c’erano anche rivalità di vario tipo) di Gran Bretagna e Francia, un sistema di regole internazionali esemplificate al meglio dal Fondo Monetario, che resse bene fino ai primi anni ’70, e con un ruolo meno cruciale resiste tutt’oggi. Il modello, semplificando molto, era quello dell’espansione del capitalismo di pari passo con l’espansione della democrazia. Il blocco sovietico seguiva una strategia analoga, e opposta, in nome del comunismo. La globalizzazione, che ha portato anche molti vantaggi soprattutto a Paesi poco sviluppati, doveva essere la vittoria definitiva del sistema occidentale dopo il 1989. Lo è stata fin troppo, per certi aspetti, mentre per altri si è dimostrata alla fine ingovernabile da Washington e da qualsiasi altra capitale, e soprattutto ha prodotto con il modello cinese un rivale troppo forte per tutti e che incarna la non coincidenza tra sviluppo economico e democrazia, negando così la stessa filosofia dell’americanizzazione e occidentalizzazione del mondo.
Le due leggi chiave di Biden
Il governo Biden ha varato mesi fa due importantissime leggi che cercano di mettere l’America al riparo da questo “mondo nuovo” ma che rischiano di fare gravi danni se non diventano un progetto comune. Le due leggi sono l’IRA (Inflation Reduction Act, l’inflazione c’entra poco, si tratta di strategia industriale in particolare per l’auto elettrica la farmaceutica e altro) e la CHIPS and Science per i semiconduttori e la ricerca, entrambe dell’agosto 2022, e che mettono in moto circa 1500 miliardi di dollari, due terzi la prima e un terzo grossomodo la seconda legge.
”Il problema” scrivono adesso su Foreign Affairs due esperti che hanno fatto parte della diplomazia economica del governo Biden nel 2021-2022, “è se questa nuova politica industriale darà il via a una nuova corsa ai sussidi ai danni di Paesi amici e alleati o può invece essere applicata in cooperazione con essi, facendo tesoro della lezione della global minimum tax”, cioè del negoziato condotto dal governo Biden e concluso con successo nell’ottobre del 21, con l’adesione di 140 Paesi, e che fissa una tassa minima del 15% sugli utili delle multinazionali, ovunque siano realizzati, per impedire la contabilità itinerante alla ricerca del paradiso fiscale. L’articolo si intitola The Perils of the New Industrial Policy, e conclude auspicando una soluzione analoga “con i Paesi amici e alleati per affrontare il problema della localizzazione di industrie ritenute cruciali per la sicurezza nazionale e la salvaguardia del pianeta”. Non una risposta solo americana, ma una risposta multinazionale alla strategia cinese di supremazia tecnologica e geopolitica. Trump, come Putin, nemmeno vuole parlare con l’Unione Europea, per lui una non entity, come per Putin. Non ci resta che Biden.