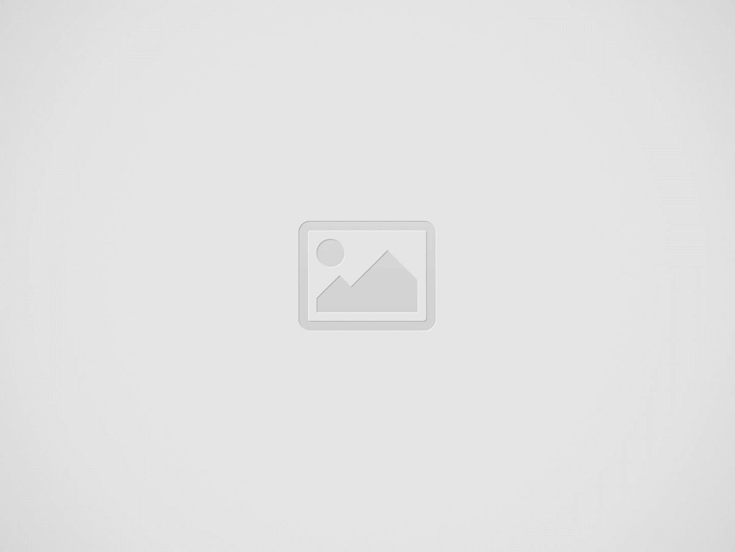Domani, il 6 gennaio, il nuovo Congresso che si è insediato venerdì è chiamato a certificare in seduta congiunta il voto con cui il collegio dei grandi elettori ha formalmente eletto Donald Trump alla Casa Bianca lo scorso 17 dicembre. Si tratta dell’ultimo adempimento nella complessa procedura di elezione indiretta del presidente degli Stati Uniti prima del suo insediamento il prossimo 20 gennaio.
Fantapolitica procedurale
Questo passaggio non può essere considerato una mera operazione di routine, soprattutto dopo quanto è accaduto il 6 gennaio 2021, quando centinaia di sostenitori di Trump hanno fatto irruzione con la violenza nella sede del Congresso, nel vano tentativo di impedire la certificazione della vittoria di Joe Biden, mentre alcuni senatori e deputati repubblicani presentavano, e avrebbero poi votato, una mozione che chiedeva di annullare i voti dei grandi elettori dell’Arizona e della Pennsylvania a favore del candidato democratico, in modo da consentire la conferma di Trump alla presidenza.
Uno sviluppo analogo, a parti politiche invertite, quest’anno rasenterebbe la fantapolitica. Infatti, quando lo spoglio di voti popolari del 5 novembre era ancora in corso, Kamala Harris ha subito riconosciuto la sconfitta, a differenza di quanto aveva fatto quattro anni prima Trump, che dichiara ancora oggi di essere stato il vero vincitore delle elezioni presidenziali del 2020 e di avere apparentemente perso solo grazie a brogli – presunti e mai provati – commessi a vantaggio di Biden.
Domani qualche deputato o senatore democratico, desideroso di ricevere il suo quarto d’ora di notorietà, potrebbe chiedere l’annullamento del voto dei grandi elettori degli Stati (il Michigan e il Wisconsin) dove lo scarto tra Trump e Harris è risultato inferiore all’1,5 % del voto popolare, motivandolo con le interferenze di Elon Musk sullo svolgimento della campagna elettorale.
Ma, ammesso pure un esito positivo di questa per il momento del tutto ipotetica richiesta, se Trump si vedesse sottratti i 25 voti elettorali complessivi di questi due Stati e scendesse da 312 grandi elettori a 287, conserverebbe comunque 17 voti elettorali in più della maggioranza minima di 270 per diventare presidente.
Non è, del resto, plausibile che l’eventuale istanza possa essere formalizzata. Infatti, fino al 2021, per presentare risoluzioni di tal sorta era sufficiente che fossero firmate da un senatore e da un deputato. Invece, allo scopo di ostacolare preventivamente Trump nell’ipotetica manovra per sollevare obiezioni al momento del conteggio del voto dei grandi elettori anche nel 2025, la maggioranza democratica al Congresso nel 2022 ha innalzato a 20 senatori e a 87 deputati, cioè al 20% dei membri di ciascuno dei due rami, la soglia minima di adesioni per formulare questo genere di contestazioni.
In ogni caso, nel Congresso appena insediatosi, il partito repubblicano è in maggioranza sia alla Camera sia al Senato e, quindi, qualsiasi impugnazione del voto elettorale da parte dei democratici verrebbe bocciata.
Il punto più basso (finora) della carriera politica di Trump
Se oggi pensare a escamotages procedurali per impedire a Trump di tornare alla Casa Bianca si configura come mera fantapolitica, quattro anni fa sarebbe sembrata tale anche la rielezione di The Donald nel 2024.
La sera del 6 gennaio 2021, dopo che il Congresso era stato sgomberato dai paladini del tycoon che vi avevano fatto irruzione e l’elezione di Biden era stata certificata in seguito al ripristino dell’ordine, Trump appariva un aspirante golpista, con l’aggravante di essersi rivelato alla fine incapace di portare a termine l’insurrezione che aveva istigato e di realizzare le proprie aspirazioni a impartire una svolta autoritaria nella politica statunitense.
Secondo i dati del Pew Research Center, The Donald lasciò la Casa Bianca il 20 gennaio 2021 con l’indice di gradimento più basso per un presidente alla conclusione del proprio mandato da quando venivano condotti i sondaggi di opinione.
Se all’inizio di gennaio del 2021 il 34% degli statunitensi aveva approvato la sua politica, la percentuale scese a un minimo storico del 29% dopo i fatti del 6 gennaio, in seguito a una perdita di consenso registrata soprattutto tra gli elettori repubblicani.
Trump era diventato un paria della politica, caduto in disgrazia non solo agli occhi di gran parte dell’opinione pubblica ma anche di fronte al suo stesso entourage. Mike Pence, che The Donald aveva scelto per la carica di vicepresidente facendolo uscire dal semianonimato di governatore dell’Indiana, si era rifiutato di avallare i suoi propositi eversivi, lasciando che il Congresso proclamasse Biden come nuovo presidente.
Il capo di stato maggiore delle forze armate, il generale Mark Milley, scelto da Trump per l’incarico contro la volontà del proprio segretario alla Difesa che gli avrebbe preferito il generale David L. Goldfein, assicurò che i militari non si occupavano di politica e restavano fedeli alla Costituzione.
Per non essere associate a progetti insurrezionali, si dimisero dal governo le titolari dei dicasteri dei Trasporti, Elaine Chao, e dell’Istruzione, Betsy DeVos. Il procuratore generale (la versione statunitense del ministro della Giustizia), William Barr, aveva già rinunciato all’incarico due settimane prima, dopo aver riscontrato l’inconsistenza delle prove sui presunti brogli elettorali a favore di Biden.
Decine di alti funzionari lasciarono l’amministrazione federale per dissociarsi dall’operato di Trump del 6 gennaio. Perfino la figlia Ivanka prese le distanze da The Donald. Da allora, oltre 1.600 sostenitori trumpisti sono stati incriminati per l’irruzione nel Congresso.
Enrique Tarrio, leader degli Young Boys, una milizia paramilitare ultraconservatrice, è stato condannato a ventidue anni di carcere in quanto ritenuto il principale organizzatore materiale del tumulto. La sentenza è stata di dieci anni per uno dei suoi luogotenenti, Dominic Pezzola, il primo degli assalitori a essersi introdotto con la forza nell’edificio del Congresso.
Gli inquirenti hanno decapitato pure un’altra formazione di estremisti, gli Oath Keepers: al loro leader e fondatore, Stewart Rhodes, è stata inflitta una pena di diciotto anni; per il capo della sezione della Florida, Kelly Meggs, gli anni di prigione comminati sono stati dodici.
Lo stesso Trump riuscì a sottrarsi all’impeachment per aver incitato i rivoltosi solo perché la sua condanna – con la conseguente interdizione dalle cariche federali, presidenza compresa – avrebbe necessitato dell’assenso di 67 dei 100 membri del Senato, ma i democratici disponevano di quarantotto seggi e, sia pure affiancati dai due unici senatori indipendenti, furono capaci di portare dalla propria parte appena sette dei cinquanta colleghi repubblicani.
“Non è pazzesco”?
Quattro anni dopo l’irruzione al Congresso, Trump si accinge a reinsediarsi alla Casa Bianca. Non è il primo ex presidente a riconquistare la carica dopo una sconfitta elettorale. Prima di lui ci era riuscito il democratico Grover Cleveland che, dopo essere stato battuto dal repubblicano Benjamin Harrison nel 1888, si prese la rivincita nel 1892.
Tuttavia, Cleveland non era mai caduto in disgrazia e, men che mai, poteva essere considerato un fomentatore di eversione politica. Tant’è che nel 1888, pur avendo conquistato più voti popolari del suo sfidante, accettò di buon grado l’elezione di Harrison senza accusarlo di avergli “rubato” la presidenza.
Il ritorno di Cleveland al potere non destò particolare sorpresa. Diverso è il caso dell’elezione di un candidato pregiudicato e legittimamente sospettato di essere un golpista mancato. Nel suo intimo, al di là della spavalderia delle dichiarazioni pubbliche, neppure Trump avrebbe creduto possibile il suo rientro alla presidenza, soprattutto dopo essere stato condannato da un tribunale di New York in sede penale per tutti e 34 i capi di imputazione formulati in merito alle falsificazioni di bilanci aziendali per comprare il silenzio di Stephanie A. Gregory, in arte Stormy Daniels, un’attrice di film pornografici con la quale avrebbe avuto una relazione.
Non a caso, nel discorso celebrativo della sua vittoria, tenuto nella notte tra il 5 e il 6 novembre, rivolto ai propri sostenitori Trump si è lasciato sfuggire un “non è pazzesco?” in riferimento alla propria rielezione.
Verso una narrazione rovesciata
La certificazione della rielezione di Trump è un atto dovuto del Congresso e un passo incontestabile dal punto di vista giuridico e istituzionale. In questo modo, però, si creeranno anche le condizioni per rovesciare la narrazione ufficiale di quanto è avvenuto il 6 gennaio di quattro anni fa, trasformando implicitamente i golpisti in patrioti e i difensori della legalità in sovversivi. Finiranno pure per trovare un’implicita legittimazione le tentazioni autoritarie di The Donald.
In un’intervista rilasciata in dicembre al settimanale Time, Trump ha preannunciato che uno dei provvedimenti che assumerà, “nella prima ora, forse nei primi nove minuti” del suo secondo mandato sarà quello di concedere il perdono presidenziale agli assaltatori del Congresso, pregiudicati che in precedenza il tycoon aveva più volte definito “ostaggi” e “prigionieri politici” dell’amministrazione Biden.
A questo colpo di spugna, giudiziario prima ancora che politico, seguirà l’opportunità di vendicarsi di coloro che hanno impedito quello che il 6 gennaio 2021 si profilava come un vero e proprio colpo di Stato. Se, come pare ormai probabile, il Senato ne confermerà la nomina, alla guida del dipartimento di Giustizia andrà Pam Bondi che, al tempo delle incriminazioni dei trumpiani che avevano fatto irruzione nel Campidoglio, si era segnalata per aver dichiarato che gli inquirenti avrebbero dovuto essere a loro volta inquisiti.
Kash Patel, che The Donald ha designato a dirigere l’FBI, è un sostenitore della “Fedsurrection” (crasi delle parole “federal” e “insurrection”), cioè della teoria cospirativa secondo la quale a irrompere nelle aule del Congresso sarebbero stati agenti federali provocatori sotto copertura che intendevano screditare Trump e il suo movimento Make America Great Again.
Barry Loudermilk, il deputato repubblicano della Georgia che presiede l’Administration Subcommittee on Oversight (il sottocomitato della Camera che si occupa della sicurezza del Campidoglio), ha diffuso un rapporto in cui si chiede l’incriminazione di Liz Cheney – l’ex deputata repubblicana che era stata vicepresidente della commissione d’inchiesta sui fatti del 6 gennaio 2021, appena insignita da Biden con la Presidential citizens medal – per avere avallato notizie false sul ruolo di Trump quel giorno.
Sono anche circolate voci sulla volontà di trascinare il generale Milley davanti a una corte marziale, con l’imputazione di alto tradimento, in quanto, dopo il 6 gennaio, avrebbe contattato i vertici della gerarchia militare della Repubblica Popolare Cinese per rassicurarli che Trump non avrebbe potuto compiere un colpo di testa finale, lanciando un attacco contro Pechino.
Uno dei più accesi critici del presunto operato di Milley è Marco Rubio, all’epoca vicepresidente della commissione sull’Intelligence del Senato e oggi segretario di Stato designato dal tycoon.
Più in generale, per assicurare preventivamente l’asservimento dei funzionari ai voleri della Casa Bianca, il Project 2025 del think tank conservatore Heritage Foundation propone un rafforzamento dei poteri dell’esecutivo con l’attribuzione al presidente della prerogativa di destituire, a suo insindacabile giudizio, tutti i dirigenti dell’amministrazione federale, compresi quelli assunti in base a criteri meritocratici attraverso concorsi pubblici e protetti dal Civil Service Reform Act del 1978 contro il licenziamento senza giusta causa.
Nel frattempo, l’elezione di Trump alla Casa Bianca ha comportato il rigetto della causa penale federale già intentata contro di lui dal procuratore speciale Jack Smith con l’imputazione di avere cospirato al fine di ribaltare l’esito delle elezioni presidenziali del 2020 incitando i suoi sostenitori a dare l’assalto al Congresso. La politica del dipartimento di Giustizia, infatti, è quella di non perseguire i presidenti in carica, la funzione che Trump tornerà a ricoprire dopo il suo insediamento il 20 gennaio.
Una riprova di come i tempi stiano cambiando rispetto alla valutazione degli eventi del 6 gennaio 2021 è data dalla constatazione che, secondo quanto ha riferito la rete televisiva Cbs, alcuni degli imputati ancora sotto processo o in attesa di giudizio, soggetti al divieto di recarsi a Washington per evidenti ragioni di ordine pubblico, avrebbero avuto l’ardire di chiedere ai tribunali che li stanno giudicando l’autorizzazione per presenziare alla cerimonia del secondo giuramento di Trump.
L’eterogenesi dei fini
Il ritorno di Trump alla presidenza non significa necessariamente che gli statunitensi desiderino l’instaurazione di un regime autoritario. Sulla necessità di scongiurare questa possibile conclusione, sia Biden, mentre era ancora in corsa per un secondo mandato alla Casa Bianca, sia Kamala Harris, dopo essergli subentrata come candidata democratica, hanno impostato la loro campagna elettorale lo scorso anno, facendo di democracy e freedom le proprie parole d’ordine.
Non a caso, la canzone Freedom di Beyoncé è stata la colonna sonora di numerosi eventi di Harris. Il grido di allarme dei democratici, però, è rimasto inascoltato da gran parte dei votanti in una fase storica in cui le reali preoccupazioni degli statunitensi e le vere ragioni della loro rabbia sono l’aumento dei prezzi, la perdita di posti di lavoro nel settore manifatturiero e la difficoltà di fronteggiare un progressivo scadimento nel tenore di vita individuale e familiare.
La lontananza di Biden e Harris dai problemi dell’americano medio ha contribuito alla rielezione di Trump, creando le premesse di una situazione paradossale: The Donald è stato riportato al vertice del potere a Washington in maniera del tutto democratica e, dalla Casa Bianca, senza bisogno di ricorrere a nuove azioni eversive eclatanti sul modello dell’assalto al Campidoglio, potrà cancellare quelle norme e alterare quelle istituzioni che da oltre due secoli hanno prodotto uno dei più grandi esperimenti democratici della società occidentale.
Sarà anche nella condizione di instaurare al loro posto una sorta di tecno-oligarchia di cui il suo sodale e principale finanziatore, Elon Musk, pare il più infervorato fautore.
Quattro anni dopo
Il 6 gennaio 2021 la democrazia statunitense dimostrò di possedere gli anticorpi per sventare progetti sovversivi portati avanti con la violenza da una folla tumultuante e minoritaria. Domani il medesimo Congresso preso d’assalto quattro anni fa ratificherà il ritorno alla guida degli Stati Uniti – questa volta con la piena legittimazione del voto espresso dalla maggioranza relativa degli elettori il 5 novembre – da parte di colui che aveva promosso proprio quel tentativo di rovesciare la democrazia.
Ma, per quanto tale esito possa apparire assurdo, forse la democrazia è anche questo e in ciò è insita la sua fragilità.
. . .
Stefano Luconi insegna Storia degli Stati Uniti d’America nel dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità dell’Università di Padova. Le sue pubblicazioni comprendono La “nazione indispensabile”. Storia degli Stati Uniti dalle origini a Trump (2020), Le istituzioni statunitensi dalla stesura della Costituzione a Biden, 1787–2022 (2022) e L’anima nera degli Stati Uniti. Gli afro-americani e il difficile cammino verso l’eguaglianza, 1619–2023 (2023).
Libri:
Stefano Luconi, La corsa alla Casa Bianca 2024. L’elezione del presidente degli Stati Uniti dalle primarie a oltre il voto del 5 novembre, goWare, 2023, pp. 162, 14,25 euro edizione cartacea, 6,99 euro edizione Kindle
Stefano Luconi, Le istituzioni statunitensi dalla stesura della Costituzione a Biden, 1787–2022, goWare, 2022, pp. 182, 12,35 euro edizione cartacea, 6,99 euro edizione Kindle