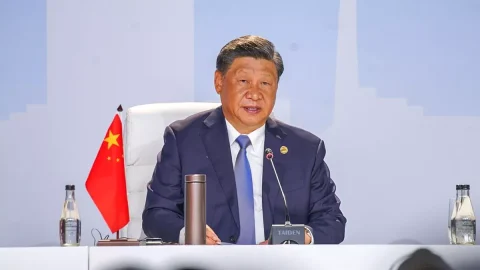Nei giorni scorsi il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato l’intenzione di voler trasferire l’ambasciata americana da Tel Aviv a Gerusalemme, riconoscendo di fatto la città come capitale dello Stato di Israele.
La decisione giunge settant’anni dopo la dichiarazione che sancì la nascita del Paese, proclamata unilateralmente il 14 maggio 1948 da David Ben-Gurion. Al tempo – così come nei decenni a seguire – non furono stabiliti i confini del nuovo Stato. Anche per questa ragione, l’ammissione di Israele alle Nazioni Unite assunse ben presto i caratteri di una priorità strategica. L’ammissione all’Onu costituiva infatti il “modo più sicuro e rapido” per ottenere un riconoscimento ampio e universale.
Il primo tentativo di ammissione di Israele all’Onu fu respinto dal Consiglio di Sicurezza il 17 dicembre 1948. Il secondo, quello che ebbe successo, risale al 24 febbraio del 1949. “I negoziati – garantì al tempo il ministro degli Esteri israeliano Abba Eban, parlando all’Assemblea generale dell’Onu – non influiranno tuttavia sullo status giuridico di Gerusalemme, che dovrà essere determinato sulla base del consenso internazionale”.
Queste garanzie – vincolanti per l’ammissione del Paese all’Onu – vennero fornite circa un anno dopo lo scoppio della guerra del 1947-48 (si veda “sacred mantras” di Uri Avnery sulla questione del “rejectionism”): nessuno degli eventi storici – e relative interpretazioni – occorsi nei successivi sette decenni è in grado di minare la valenza giuridica di quelle garanzie.
Ciò è ancora più rilevante se si considera che quando nel 1980 Israele emanò la “Basic Law” attraverso cui Gerusalemme “completa e unita” venne dichiarata come “capitale di Israele”, il Consiglio di sicurezza dell’Onu reagì adottando la Risoluzione 476, nella quale venne notato che “le misure che hanno alterato il carattere e lo status geografico, demografico e storico della Città Santa di Gerusalemme sono nulle e prive di validità”.
Queste affermazioni erano peraltro in linea con lo spirito dei principi affermati 35 anni prima. Nel giugno del 1945, infatti, la Conferenza di San Francisco stipulò nell’Articolo 80 della Carta dell’Onu che l’organizzazione era rivestita dell’autorità necessaria per concludere “trusteeship agreements” volti ad alterare i diritti giuridici che erano stati sanciti dalla Società delle Nazioni nel contesto del Mandato per la Palestina. La formula “international trusteeship regime” venne poi utilizzata nel piano di spartizione (Risoluzione 181) suggerito dall’Assemblea Generale dell’Onu il 29 novembre 1947.
Il peso della Storia
Per quanto rilevanti, gli aspetti giuridici non sono in grado da soli di spiegare le ragioni per le quali le decisioni unilaterali alle quali stiamo assistendo non possono che generare ulteriore violenza e iniquità. È infatti solo volgendo lo sguardo alla complessa storia di questi luoghi che le problematiche legate alle decisioni del presidente Trump emergono nella loro evidenza.
Nonostante le diffuse e crescenti tesi assolutistiche espresse da tutte le parti in causa, “Uru-Shalem” (ovvero la città “fondata da Shalem”, una divinità venerata dagli antichi cananiti), fondata circa 5.000 anni fa, non è appartenuta a un singolo popolo o gruppo religioso nella sua intera storia. È questa una ulteriore ragione per la quale, proprio per la sua natura, Gerusalemme non può che essere internazionalizzata o condivisa.
Ben prima delle tre religioni monoteistiche, la Spianata delle Moschee, sito su cui si ergeva il Tempio di Salomone, rappresentava un luogo sacro per i cananiti. È opportuno ricordare che nella tradizione biblica la città è sovente menzionata con il nome di “Sion”, l’altura sulla quale i suoi primi abitanti costruirono la fortezza originaria dell’attuale città. Ṣiyôn è per l’appunto un termine di derivazione cananita traducibile come “collina” o “altura”.
Ancora all’inizio del secolo scorso quasi l’80 per cento degli abitanti della città viveva in quartieri ed edifici misti. Ya’acov Yehoshua, padre del celebre scrittore israeliano Abraham B. Yehoshua, testimoniò nelle sue memorie intitolate Yaldut be-Yerushalayim hayashena, (“Fanciullezza nella citta vecchia di Gerusalemme”) che nella città “vi erano edifici abitati da ebrei e musulmani. Eravamo come una famiglia […] I nostri bambini giocavano con i loro nel cortile e, se i bambini del quartiere ci facevano male, quelli musulmani che vivevano nel nostro complesso ci proteggevano. Erano nostri alleati”.
Rapporti ben più complessi
Ciò non mira a negare l’assenza di scontri di natura religiosa o confessionale. Violenze di questo genere sono documentabili già a partire dall’Alto Medio Evo. Esse, tuttavia, non rappresentano che una frazione di un millenario vissuto locale e non riflettono la complessa storia della città. Né, più in generale, quella della regione.
Si potrebbe obiettare che, in particolare nel periodo tardo ottomano, questa “complessa storia” e i relativi equilibri locali non venissero interpretati allo stesso modo da tutti gli osservatori, a cominciare da quelli esterni. Nel 1839, William T. Young, primo vice-console britannico a Gerusalemme, scrisse ad esempio che un ebreo a Gerusalemme non era considerato “molto al di sopra di un cane [much above a dog]”. Anche Young dovette tuttavia ammettere che nel caso di necessità un ebreo avrebbe trovato riparo “prima in una casa di un musulmano che in quella di un cristiano”.[1]
A ciò si aggiunga che molti “osservatori esterni” erano soliti fornire opinioni assai diverse, nonché sovente contraddittorie. Nel 1857, pochi anni dopo Young, il console Britannico a Gerusalemme James Finn notò ad esempio che vi erano “pochi paesi al mondo dove, sebbene l’apparenza suggerisca il contrario, si possa riscontrare una “così concreta tolleranza religiosa come in Palestina”.[2]
In nessun luogo più che nei registri della corte della Shari‘ah di Gerusalemme è possibile comprendere fino a che punto, tanto ai tempi di Finn quanto in altri periodi della storia ottomana, le diverse comunità locali si percepissero come elementi costruttivi del milieu locale. Lo storico americano Amnon Cohen, che per anni ha studiato i documenti conservati nelle corti gerosolimitane, riscontrò mille casi presentati da ebrei tra il 1530 e il 1601.
Cohen giunse alla conclusione che gli ebrei gerosolimitani preferissero ricorrere alle corti della Shari‘ah piuttosto a che quelle rabbiniche: “Gli ebrei ottomani”, scrisse Cohen, “non avevano motivo di lamentarsi del proprio status o delle loro condizioni di vita. Gli ebrei della Gerusalemme ottomana […] rappresentavano un costruttivo e dinamico elemento dell’economia e della società locale, e potevano contribuire – come effettivamente fecero – al suo funzionamento”.
Il passato nel presente
Arthur Balfour, che diede il nome alla celebre Dichiarazione del 1917, visitò la Palestina nel 1925: fu la prima visita della sua vita in Terra Santa. In quella occasione presiedette, con Chaim Weizmann e sua moglie Vera, l’apertura dell’Università ebraica di Gerusalemme.
Pur avendo una conoscenza molto limitata della realtà locale, Balfour era stato a lungo mosso dalla granitica convinzione che le azioni e le idee da lui sostenute fossero radicate “in antiche tradizioni, in bisogni attuali e in speranze future ben più importanti dei desideri e dei pregiudizi dei 700.000 arabi che abitano al momento quella terra antica”.[3]
Ogni lettore e ogni storico può avere un’opinione differente su queste considerazioni, nonché sull’approccio di Balfour. “La verità”, parafrasando Oscar Wilde, “è raramente pura e mai semplice”. La questione di fondo tuttavia rimane: il presidente Trump, come Balfour un secolo fa, ha scelto di imporre una visione unilaterale della realtà locale senza conoscere molte sfumature del suo complesso passato e presente. I movimenti più oltranzisti, dentro e fuori la regione, hanno tutto da guadagnare da questa decisione. A pagarne il prezzo più alto saranno invece quanti credono ancora in una pace equa.
[1] The National Archives (TNA) FO 78/368 – Young a Palmerston, 25 maggio 1839.
[2] Israel State Archives (ISA) RG 160/2881-P. Finn, Gerusalemme, 1 gennaio 1857.
[3] TNA FO 371/4185. Balfour a Curzon, 11 agosto 1919.