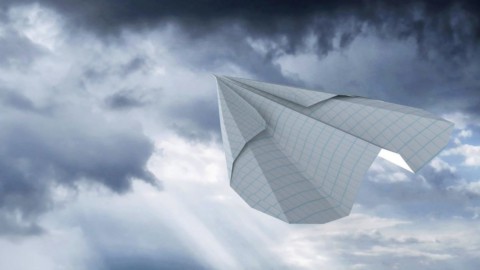È un’Europa ancora tutta da costruire quella che Roland Berger, uno tra i più blasonati consulenti mondiali, ha raccontato sabato 14 giugno al tradizionale Workshop di Venezia, evento annuale di punta del Consiglio per le Relazioni tra Italia e Stati Uniti al quale hanno partecipato anche Enrico Letta, Federica Mogherini, Carlo Cottarelli, Mohamed El-Erian e Sergio Marchionne.
Tralasciando gli spinosi temi della governance europea, Berger ha snocciolato le più significative cifre che fotografano un continente frammentato nei mercati e nelle normative fiscali, nella legislazione sul lavoro e nelle infrastrutture, nell’energia e nella cultura d’impresa. Il Vecchio Continente è la più grande area economica del pianeta, produce il 24% del Pil mondiale e il 50% della spesa sociale. Ma è intrappolato in un vortice deflazionistico e ad alta disoccupazione, rallentato da asimmetrie che minano lo sviluppo ed esacerbano le tensioni sociali.
C’è innanzitutto un problema generale di produttività totale dei fattori, sensibilmente più bassa in tutti i paesi europei rispetto, ad esempio, a Giappone e Stati Uniti, che vantano un indice pari a 106, mentre i maggiori paesi europei siedono mediamente sotto quota 100 (l’Italia è a 92). Solo la Germania tiene il passo con un ottimo 105.
Ma i trend sulla produttività e competitività – che premiano i paesi virtuosi penalizzandone altri – si inseriscono in una tendenza storica che vede, a partire dai primi anni ’70 per finire ai giorni nostri, una crescente terziarizzazione dell’economia, con la quota di Pil mondiale generata dall’industria che cala dal 26% al 17%, mentre i servizi “occupano” uno spazio sempre maggiore nel Pil, dal 53% al 66%.
Impressionante in questa prospettiva è il dato sulla Francia, clamoroso esempio di arretramento dell’industria, che ha perso negli ultimi 30 anni il 41% dell’occupazione, crollata dai 5,5 milioni di addetti nel’75 ai 3,2 del 2010. Ma per certi versi si tratta di un cammino inesorabile: questo crollo transalpino, secondo Berger, è causato per il 25% dall’outsourcing dei servizi (logistica in primis), per il 30% da un aumento della produttività (garantito, nel trentennio, dai progressi nella tecnologia, nell’automazione, nel management), e per il 45% dalla competizione internazionale (che ha portato delocalizzazioni e riduzione degli investimenti).
Anche il dato europeo non scherza: tra il 2000 e il 2012 abbiamo ridotto in media dell’1,6% la quota nostrana della manifattura mondiale. Ma fa eccezione la Germania, che l’ha fatta “lievitare” dello stesso ammontare.
Se da una parte la deindustrializzazione è conseguenza di tendenze storiche difficilmente contrastabili, rischia alla lunga di innescare un circolo vizioso che deve essere affrontato a livello europeo: secondo Berger l’Unione deve “remare contro corrente”, inseguire la crescita proprio in un settore che si sta contraendo.
Il vortice della deindustrializzazione ha innescato una perdita di ritorno sugli investimenti, che ha a sua volta disincentivato l’aggiornamento degli asset industriali – divenuti obsoleti – riducendo la competitività di prezzo e di qualità. L’Europa si è seduta in una “terra di mezzo” dove la specializzazione produttiva e l’integrazione tra le catene internazionali del valore sono ancora un processo incompiuto.
Come uscire dalla palude? Innovare la politica industriale, promuovere startup e venture capital, armonizzare la legislazione fiscale creando un contesto in cui le “regole del gioco” siano simili per tutti i giocatori. Puntare sui distretti che già ci sono, integrandoli e potenziandoli affinché si inseriscano meglio nella catena internazionale di produzione del valore. Ma anche creare un terreno fertile per le start-up e incentivare in maniera uniforme la spesa in ricerca e sviluppo.
Da rivoluzionare c’è anche il mercato dell’energia: basti pensare che il costo per le imprese in Europa è circa il triplo di quello americano. Non possono aspettare oltre i gas di scisto, le sabbie bituminose e i sistemi di cattura-stoccaggio dell’anidride carbonica. E un grande progetto continentale per implementare le “smart grid”.
Addirittura nell’ICT l’Europa ha perso quote che si stanno reindirizzando altrove. Il sintomo è che non esiste attualmente un vero campione europeo dell’economia digitale. Questo, forse, spiega in parte l’acredine verso Google (la recente sentenza della Corte sul “diritto all’oblio” potrebbe esserne una conseguenza?).
Berger calcola che servono almeno 1000 miliardi di euro di investimenti infrastrutturali per rilanciare l’Europa e propellere un mercato veramente competitivo. Andrebbero così suddivisi: 270 nelle telecomunicazioni, 220 nell’energia, 200 nel settore idrico e 180 nelle autostrade).
Dove attingere per finanziarli? Non dai bilanci pubblici, certo, in pieno risanamento, ma Berger stima che a fronte di un trilione necessario ce ne sono circa 170 disponibili a livello mondiale. E’ proprio qui – nella capacità di attrarre investimenti e venture capital – che si gioca il futuro dell’Unione.
Berger non risparmia certo i sindacati:si deve “flessibilizzare il mercato del lavoro con parti negoziali responsabili e impegnate a perseguire il benessere collettivo; sindacati e datori non devono essere motivati ideologicamente”.
Importanti sono anche i fattori culturali: promuovere una maggiore cultura del rischio e del cambiamento è fondamentale per rimettere in marcia il convoglio: in Italia il 60% delle persone pensa che la scienza faccia cambiare troppo in fretta le abitudini di vita, in Grecia la percentuale sale addirittura al 92%, mentre in Germania e nei paesi anglosassoni si scende al 45-50 %. I potenziali imprenditori, in Europa, sono inoltre spaventati dal fallimento molto più dei cugini d’oltreoceano: greci e italiani siedono, rispettivamente al 59 e 49%, gli americani sono al 31%. Ciò spiega anche la maggiore disponibilità di venture capital negli Stati Uniti, che pesa, rispetto al Pil, ben 170 volte in più.
La relazione indica una direzione, una corrente inarrestabile: quella della quarta Rivoluzione Industriale, delle reti, dell’interconnessione, dei big data. Una nuova dimensione del capitalismo globale che offre enormi possibilità, ma sottopone i player anche ad enormi rischi, se rifiutano di innovarsi. Una nuova dimensione in cui vince chi si adatta e scommette sul futuro considerando flessibilità e incertezza alla stregua di asset, non ostacoli. In questo cammino inesorabile, Berger illustra una mappa che pone l’Italia nel gruppo degli “esitatori“. Germania e Svezia, ad esempio, sono “pionieri”.