Anche il corrente dibattito nella sessione di bilancio in Parlamento ruota, come da almeno due decenni, su come rilanciare la crescita dell’economia italiana, da tempo rinchiusa in una fase che potremmo definire di stagnazione secolare. Tranne i grillini, noti untori giustizialisti e fautori di un’economia silvo-pastorale sottoposta alla pervasività del diritto penale (vedi l’abolizione della prescrizione nei processi), tutte le forze politiche auspicano la ripresa delle imprese e la creazione di nuove. Così facendo assecondano la Confindustria, che tuttavia da sempre si limita a bussare alla porta del bilancio pubblico. Prevalgono così sgangherate proposte di qualsivoglia sostegno della domanda interna che si vorrebbero attribuire al povero Keynes, che essendo morto da tempo non può ribellarsi alle considerazioni da bar sport che lo svillaneggiano.
Poiché le imprese non nascono per mano divina o invisibile, ma nascono, crescono e muoiono dipendendo dalla capacità innovativa dell’imprenditore, la domanda che si pone è se in Italia difetta il numero delle imprese o se difetta il numero degli imprenditori privati che creino e sviluppino imprese capaci di affrontare le sfide di un’economia non racchiusa nelle confortanti stanze del sovranismo autocrate e non dominata dal protezionismo interno, come ai tempi delle torrentizie svalutazioni competitive sui prezzi prima dell’euro, nel regime dei cambi irrevocabilmente fissi.
Un’occhiata alla Borsa Italiana che non si limiti a ieri può contribuire a dare qualche spiegazione alla stagnazione economica italiana.
Nel 1951, con la vecchia Iri funzionante come motore anche culturale della politica industriale del Paese, le prime tre società quotate per capitalizzazione erano Edison, Montecatini e Snia Viscosa. Dieci anni dopo, vecchia IRI ancora funzionante, erano Edison, Fiat e Montecatini; ancora nel 1971 erano Fiat, Montecatini e Sip.
Poi cominciarono ad aprirsi i mercati in regime di cambi variabili con le conseguenti svalutazioni competitive, tuttavia non sufficienti alla sopravvivenza e alla crescita delle imprese carenti nelle innovazioni di prodotto e di processo. Fu così che l’Iri divenne il luogo ove imperava il dualismo zoppo nell’ambito della economia mista. Ovvero i privati, invece di acquisire il controllo di gioielli dell’Iri, facevano acquistare dall’Iri stessa le loro imprese decotte. Nel 2018, delle prime tre società quotate in Borsa due sono a controllo pubblico, Enel ed Eni, seguite da Intesa San Paolo, controllata da Fondazione. Gli imprenditori privati si sono dissolti, almeno nella graduatoria di Borsa Italiana, e torna la voglia dell’Iri, sotto mentite spoglie, come luogo di un rinnovato dualismo zoppo.
Potrebbe essere che il libero mercato non abbia saputo guidare con la sua mano invisibile non ancora rattrappita le scelte degli imprenditori e che i sussidi a pioggia graditi da imprenditori riluttanti all’innovazione ne abbiano alterato le scelte innovative di rischio di mercato, ma potrebbe anche essere che l’abbandono di ogni qualsivoglia ipotesi di politica industriale da parte dei governi abbia contribuito a non orientare le scelte strategiche degli imprenditori italiani.
Se è impossibile e forse grottesco reinventare l’Iri di una volta, motore della politica industriale, è anche stupefacente la rinuncia da parte dello Stato ad ogni e qualsiasi ipotesi di politica industriale che orienti e incentivi gli imprenditori italiani a rinnovarsi in questa nuova rivoluzione industriale. Una situazione che non è affrontabile con Quota cento e Reddito di cittadinanza, ma nemmeno con i tradizionali trasferimenti a pioggia alle altrettanto tradizionali imprese e con riduzioni del costo del lavoro ugualmente a pioggia.




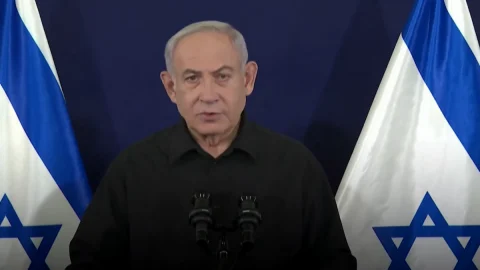

egregio Professore tutto vero quello che dice ma in questo Paese per 20 anni ministro delle riforme è stato un “signore” che perdeva tempo tra canzonette e partite di bigliardo nei lunghi inutili pomeriggi al Bar dello sport…….. .