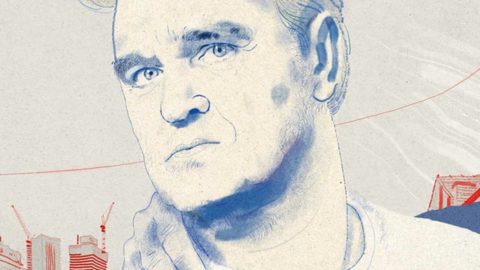Il sipario si alza su un palcoscenico buio, nero. Per qualche istante si sente una melodia in lontananza, quasi impercettibile, una voce malinconica e delle note in sottofondo, basse; dopodiché la musica si interrompe e il palco comincia a illuminarsi. La luce è bianca, forte, e al centro della scena c’è un tavolo di legno, bianco anch’esso. Sopra vi siede una donna bruna, scalza e dai vestiti strappati, con le gambe e i piedi sospesi nel vuoto e le braccia abbandonate lungo i fianchi, molli. Tiene la testa china, flaccida, come senza vita. Di fronte a lei ci sono delle sedie rovesciate, bianche come il tavolo. La luce aumenta di intensità. La donna alza il capo e guarda dritto dinanzi a sé, oltre le sedie e il proscenio, fra il pubblico; ha il volto troppo truccato, sfatto. La luce aumenta ancora, ma solo sul palcoscenico. La donna sgrana gli occhi tutt’intorno, nella sala buia, tira fuori una penna e se la rigira fra le mani, soppesandola. Tutto tace. Finalmente scende dal tavolo e dà inizio al racconto, con la penna in mano.
Certe volte – certe volte avevo la sensazione di essere davvero lui. Mi bastava un ciuffo all’aria, una domenica di pioggia, qualche ora di solitudine e di noia e improvvisamente mi tramutavo in Morrissey, sul serio, diventavo l’ex cantante degli Smiths, il fine della mia vita e la mia ossessione, la mia condanna. Ero capace di dimenarmi al buio per ore e ore, da sola, strascicando la voce e il corpo e offrendomi al mondo intero, al pubblico e alla mia stanza vuota. Immagino di poterlo fare ancora, persino qui, arrampicandomi sul tavolo e usando questa penna come un microfono, come uno scettro. Ma sarebbe uno spettacolo raccapricciante, e in fondo so che la mia voce non vi interessa: voi volete sapere delle mie ferite, delle mie ossessioni, dei miei disturbi e via di seguito, perfino delle mie fantasie e della mia violenza, suppongo, come se il mio rapporto con Morrissey fosse univoco, come se lui non c’entrasse con me e con la mia “malattia”, se così vogliamo definirla.
Perché per voi il mio adorato Moz non è altro che l’ennesima popstar degli anni Ottanta, una miscela tra Frank Sinatra, Elvis Preasley, John Lennon e chissà chi altro, niente di unico o di trascendentale; non avete l’aria molto sveglia, musicalmente parlando. Quando vi ho chiesto se lo conoscevate sapevo che avreste risposto di no, o comunque che avreste nicchiato, magari fingendo di averne ascoltato una canzone o due, per entrare nelle mie grazie. Ma quando ho ribattuto, seria: “Morrissey potrebbe salvarvi la vita”, non avreste dovuto fare quei sorrisetti, o miei inquisitori, come non dovreste trattarmi con condiscendenza in futuro, durante le nostre visite, altrimenti piuttosto che nelle mie grazie finirete dritto dritto nel mio odio, fra le mie vittime.
Non posso esserne certa, però credo che il mio primo incontro con Morrissey risalga al 1995, all’inverno dei miei tredici anni e all’uscita di Southpaw Grammar, il suo quinto album da solista. Ero solo una ragazzina, allora, eppure cominciavo già a dibattermi fra un’adolescenza solitaria e umiliante e dei sogni sediziosi e perversi, il corsivo è d’obbligo, frutto di giornate trascorse in biblioteca o sul letto, in contemplazione. Inutile dire che Morrissey ha vissuto qualcosa di simile, nella Manchester degli anni Settanta – “Sono nato a Manchester, nella Biblioteca centrale, sezione Crimine” –, fra poesie e solitudini, ossessioni e pioggia, e questo è uno dei fulcri del nostro rapporto. Un altro fulcro è la musica, o meglio la sua voce e le sue parole, le sue pose sul palco e nella vita; parlare di semplici canzoni sarebbe riduttivo, ingiusto.
D’un tratto infatti era come se qualcuno, un essere al tempo stesso adorabile e dannato e teneramente ribelle, si fosse infilato nella mia stanza e avesse cantato la mia solitudine, il mio splendore e la mia miseria umana, la mia incapacità di amare, di essere amata. Morrissey non mi prometteva scopate, fumo, droghe, vite su Marte o altre amenità, però sapeva cantare e soffrire con me, e mi bastava. I suoi versi struggenti e ambigui mi rivelavano che eravamo soli in un mondo senza speranze, e andava bene così; o andava e basta, il che era sufficiente. Avevo tredici e poi quattordici anni, quindici, sedici, diciassette, entravo nell’età adulta e nel terzo millennio sapendo che “the year 2000 won’t change anyone here, as each fabled promise flies so fast”, e tuttavia lui mi insegnava ad apprezzare il vuoto nelle mie tasche e nella mia vita, la mia solitudine e la mia noia, il mio disprezzo, i miei malumori, le mie scie di sangue nel gabinetto. In breve: Morrissey mi aiutava a vivere, mi dava un’identità e un uomo da amare, lui. Quando uscì Irish Blood, English Heart (“there’s no one on earth I’m afraid of…”) avevo ventiquattro anni, e mi risolsi di lasciare l’Italia e vederlo dal vivo, a Manchester, all’Arena, e fu uno spettacolo indimenticabile, non ci sono altre parole per definirlo.
La folla mi sbatteva fra transenne e gomiti e braccia protese verso di lui, sul palco, ritto e immenso nella sua camicia bianca, irreale eppure vero, alto, deciso, luminoso, in carne e ossa e jeans e ciuffo ribelle, mentre agitava il filo del microfono o passeggiava fra le note, guardandomi dritto negli occhi, cantando per me. Soltanto una persona al mondo può capire l’importanza fisica di Morrissey, per i suoi fan – ed è Morrissey stesso. Morrissey, che diceva: “Ammiro coloro che raggiungono importanti traguardi artistici dopo aver subìto ripetute fustigazioni pubbliche, dopo essere stati arsi vivi dai critici e aver visto numerose porte chiudersi loro in faccia. Mi piace quando raggiungono il vertice, sorridendo, controllati, incrollabili. Di quegli esempi, secondo me, bisogna far tesoro”. Ecco: io facevo tesoro di Moz da anni e anni, e quella sera, dopo l’epica There Is a Light That Never Goes Out, nel darkened underpass mi feci coraggio e decisi di offrirgli il mio corpo, la mia mente e le mie paure, tutto ciò che possedevo. Decisi di non vivere più se non in Morrissey, per Morrissey. Decisi di trasformarlo in una religione.
A essere precisi, temo che “decidere” non sia il verbo corretto. Non ho difficoltà ad ammetterlo: il mio stato psichico era talmente fragile da annullare ogni mia volontà, ogni mio pensiero; non avevo (non ho) un lavoro, una famiglia, un ragazzo, degli affetti o delle foto da appendere e delle date da ricordare; non avevo una vita, niente. Mio fratello, l’unico parente che valga la pena di nominare in questa sede, se non altro per l’odio che quell’infame piccolo stronzetto ha saputo smuovere dentro di me, si rifiutava di rivolgermi la parola o persino di guardarmi, considerandomi un’isterica asessuata e una ritardata mentale, o forse una contendente per l’eredità, non so. Non che me ne importasse granché: lo vedevo a stento, non uscendo mai dalla mia stanza e prolungando l’adolescenza all’infinito, ascoltando e riascoltando gli Smiths e Morrissey a volume altissimo, di giorno, di notte, nutrendomi tanto di amore: “Learn to love me, assemble the ways…”; quanto di odio: “I praise the day that brings you pain…”.
In effetti l’odio mi aiutava a fortificare la mia solitudine, dando un alibi al mio rifiuto di vivere, di essere. Ancora oggi mi capita di riprendermi dalle depressioni attraverso di esso, attraverso l’odio, disprezzando i padri, le madri, i figli, i rapporti, gli amori, il sesso, gli esseri viventi e tutto il patatrac umano, escludendo solo Morrissey e il suo ciuffo, naturalmente, e comprendendo me. A questo punto vi starete chiedendo: perché non la fa finita, se odia talmente la vita e l’umanità? Perché non congedarsi elegantemente dal mondo, con una corda al collo e un salto nel vuoto? Innanzitutto mi dispiace informarvi che al riguardo voi non avete nessuna voce in capitolo, o miei inquisitori, non sapendo cosa sia la solitudine, come tutti. Cioè, non nego che nel corso delle vostre esistenze possiate sentirvi vagamente “soli” e “disperati”, a tratti, e tuttavia la solitudine è un’altra cosa, credetemi, è un’esperienza terribile e affascinante, da cui non si torna indietro. In qualche modo è simile a quelle macchie che mi mostrano qui dentro, ai disegni multistabili: li guardi e ti sembrano qualcosa, poi stringi gli occhi e diventano qualcos’altro, li fissi con più attenzione e si trasformano ancora, e così via, all’infinito, fino a ossessionarti e trascinarti dentro di loro, nella solitudine, che è una macchia ambigua.
Farla finita non è una soluzione, non sempre, e comunque non è affatto semplice o scontato come può sembrare, da fuori. D’altronde voi non capirete mai nulla di tutto questo, non con i vostri affetti e le vostre fedi al dito, non vivendo le vostre vite. Voi credete di essere e perciò non siete, non sarete mai, non siete mai stati. Voi non siete nemmeno capaci di fissare una parete senza sentire niente, niente oltre alla parete stessa, all’atroce fissità del suo essere lì e non altrove, per sempre, anche dopo di voi e dopo di me, anche dopo Morrissey. Ma sto complicando un po’ le cose, e in fin dei conti non devo dimenticare che siete soltanto degli impiegati, dei servi, degli schizzi di merda nel secchio merdoso in cui mi agito, e che umiliarvi o distruggervi è troppo facile, o miei inquisitori. Meglio tornare a Manchester, al M.E.N. Arena.
Quel concerto ha cambiato la mia vita, dunque. Tornata a Roma, per la prima volta ero in grado di uscire dalla mia stanza e aprirmi al mondo, seppure solo virtualmente, cercando adepti e complici fra i vari siti Internet e forum dedicati a Morrissey. Avevo sottovalutato l’importanza e le potenzialità della Rete: nel giro di un mese selezionai una ventina di chitarristi e batteristi falliti e procedetti per eliminatorie, fino a lasciarne tre, ossia i sosia di Johnny Marr, di Andy Rourke e di Mike Joyce, gli altri componenti degli Smiths. Il mio Johnny era un po’ più alto e brufoloso dell’originale, però faceva degli ottimi arpeggi e dalla platea era fotogenico; quanto a Rourke e a Joyce, sarebbero rimasti in fondo al palco, all’ombra, oscurati dalla vera stella della band, ovvero me, Morrissey – o meglio: una Morrissey in gonnella, con calze nere e scarpette bianche. Le cose cominciarono subito a prendere forma, a evolvere, senza grandi sforzi da parte mia. Johnny aveva qualche conoscenza nel giro underground romano, e riuscì a organizzare una quindicina di serate in locali umidi e claustrofobici, fra Testaccio e la Prenestina. Il gruppo si chiamava gli Unruly boys, dai versi: “Unruly boys / Who will not grow up / Must be taken in hand”, e si dedicava esclusivamente a cover degli Smiths, imitandoli in ogni dettaglio, dalle posizioni sul palco ai vestiti, al look.
Il pubblico si divideva fra appassionati degli Smiths e spettatori casuali e un po’ annoiati, ma in genere applaudivano tutti, per pietà o per educazione. Non che facessi caso ai loro applausi, però, presa com’ero dal mio show e dalle schitarrate di Johnny. Vivevo i concerti in trance, come se fossi ancora rinchiusa nella mia stanza, da sola, protetta dalle pareti e dai poster di Moz, imitando la sua voce calda e sensuale o i suoi falsetti ironici, le sue pose. Non ero né timida né impaurita, o miei inquisitori – ero Morrissey, semplicemente, pure lontano dal palco, nel rapporto con Johnny e gli altri. Quando uscivano per rimorchiare qualche ragazza, mettevo su un broncio altezzoso e mi rifugiavo nelle opere di Oscar Wilde, disprezzandoli silenziosamente. Quanto al veganismo e a Meat Is Murder, mi capitava di affacciarmi nelle macellerie e nei fast food e dare agli astanti delle teste di cazzo cannibali, e una sera finii addirittura per interrompere un concerto dopo pochi minuti, squadrando il pubblico e dichiarando, come Morrissey in California, al Coachella Festival del 2009: “Sento puzza di carne bruciata, e spero di cuore che sia carne umana”.
Nelle conversazioni invece tiravo fuori frasi del tipo: “Sono sempre stato attirata da persone con i miei stessi problemi, e non è d’aiuto quando la maggior parte di loro sono morte”, oppure: “Ho sempre dovuto ridere di me stessa: se non avessi trovato la mia condizione sociale da adolescente così ridicola, mi sarei impiccata”, o ancora, sempre parafrasando Morrissey, rivolta a tizi che tentavano di invitarmi a cena, illusi: “Se tu avessi vissuto la mia vita per cinque minuti, ti saresti strangolato con il primo pezzo di corda a portata di mano”. Inutile dire che Johnny e gli altri mi trovavano insopportabile, odiosa. Quando, dopo il concerto interrotto, Andy e Mike mi dissero che ero una pazza isterica, ribattei che in realtà loro non erano dei veri fan degli Smiths, e che quindi non avevano il diritto di ascoltarli e di suonarli. Dopodiché puntai il dito contro Mike, rabbiosa, aggiungendo lentamente: “You pleaded and squealed, and you think you’ve won, but sorrow will come to you in the end…”, e chi ha orecchie per intendere intenda – non certo voi, o miei inquisitori.
Comunque quel litigio sancì l’inizio della fine, per gli Unruly boys. Poco tempo dopo qualche idiota pubblicò le nostre esibizioni su Internet, con un audio distorto e delle riprese traballanti, e centinaia di commentatori e presunti fan di Moz cominciarono a sfottermi e a insultarmi, dandomi della “fallita-senza-speranza”, della “cozza”. Li capivo, d’altronde: cliccavano sul link di This Charmig man o di I know it’s over e incappavano in uno dei nostri miseri concertini, non nei live degli Smiths o di Morrissey. Sul palco lo imitavo discretamente, d’accordo, però nello schermo era tutta un’altra cosa, e il vero Moz è inarrivabile, me ne rendo conto. Una sera di depressione e di noia, naufragando su Internet, mattatoio mentale della mia stanza e della mia vita, giunsi persino a insultare la mia stessa esibizione, come per liberarmene. MA CHI SONO QUESTE MERDE?, scrissi, con un profilo anonimo, e giù risate e altri insulti, e in quel momento, odiandomi, decisi di non cantare più, se non da sola e nella mia stanza, come prima. L’esperienza degli Unruly boys era finita, mi dissi, come quella degli Smiths nel 1987. Era giunto il momento di diventare solista.
Silenzio. In sottofondo si sente il ritornello di Everyday is like sunday, mentre le luci calano di intensità e il palco si ingrigisce. Finora nel corso del monologo si sono alternati il silenzio e le prime note di alcune canzoni, fra accordi briosi, incalzanti o malinconici (This charmig man, Nowhere fast, This night has opened my eyes) e marce funebri (Sorrow will come in the end). La donna parla a tratti in tono monocorde e a tratti ravvivandosi, passeggiando sul palco e sul proscenio, fra il bianco e il nero – che l’attrice sia libera di muoversi, di dare un corpo al testo. Adesso lascia cadere la penna e danza fra le sedie rovesciate, in penombra, spostando l’ultima sul proscenio, raddrizzandola e sedendosi. Per qualche secondo chiude gli occhi e si passa le mani sul corpo, sempre al ritmo di Everyday is like sunday, in estasi, librandosi alla musica; dopodiché le note sfumano e lei si raddrizza e si guarda attorno, come risvegliandosi. Tutto tace. Il palcoscenico è in gran parte invisibile, tra il grigio e il nero, ma dopo un po’ le sedie e il tavolo si illuminano di nuovo, e torna il bianco. La donna ricomincia a parlare.
Viva Hate è il primo disco solista di Morrissey, un passo difficile e riuscitissimo, con capolavori quali Suedehead e Everyday Is Like Sunday, la mia preferita. Molti critici lo avevano dato per spacciato dopo la separazione da Johnny Marr, e invece lui tira fuori una sfilza di singoli indimenticabili e balza in cima alle classifiche, che mito. La forza di Moz, e di conseguenza anche la mia, risiede nel suo puro e inestinguibile talento, che gli permette di fare e dire ciò che vuole, mandando al diavolo regine, politici, case discografiche, presentatori televisivi e via di seguito. Analogamente, o miei inquisitori, io potevo e posso permettermi di fare ciò che ho fatto, non in nome mio ma nel nome di Morrissey, per onorare il suo talento. Non volendo più cantare in pubblico, dovevo provare qualcos’altro: un omaggio estetico, unico, un gesto degno di Suedehead o di Meat Is Murder – capite?
“Murder”, appunto. La mia prima vittima si chiamava Giampiero Antoni, un omone di due metri, calvo e baffuto, nato nel 1958 e sposato con Olga Antoni, una cicciona in grembiule bianco, per giunta barese o napoletana, la mia seconda vittima. Gestivano una macelleria nella periferia di Ladispoli, affettando continuamente manzi, vitelli, mucche, polli e via dicendo, uno schifo immondo. Non so se i carnivori vi disgustino quanto a me e a Morrissey, o miei inquisitori, ma vi assicuro che c’è qualcosa di terribile in un uomo che infila quotidianamente la lama nei resti di un cerbiatto o di una gallina; è un gesto inumano, atroce. Morrissey dice: “Restiamo violentemente turbati quando gli animali mangiano gli uomini, è orribile, è terrificante. Ma allora perché non dovremmo provare orrore quando gli uomini mangiano gli animali?”. D’altra parte vi garantisco che i corpi dei coniugi Antoni erano infinitamente più ributtanti e fetidi delle carni indifese che tritavano e affettavano ogni mattina; quei bastardi meritavano di morire, per quel che mi riguarda. Quanto alle descrizioni e al sangue, non ricordo bene ciò che accadde durante e dopo la carneficina, però non credo di aver perso la testa o di essere andata in panico, nossignori, malgrado le viscere sparse per terra e le fette di vitello e pollo allineate sul banco. Devo aver abbassato la serranda della macelleria, trascinato i cadaveri nel retro e lavato il pavimento, salvando le apparenze – così immaginate la “scena del delitto”, giusto? Poi sono tornata a casa e ho messo su una canzone di Morrissey, anche se non saprei dire quale, o miei inquisitori. È probabile che volessi riposarmi, dormire, e dunque propenderei per Suffer, suffer, little children, pezzo ambiguo e tragico, adatto sia a un pisolino che a un massacro, a seconda del bisogno. Ma non posso dirlo con certezza.
Posso rivelarvi di aver ucciso ancora, in compenso. Era un’estate rovente e silenziosa, da film western, con le strade deserte e le case vuote, e io e Moz non resistemmo alla tentazione e ci demmo dentro per una settimana, tutti i giorni. Dopo la prima vittima si scopre che uccidere un altro essere umano è relativamente semplice, purché non si abbiano ostacoli psichici o morali, e noi non ne avevamo. Fino ad allora i macellai romani avevano avuto vita facile, sterminando migliaia di polli e mucche impunemente; nel giro di pochi giorni ne giustiziammo sei, uno dietro l’altro, e fu una vera goduria, una liberazione. Sceglievo la macelleria giusta, mi infilavo le cuffie nelle orecchie, entravo e ordinavo mezzo chilo di manzo, al ritmo di Meat Is Murder o di Death at One’s Elbow, aspettando il momento più propizio, calma, pronta a girare intorno al bancone e sorprendere il bastardo alle spalle, zac, una coltellata alla gola, zac zac, un paio al fianco, zac, un fendente al petto, eccetera, sempre ascoltando Morrissey, obbedendo alla sua voce. (Dicendo questo raccoglie la penna e la brandisce a mezz’aria, a mo’ di coltello, per poi scagliarla fra il pubblico, nel nero – ora la penna è scomparsa.) Nessuno sospetta di una donna sola, fragile e disperata, per fortuna; nessuno sospetta di una donna, e basta.
Di sera, a casa, ero sfinita e confusa, e qualche volta sentivo persino il bisogno di mettere a tacere Moz e sdraiarmi sul letto, in silenzio, fissando il soffitto e il vuoto, sperando di addormentarmi. Durante il sonno però le coltellate e gli schizzi di sangue mi svegliavano di continuo, di colpo, più e più volte, affascinandomi e terrorizzandomi al tempo stesso, e tuttavia la mattina seguente stavo bene, e nel pomeriggio uccidevo ancora. Di quando in quando, fra macellai e pisolini, incrociavo mio fratello sulle scale o in cucina, sempre con Morrissey nelle orecchie, eppure lui non si accorgeva di nulla, guardandomi a malapena. Mio fratello è sempre stato freddo nei miei confronti, scostante, maligno, stronzo oltre ogni dire. Dopo la morte dei nostri genitori, che per inciso non ha niente a che fare con questa storia, abbiamo condiviso la casa per cinque anni, senza mai rivolgerci la parola, ognuno nel suo territorio e seguendo regole ben precise, dal divieto di mangiare carne agli orari del bagno, della lavatrice, della lavastoviglie, dei fornelli e della tivù. Non mi ha mai voluto bene, né io ne ho voluto a lui. Il tempo ci ha reso estranei l’uno dall’altra, suppongo, due tizi che vivono nella stessa casa e si disprezzano vicendevolmente, per litigi ormai dimenticati. Aggiungo questi dettagli perché in seguito avranno un certo peso nella vicenda, o miei inquisitori – se non fosse per quello stronzetto, non sarei qui.
Ma torniamo ai cadaveri. Il vero problema era il rumore, le urla dei corpi grondanti di sangue e già spacciati, senza speranze di sopravvivenza, le bocche che emettevano urla strazianti e si infilavano fra me e Morrissey, nelle cuffie, rovinando la scena, maledizione. Non capisco perché gli esseri umani accolgano la morte con terrore, visto che li strappa da una vita di merda. Tra l’altro le grida mi facevano infliggere coltellate più profonde, ripetute, rabbiose, cruente, fino a farli tacere e a rendere i loro corpi un ammasso di sangue e viscere – ecco cosa vedo in quei dannati disegni: sangue, viscere, coltellate, odio. L’unico macellaio ad averla scampata, a pensarci, è stato il meno rumoroso di tutti, l’ultimo. Dopo un fendente era già a terra, muto e immobile, come stecchito, per furbizia o per uno svenimento, non so. Lo trascinai nel retro senza problemi, convinta che fosse morto e lieta di aver fatto un lavoro pulito, danzando con Morrissey, canticchiando con lui. Peccato che il giorno seguente la macelleria abbia aperto alla solita ora, senza polizia né niente del genere, e che il macellaio, un nanetto muscoloso e tatuato, mi abbia squadrata dalla vetrina, sfidandomi a riprovarci. Lì per lì me la feci sotto – come era possibile? Tornai a casa d’istinto, senza pensare, presi il coltello e scesi di nuovo, fino alla macelleria. Rimasi sul marciapiede per diversi minuti, all’erta, con la mano tremante. Avevo paura. Cosa mi aspettava, lì dentro? Se il nanetto era sopravvissuto alla prima coltellata, non poteva sopravvivere anche alla seconda, alla terza e così via? Ero in grado di ucciderlo, con tutti quei muscoli e quei tatuaggi? Di più: e se mi avesse teso un agguato, alleandosi con altri macellai? Mentre mi tormentavo con questi dubbi, lui continuava a gettarmi le sue occhiate nanesche da dietro il bancone, sventrando un vitello e sorridendo, irridendomi, sicuro di sé, pronto a difendersi e a uccidere, a uccidermi. Non ebbi il coraggio di infilarmi Morrissey nelle orecchie, quella volta. Non volli renderlo complice della mia paura, della mia resa, e così tornai a casa e mi misi a letto, fissando il soffitto fino a sera, quando mi addormentai. Feci incubi che non ricordo.
Il giorno dopo andai un po’ in confusione, temo. Dapprima pensai di tornare dal macellaio e farlo fuori in quattro e quattr’otto, zac zac zac, ma poi decisi di lasciar perdere le macellerie per qualche giorno, prudentemente. Uscii di casa con le cuffie nelle orecchie, decisa a passeggiare e basta, al massimo di visitare il cimitero del Verano al ritmo di Cemetry Gates, un capolavoro. Ma proprio mentre varcavo il cancello e mi infilavo in un corridoio di lapidi e di erbacce, Cemetry Gates finì e cominciò la traccia successiva dell’album, la cruenta Bigmouth Strikes Again: “Sweetness, sweetness, I was only joking, when I said I’d like to smash every tooth in your head…”, e all’improvviso spuntò fuori un cinese di una dozzina d’anni, un ragazzino tutto pelle e ossa, con dei fiori in mano. Voleva vendermeli, regalarmeli, procurarsi qualche spicciolo, infiorettare la mia vita. Il suo corpo dovrebbe essere ancora fra le tombe e le erbacce, o miei inquisitori, anche se stavolta il pensiero mi disturba, perché non avrei dovuto ucciderlo. Morrissey non è razzista, infatti. Gli ambigui versi di Bengali Platforms – “Oh, shelve your Western plans and understand / that life is hard enough when you belong here” – si rivolgono più alla miseria dell’Inghilterra che ai bengalesi, e comunque sono inclusi nell’album Viva Hate, viva l’odio, e quindi necessari, mi pare. Tra l’altro definire The National Front Disco un pezzo fascista, come fece a suo tempo la NME, è semplicemente da idioti; si tratta di arte, e il fascistello della canzone è soltanto una musa, come in Sweet Tender Hooligan. D’altro canto Morrissey ha chiuso il discorso sul suo presunto razzismo nell’album You Are the Quarry, del 2004: “I’ve been dreaming of a time when to be English is not to be baneful, to be standing by the flag not feeling shameful, racist or partial…”. È anche vero che di lì a poco avrebbe definito i cinesi una sottospecie, però nelle interviste il Moz è sempre il Moz, e comunque i musi gialli trattano gli animali come bestie, o miei inquisitori, e se lo meritano.
Ad ogni modo, sottospecie o meno che fosse, non dovevo sgozzare quel ragazzino, Morrissey non avrebbe approvato. Mi allontanai dal cimitero stordita, sudata, ascoltando Panic e dicendomi di aver commesso un errore, un delitto, e di non poter tornare indietro. Non so se vi è mai capitato di pentirvi davvero di qualcosa, di compiere un gesto terribile e irrimediabile e rivivere gli stessi istanti all’infinito, lo stesso orrore, la gola squarciata e sprizzante sangue di un bambino e i suoi lamenti gutturali, mostruosi, eterni. Avevo già ucciso diverse persone, ma per la prima volta provavo qualcosa, ed era tremendo. Riattraversai la città pensando di farla finita al più presto, subito, corteggiando la ventata della metropolitana e cadendo fra i binari, sotto il treno, lasciandomi travolgere.
Ma non lo feci, e a poco a poco Morrissey ebbe la meglio, salvandomi e trascinandomi via con sé, nella sua voce, addirittura perdonandomi – “Don’t rake up my mistakes, I know exactly what they are…” – e forse lodandomi, in fondo quel cinesino era per lui, una vittima sacrificale. Giunsi al mio palazzo ancora zuppa di sudore, però più calma. L’avevo scampata. Uccidere quel ragazzino era stato atroce, d’accordo, e tuttavia Moz poteva permettersi tutto, e io con lui. Entrai nell’ascensore al ritmo selvaggio di Barbarism Begins at Home, ballando davanti allo specchio, salii al mio piano, aprii la porta e d’un tratto mi imbattei nel mio vicino di casa, cosa rarissima, un giudice o avvocato in pensione, che non usciva mai. Mi guardò a lungo negli occhi, come se sapesse, condannandomi, e allora mi feci avanti e uccisi di nuovo, “Oh, you handsome devil”. Successe tutto per caso, o miei inquisitori, come se fossi uscita dall’ascensore sbagliato – “È successo tutto per caso, sono uscito dall’ascensore sbagliato”: Morrissey nel 1987, a proposito della sua vita –, e di colpo mi ritrovai con il cadavere di un vecchio fra le braccia, davanti casa.
Lo portai dentro; che altro potevo fare? Lo trascinai lungo il corridoio e lo appoggiai contro il divano, seduto, con le gambe allungate sul pavimento. La testa gli dondolava da un lato e dall’altro, flaccida e senza vita, ma a parte questo sembrava un barbone come tanti, non un cadavere. Gli rovesciai il capo all’indietro e lo guardai dritto negli occhi, due occhi spalancati e vitrei, e sul momento, ricordando il suo sguardo d’accusa di poco prima, provai un vago senso di rimorso e irrimediabilità, come per il cinesino. D’altro canto bisogna dire che nessuno dei due aveva fatto granché per restare in vita, lasciando che il coltello gli squarciasse la gola e il ventre da parte a parte, senza dibattersi. A volte ho l’impressione che sia colpa loro, delle vittime, come se volessero essere uccise, usandoci e ossessionandoci, o miei inquisitori.
Comunque restai a lungo accasciata per terra, con Morrissey che mi gridava nelle orecchie e in una pozza di sangue, come vegliando il vecchio. Ero a pezzi, sfinita. Quando vidi accendersi le luci del corridoio non provai nulla di particolare, se non lo stupore che fuori fosse già notte e che Morrissey non cantasse più, e quando mio fratello si affacciò nel salotto e cacciò un grido di orrore non dissi una parola, distogliendo lo sguardo. Lui si avvicinò e si piegò sul vecchio, a pochi centimetri dal mio volto, raddrizzandogli le spalle contro il divano e tenendogli su la testa, spruzzando sangue tutt’intorno. “Ma è… il vicino di casa” fece. “È il vicino di casa! Cosa – cosa gli è successo?”
Cosa gli era successo? Non era ovvio? Mio fratello spostava lo sguardo da me al cadavere e viceversa, senza capire, come non aveva mai capito niente di me e della mia vita, della mia estetica, continuando a reggere la fronte di quel vecchiaccio immondo, che conosceva a stento. E tuttavia, grazie a quel gesto, all’improvviso provai qualcosa nei suoi confronti, una specie di tenerezza. “Cosa – cosa gli è successo?” ripeteva, tentando invano di rianimare il vecchio eppure rivolto a me, rivolto a sua sorella. E per un istante mi resi conto di potergli voler bene, riconobbi questa possibilità. Per un lunghissimo, inconcepibile istante mi resi conto che il sangue significa qualcosa, in più di un senso, e che io e mio fratello avevamo sbagliato tutto, rovinando le nostre vite.
Lui gridava: “Non si muove, è morto, cosa possiamo fare, cosa faremo?”, e io pensavo a quel “noi” e mi chiedevo perché non mi avesse parlato per anni – perché? O ero io a non aver più parlato a lui – ma perché, ancora? E di colpo ogni rapporto umano mi parve tragico e terrificante e scattai in piedi, come ribellandomi, e ora mi chiedo perché lui mi abbia urlato quelle parole, mentre gli saltavo addosso e lo pugnalavo al petto, al cuore; mi chiedo perché abbia urlato: “Fermati, Amelia! Fermati! Sono io!”, e se abbia provato amore, odio, confusione, paura – o se non abbia provato niente, come non provo niente io.
Io. Lui. Fermati, Amelia, fermati. Amelia, o miei inquisitori. I rapporti umani sono tragici e terrificanti, però non ci resta altro, se non musica e terrore, solitudine e pareti bianche. Ci ho messo un po’ a capirlo, e ormai ho sprecato la mia vita. Quando mio fratello smise di gridare il mio nome, mi fermai. Tutto taceva. Spensi le luci (le luci si spengono anche sul palcoscenico, una dopo l’altra, accompagnando la sua voce; Amelia si accascia fra le sedie, in penombra) e mi accovacciai fra i cadaveri, nel sangue, cercando di morire a mia volta, di non muovermi né respirare. Ma non ne ero capace. Non… ci riesco. D’altra parte anche Morrissey è rimasto in vita, quindi non è colpa mia. Non posso farla finita, non ancora – non finché lui è vivo e canta. Dovrò restare qui a lungo, fra queste pareti nere, buie, come il mondo che vi circonda, come le mie parole. Continuerò a vivere e a odiare. Abbiate pietà di me.
Sipario.
Live di Morrissey
L’autore
Edoardo Pisani è nato a Gorizia nel 1988 e ha vissuto a Buenos Aires, Riccione e Roma. Ha tradotto e curato testi per alcune riviste e nel 2011 è stato selezionato per Scritture giovani cantiere, del festival di Mantova. Per il momento scrive e lavora a Roma, con goWare ha pubblicato il pamphlet Vomitando il Novecento.