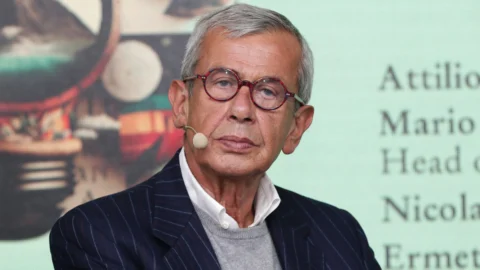Ancora poche settimane prima che scoppiassero le prime rivolte in Tunisia il Fondo monetario internazionale aveva pubblicato un rapporto nel quale si mostrava quanto i paesi del Nord Africa e Medio Oriente (Mena) avessero superato agevolmente la crisi economica finanziaria. Nel 2010 l’economia egiziana e siriana erano cresciute a tassi superiori al 5%, mentre quella tunisina e marocchina avevano sfiorato il 4%, quasi il doppio della crescita americana e soprattutto europea. Così il tasso di disoccupazione di molti paesi arabi importatori di petrolio stava calando, seppure lentamente, dai valori alti, tradizionalmente osservati. La risalita dei prezzi del petrolio, che alla fine dell’anno aveva sfiorato i 100 USD al barile, rendevano poi eccellenti le prospettive di sviluppo dei paesi del Golfo, che dipendono in maniera rilevantissima delle quotazioni del greggio. Certo l’aumento dei prezzi delle derrate agricole, superiore al 30%, sollevava qualche preoccupazione, ma la rete di sussidi messa in piedi risultava più che sostenibile da bilanci pubblici e riserve ufficiali confortevoli.
Anche da un punto di vista politico la situazione appariva apparentemente relativamente tranquilla. In Egitto nel novembre del 2010 le elezioni parlamentari avevano assegnato al NDP di Mubarak una vittoria trionfale in un clima di incertezza circa le condizioni di salute del presidente e i soliti brogli elettorali. In Tunisia e Siria la posizione di Ben Ali e Assad appariva solida, mentre nello Yemen la vita politica era costellata dai soliti attentati, ma la posizione di Saleh non veniva messa in discussione da nessuno, anche perché incondizionatamente appoggiata dei sauditi.
Eppure un ritardo nello sviluppo socio-economico dell’area si poteva registrare già allora. E alla base di questa arretratezza c’è, a nostro avviso, la scarsa apertura al resto del mondo ed un modello di sviluppo più basato sull’import-substitution che sull’export-led. In questo modo i paesi Mena non hanno saputo approfittare del processo di globalizzazione che ha interessato il pianeta negli ultimi decenni e che ha giocato un ruolo fondamentale nel determinare la straordinaria crescita dei paesi asiatici.
Negli ultimi trenta anni molti paesi del globo hanno conosciuto un’evoluzione in senso democratico, grazie alla caduta dell’impero sovietico, alla fine di molti regimi militari dell’America Latina e allo sbriciolarsi di numerose dittature asiatiche. Il Medio Oriente, da questo punto di vista, non ha affatto conosciuto una simile evoluzione e rappresenta, sotto questo aspetto, una deprecabile eccezione. La longevità dei governi non è altro che un indicatore della sclerosi politica.
Come si spiega un simile ritardo? Esiste un’ampia evidenza empirica che mostra come i paesi più ricchi tendono ad essere più democratici e meno raramente si trasformano in dittature autoritarie. Questa è la cosiddetta “teoria della modernizzazione”, che trova le sue radici nei filosofi illuministi del XVIII secolo. Ovviamente non si tratta di una relazione deterministica giacché molti altri fattori influenzano sia lo sviluppo economico che il regime politico di un paese. Dal nostro punto di vista l’aspetto più interessante è che quasi tutti i paesi arabi sembrano avere superato la soglia di reddito ritenuta indispensabile allo sviluppo di istituzioni democratiche. Questo vale, ovviamente, sopratutto per i produttori di petrolio che hanno redditi procapite più alti.
In questi paesi trova ampia conferma quello che molti studiosi chiamano la maledizione dello stato rentier: bassa crescita economica, forte probabilità di guerre civili e scarsa propensione allo sviluppo di istituzioni democratiche. Né l’analisi teorico-dottrinale, né l’evidenza storica ed econometrica, da noi rivisitate, sembrano in grado di dare risposte definitive circa il contributo dell’Islam allo sviluppo economico-istituzionale. Sembrerebbe, invece, che i paesi islamici presentino situazioni socio-economiche alquanto differenziate e dipendenti, piuttosto, dall’area geografica di appartenenza. Tipico il caso dell’Indonesia, che è riuscita ad agganciarsi al carro delle tigri asiatiche, o quello della Turchia, che fortunatamente, mantiene ancora forti legami con l’Europa.
Negli ultimi anni la scienza economica e politica hanno anche mostrato come la frammentazione etnica, linguistica, culturale e religiosa possa essere un forte ostacolo al processo di crescita economica e alla creazione di istituzioni efficienti e democratiche. Sotto questa angolatura mostriamo come i paesi arabi siano molto meno omogenei di quanto possa apparire agli occhi di un occidentale. Questa forte eterogeneità dell’area sembra possa essere un fattore che contribuisce a spiegare lo scarso sviluppo economico e l’arretratezza delle istituzioni.
Tutto questo ci permette di costruire qualche scenario per il futuro. E’ soprattutto sul terreno macroeconomico che si giocherà la partita più importante nei prossimi anni. Se è vero che il principale problema dei paesi del nord Africa e del Medio Oriente è stato un modello di sviluppo troppo chiuso e poco propenso ad integrarsi con il resto del mondo, solo un diverso atteggiamento politico-culturale verso l’esterno potrà permettere alle economie dei paesi arabi di trovare il giusto ritmo di crescita. Questo è stato peraltro l’atteggiamento che ha accompagnato il mondo arabo nel momento del suo miglior splendore. Questo sarebbe anche la migliore vitamina per rafforzare i giovani germogli delle democrazie arabe.