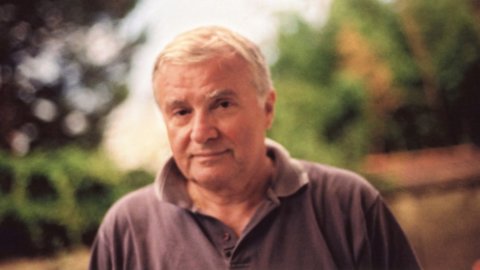Il buono ha vinto, il cattivo sta per essere cacciato, e tutto andrà per il meglio. “America is back”, come ha detto il buono, Joe Biden. E’ questa la percezione che molti europei e in particolare molti italiani hanno della situazione postelettorale americana. Ma non è così semplice. Non si sa quanto il buono riuscirà ad essere buono. Quello che molti europei considerano il cattivo, Donald Trump, è decisamente considerato da circa un terzo dell’elettorato il vero buono, o così dicono. Quale America is back?
Sono solo tre ormai le caselle ancora vuote del calendario che il 20 gennaio porterà all’insediamento di Joe Biden, in presenza o in assenza di un Donald Trump che si comporta ormai come un sovrano africano detronizzato da un golpe tribale.
Entro l’8 dicembre vanno conclusi i casi legali, una quarantina, tentati dagli avvocati personali di Trump in nome della sua campagna elettorale. Nei vari Stati la magistratura ne ha già rifiutato 39, perché senza prove credibili; resta in piedi in Wisconsin il tentativo più ambizioso, quello di far cancellare in blocco centinaia di migliaia di absentee ballots, voti per posta e simili, in quanto mancava una richiesta scritta per ottenere ogni singolo modulo. Ma il formulario generale che l’elettore ha dovuto compilare per ottenere la scheda dice chiaramente, in testata, anche “officil absentee ballot application/certification”.
Quindi è anche una richiesta di scheda per votare. Inoltre, passaggio cruciale, il ministro della Giustizia William P. Barr ha dichiarato il primo dicembre con grande irritazione di Trump che il suo ministero, incitato giorni prima dal presidente a scoprire insieme all’Fbi le frodi elettorali evidenti a suo dire in sei Stati, non ha trovato nulla “di dimensioni tali che avrebbe potuto portare a un risultato elettorale diverso”. Mentre Doug Ducey governatore repubblicano dell’Arizona, andata a Biden per 10.457 voti e contestata da Trump, ha tagliato corto dicendo “In Arizona facciamo bene le elezioni. Il sistema è forte”.
Il 14 dicembre, seconda tappa, si riuniscono nei rispettivi 50 Stati i grandi elettori del particolare sistema americano dell’electoral college, su cui in Europa spesso si hanno idee incomplete. Esiste il popular vote, il suffragio universale diretto, e l’electoral vote, espresso dai grandi elettori, persone scelte dalle assemblee legislative locali, alla fine. Il sistema prevede che ogni Stato abbia tanti grandi elettori quanti sono i suoi deputati alla Camera federale più i due senatori. Esiste da sempre (art.2, sez.1 della Costituzione) e funziona con le modalità attuali grossomodo dalla metà dell’800.
Ha un vantaggio, di impedire che i quattro o cinque Stati più popolosi scelgano il presidente con un voto popolare diretto; e uno svantaggio, quello di attribuire proporzionalmente più peso di quello che sarebbe il loro voto popolare diretto agli Stati meno popolosi, i meno abitati dei quali hanno comunque 3 voti elettorali (pari a un deputato e tre senatori). I grandi elettori votano il 14 e mandano i risultati, ancora segreti, al Congresso. Da circa 170 anni il mandato è chiaro: il grande elettore di 48 Stati dà il suo voto a chi ha vinto nello Stato la maggioranza dei voti popolari, mentre in due Stati (Nebraska e Maine) l’attribuzione avviene sulla base di chi ha vinto le presidenziali nei vari collegi per la Camera federale, 5 in Nebraska e 4 nel Maine.
Trump ha fatto pressione su varie assemblee statali a maggioranza repubblicana perché ribaltassero la prassi, e in particolare lo ha fatto con il Michigan, chiedendo che i grandi elettori di espressione repubblicana votassero comunque per lui ignorando la maggioranza di 157mila voti di Biden. “Non succederà – ha detto il leader repubblicano al Senato locale, Mike Shirkey – noi seguiremo la legge e seguiremo la prassi”.
Infine il 6 gennaio il Congresso conta i voti dei 538 grandi elettori e proclama ufficialmente il presidente degli Stati Uniti, che in base al voto alla legge e alla prassi sarebbe Joe Biden, con 306 voti elettorali contro i 232 di Trump. Il 20 gennaio finisce l’era Trump e il nuovo presidente giura e si insedia. Ci sono state però nelle ultime settimane cose mai viste. C’è prima di tutto una cifra da ricordare brevemente e poi ci sono due fatti pesanti su cui riflettere, fra cronaca e storia.
La cifra è quella dell’esiguità delle vittorie, in termini di electoral votes, e quindi della profonda divisione del Paese sulla scelta presidenziale. Ieri per Trump, che – sotto di quasi 3 milioni di voti nel suffragio popolare – vinse per un totale di 77mila voti popolari capaci di portargli l’electoral vote di tre Stati (Michigan, Pennsylvania e Wisconsin). Oggi per Biden al quale la vittoria sarebbe stata tolta se 44mila voti ottenuti complessivamente in tre Stati (Arizona, Wisconsin e Georgia, in totale 37 electoral votes) fossero mancati. In quel caso il risultato sarebbe stato 269 a 269 e la Camera, in base alle regole decise 130 anni fa, sarebbe stato l’arbitro di ultima istanza.
I democratici sono in maggioranza, sarà assai più esigua da gennaio perché hanno perso il 3 novembre una decina di seggi, ma il voto per scegliere il presidente non è pro capite ma pro Stato, ogni Stato un voto, le delegazioni a maggioranza repubblicana sono nell’attuale Camera 26 su 50, e Trump sarebbe uscito presidente. Tutto il suo irrefrenabile e maldestro attivismo, dal 4 novembre non sta facendo praticamente altro, punta a questo irraggiungibile obiettivo. Del resto già a settembre, in un comizio a Middletown, Pennsylvania, aveva parlato di questa soluzione, e ben prima del voto aveva preannunciato giganteschi brogli che ora vede.
“Il loro argomento fondamentale – ha detto sarcastico parlando del circolo Trump il superfalco repubblicano John R. Bolton, consigliere per la sicurezza nazionale scaricato l’anno scorso e autore di un libro sull’ignoranza irrimediabile del presidente – è che è stata una cospirazione così vasta e così fortunata da non lasciare traccia. Se è vero, vorrei davvero sapere chi l’ha diretta e realizzata. Vanno subito arruolati nella Cia”.
Nonostante il ridicolo ormai evidente per moltissimi, Trump manterrà comunque una fedele platea di molte decine di milioni di americani, già pronti da anni ad accogliere un messia come lui nella lotta del bene contro il male, e per questi sta parlando con freddo calcolo in modo così enfatico e falso. L’obiettivo è quello di mantenere una forte influenza su una parte decisiva degli elettori repubblicani, in modo che non vi sia competizione in cui Trump non sia l’arbitro, concedendo o negando l’appoggio dei suoi fedeli.
I parlamentari federali e locali a fine carriera, o sicuri del proprio elettorato, potranno prendere le distanze, anche se pochi lo fanno prima delle due supplettive in Georgia, il 5 gennaio, che potrebbero determinare la maggioranza in Senato. Quelli invece in collegi meno sicuri staranno ben attenti a non inimicarsi i Trump boys e a non attirare i fulmini dell’ex presidente diventato pontefice della alternate reality, la “vera” verità concetto fondamentale dell’iperpopulismo rampante rilanciato dalla negazione dei risultati elettorali.
Micidiali sono i 46 minuti di un soliloquio dalla Casa Bianca, diffuso dal presidente via Facebook il 2 dicembre, “il più importante discorso probabilmente che io ho mai fatto”. Si erge a garante della legalità, per cui mai potrà accettare il verdetto di un voto “fraudolento”. Trump e volenterosi alleati come gli avvocati Sidney Powell e Lin Wood, così estremi che persino l’entourage di Trump ha preso qualche distanza, stanno preparando un clima che ha confronti solo con il maccartismo, la caccia alle streghe, comuniste, liberal e di altro tipo, lanciato dal senatore repubblicano Joe McCarthy e silurato poi dai suoi eccessi, dal Congresso e dal presidente Eisenhower, ma dopo una dura battaglia, perché McCarthy piaceva a molti americani.
“E’ il momento di alzarsi e farsi contare” ha detto il Segretario di Stato della Georgia, Brad Raffensperger, la bestia nera dei trumpisti perché, repubblicano e in passato sostenitore di Trump, ha certificato la correttezza del voto nel suo Stato. “Con chi stai, con la legge e la correttezza, o con la folla selvaggia?” ha detto, ricordando di essere stato sollecitato a trasgredire la legge, a farlo per far giungere Trump a quota 270 voti elettorali o a dare una mano per portare la decisione finale alla Camera. “Signor Presidente, qui si rischiano dei morti” ha detto Gabriel Sterling, uno dei suoi principali collaboratori, repubblicano, ricordando le gravi minacce anonime a Raffensperger e a lui stesso. La risposta è stata il citato soliloquio di 46 minuti. Mai prima d’ora si era arrivati a un Bokassa sulle sponde del Potomac.
Non è stato Trump a inventare questa psicologia malata del complotto e del “noi” contro “loro”, l’ha solo abilmente cavalcata, e senza scrupoli. In America c’era e c’è una parte del Paese che ha accettato i vantaggi della nuova America inaugurata dal New Deal e dal periodo postbellico ma non ne ha mai accettato le responsabilità, considerate legacci fastidiosi, sia all’interno che sulla scena internazionale. Se si prendono i 27 milioni di voti avuti da Barry Goldwater come candidato repubblicani nel 1964, a fronte dei 43 milioni di Lyndon Johnson, si ha un’idea del peso storico nell’America contemporanea di questa destra, discendente diretta di quella di inizio 900. Goldwater vinse solo nel Deep South, l’area alienata retaggio della Guerra Civile, oltre che nel suo Stato dell’Arizona, di cui era apprezzato senatore.
L’alienazione, con in più forti dosi di populismo che a Goldwater in gran parte mancavano, hanno portato a Trump. Il suo precursore diretto, l’ex deputato Newton Gingrich, poi presidente della Camera, a partire dagli anni 80 ebbe un ruolo chiave nel cambiare stile e uomini del partito repubblicano, con guerre senza quartiere ai democratici stile alla iugulare e ostracismo ai repubblicani moderati, i RINO, republicans in name only. “Come si farebbe la transizione dal suo linguaggio da scuole elementari a una vera politica non lo so”, diceva Gingrich di Trump nel febbraio 2016, prima di cercare mesi dopo di candidarsi come suo vicepresidente. “E’ un orso grizzly nella sala. Non è normale”. Oggi Gingrich è un forte sostenitore di Trump, anche se da qualche giorno non batte più il tasto della frode elettorale.
Trump non mollerà la presa, anche fuori dalla Casa Bianca. Primo perché ha grossi problemi di liquidità nei suoi affari e ha bisogno di un ruolo pubblico. Poi perché c’è la base, una base irrobustita dalle paure di impoverimento che anche negli Stati Uniti avanzano e non da oggi, e dalla totale volontà di attribuire la colpa di questo a un complotto, nazionale e internazionale. Per questa cultura politica, che ripetiamo non è nuova, tutto quello che non piace è un complotto. Nelle lettere al fratello Ike, Edgar Eisenhower, legato ad ambienti molto conservatori e in particolare al petroliere Haroldson L. Hunt, lamentava che non venisse molto ridimensionata l’eredità del New Deal e si perseguisse una politica interna ed estera troppo simile a quella del predecessore democratico, Harry Truman, e quindi a quella di Roosevelt.
Il presidente rispondeva che non si poteva andare contro il sentire dei tempi, che provassero a togliere la pensione pubblica, l’assicurazione disoccupati e altre strutture sociali e avrebbero visto la reazione, e ricordava che a chiedere questo erano in pochi e in genere “stupidi”. Nessuno vuole toglierle oggi, anzi, ma la generica e ora rabbiosa insoddisfazione, alimentata dalla divaricazione economico-sociale fra ceti urbani e rurali, fra periferie e centro, fra le due coste e i fly-over States, ha prodotto Trump e ora Trump la sta esasperando, con risultati probabilmente gravi, e il voto del 2020 ha il grande risultato di cacciarlo dalla casa Bianca, ma non molto di più.
Joe Biden, che appartiene a un’altra America e non solo perché ha 78 anni (anche Trump, di poco meno anziano, è della sua leva), non ha ampi spazi. Per prima cosa deve disinnescare la bomba Trump, e ha ammesso nella sua prima intervista da presidente-eletto che “avere evitato quattro altri anni di Trump è già un risultato”. Deve poi cercare di indebolire questo mondo paranoico della alt-reality, della realtà “alternativa” arrivato dopo il 3 novembre e con Trump ad alimentarlo una paranoia. Il tutto con i repubblicani che probabilmente manterranno per 1 voto se non due la maggioranza al Senato, hanno molto accorciato le distanze alla Camera e hanno vinto negli Stati, dove controllano più che mai la netta maggioranza delle assemblee locali e dei governatori.
Biden dovrà concentrarsi sull’economia e sulla politica interna perché è lì che si guadagnano consensi; dovrà gestire i progressisti democratici, che ad ogni voto guadagnato a sinistra ne fanno perdere uno a destra come dimostra la forza repubblicana nel voto locale, farà una politica estera decisamente migliore di quella inesistente di Trump, addolcirà ma non molto i termini di quella commerciale. Per l’Europa è molto meglio avere lui. Ma visto il complesso della consultazione, vista la realtà degli schieramenti, Biden non potrà dire nel discorso inaugurale ciò che Gerald Ford chiamato a sostituire il dimissionario Richard Nixon disse nel suo discorso inaugurale del 9 agosto 1974: “My fellow Americans, our long national nightmare is over”.
L’incubo è dietro le spalle. No, l’incubo Trump, e più ancora il trumpismo, rimangono. Gingrich vista la vittoria repubblicana negli Stati parla ora di una prossima “decade of creativity”, da sempre una sua specialità e assai prossima alla alt-reality. La speranza è che si apra anche un fronte fra Trump e il partito repubblicano, dopo lo show postelettorale da dittatore della repubblica delle banane.