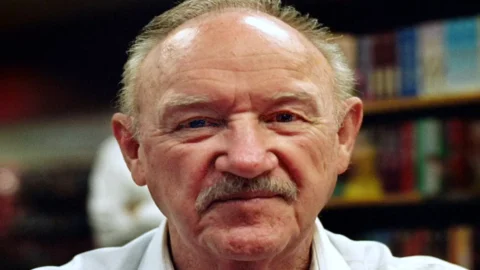In un precedente articolo pubblicato su FIRSTonline si è visto come la femminilizzazione delle professioni un tempo esercitate da soli uomini abbia sollevato all’inizio un certo imbarazzo linguistico, e anche soluzioni, come “sindachessa” o “giudichessa”, che più che per femminilizzare sembravano esser nate per canzonare. Questo in fondo è vero anche quando si percorre la strada opposta, ossia quella di maschilizzare le attività presuntamente solo femminili.
Il “mammo” e il “ghiando”
Come in certe commedie nazional-popolari, l’effetto ironico è dovuto alla presunta inversione dei ruoli: i pochi uomini che rinunciano alla carriera per curare la moglie e i figli sono sempre stati chiamati dai giornali “il casalingo” con le virgolette, e sembrano molto divertenti, ma solo da noi, “il bambinaio” o “il segretario” (nelle piccole aziende, mentre quando si tratta del capo di un partito suona improvvisamente strano il femminile), per non parlare di “il mammo”, sfottò rivelatore del fatto che, per molti di noi, un padre che si comporta in modo affettuoso coi figli anziché berciare se non sanno cosa sia lo spinterogeno è ancora motivo d’irrefrenabile ilarità.
Lasciamo da parte il “mammo”, che è parola inventata come sarebbero “il pecoro, il mucco, il ghiando” (ma non poi tanto: in varie parti della Toscana queste forme significano “l’ariete” in quanto maschio della pecora, “il vitello senza corna” che dunque somiglia alla mucca, e “la quercia” in quanto albero da cui cadono le ghiande).
L’avvocato e l’avvocata
Negli altri casi, è piuttosto normale che le parole maschili in -o formino il femminile prendendo una -a: se abbiamo il gatto e la gatta, il nonno e la nonna, il tizio e la tizia e, udite udite, nomi di mestieri come il sarto e la sarta, il maestro e la maestra o il cuoco e la cuoca, allora l’avvocato e l’avvocata sono perfettamente formati secondo le regole della nostra lingua, e così il sindaco e la sindaca o il ministro e la ministra.
Anzi, il caso dell’avvocata è particolarmente ovvio, trattandosi di un participio passato sostantivato (il laureato e la laureata, l’impiegato e l’impiegata, l’imputato e l’imputata), ma anche la sindaca e la ministra hanno perso da un pezzo le virgolette: dopo che a governare la Capitale ci è andata una donna, dopo che abbiamo avuto ormai qualche decina di ministre, attardarsi a chiamare una donna in politica “il sindaco” o “il ministro” sembra un puntiglio ideologico che non ha molto a che fare con la parità (anzi).
Il “dilemma dell’assessrice”
La scorsa estate, e dunque prima delle elezioni e dello strambo comunicato con cui la Meloni diceva di voler essere chiamata “il Signor Presidente del Consiglio” come se fosse un uomo, mi trovavo in un piccolo comune dell’Umbria governato da Fratelli d’Italia, e ho così avuto l’occasione di fare un esperimento. Ero a cena col sindaco e la responsabile della Cultura, insieme ai quali avevo presentato un libro. “Ma come si dice”, avevo chiesto con ingenuo tono curioso, “lei è l’assessore o l’assessora?”.
“L’assessore, naturalmente”, mi aveva risposto la signora con un sorriso durante il piacevole evento mondano, “perché il femminile giusto sarebbe assessrice, ma suona male”. Lo credo bene che suona male: quella parola non esiste, essendo erroneo il presupposto per cui le parole maschili in -ore avrebbero il femminile in -rice.
Proviamo: pittore-pittrice, scultore-scultrice, attore-attrice, direttore-direttrice, nuotatore-nuotatrice, traditore-traditrice e così via. Cosa ne risulta? Che le parole in -tore hanno il femminile in -trice, ma la parola “assessore”, essendo sprovvista di /t/, non può prendere tale suffisso femminilizzante. Se vogliamo dirla in termini di linguistica generale, al morfema m. -ORE non corrisponde il morfema f. RICE; in termini strettamente fonetico-fonologici, il nesso /ssr/ in italiano non è grammaticale.
Forse “assessoressa”?
Anzi, per dirla tutta ci sono anche alcune parole in -tore che, per motivi vari, non fanno il femminile in -trice, ad esempio una donna che si mettesse in combutta con un impostore sarebbe “un’impostora” e non “un’impostrice”, e le chiese protestanti che hanno accolto il sacerdozio femminile possono avere un pastore o “una pastora”, ma non “una pastrice”.
Per riformulare la questione in termini fonologici, la presenza di /s/ impedisce l’alternanza -TORE / -TRICE, nonostante /str/ sia perfettamente ammesso dall’italiano in tante altre posizioni, da “ancestrale” a “pipistrello”, fino a “stranezza”.
Ora, le soluzioni al “dilemma dell’assessrice”, sono due: si può usare il suffisso -essa, come in “dottoressa, professoressa”, ottenendo “assessoressa”, parola che però comprende un po’ troppe /ss/ per non risultare un tantino cacofonica, oppure si trasforma -ore in –ora ottenendo “assessora”, che è perfettamente formato se si considera accettabile (e produttivo) il sistema “impostore / impostora, pastore / pastora”.
L’assoluta normalità e regolarità delle parole femminili
A pensarci bene, la chiave della fortuna delle nuove forme femminili, come “avvocata, sindaca, ministra, assessora”, sembra stare proprio lì: nella loro assoluta normalità. Esattamente come “il ghiando”, che può sembrar buffo a chi lo giudichi guardandolo dal di fuori del sistema in cui è nato (ossia il toscano di certi luoghi e ambienti) ma sembrerà perfettamente normale giudicandolo dal di dentro, perché formato secondo le regole: se il melo dà le mele e il pero dà le pere, il ghiando dà le ghiande, ed ecco che con questo termine si può designare la quercia.
Tornando all’italiano, la normalità delle forme femminili in -a è tale che queste forme sono visibilmente in espansione: fino a poco tempo fa sarebbe stato impossibile sentir parlare in televisione di una “politica” che vuol diventare “segretaria” del PD, e invece è quel che abbiamo sentito di recente.
La frase ha rotto due argini finora piuttosto solidi, ossia il fatto che “la politica” è già il sostantivo indicante l’attività di governare la polis, per cui non sembrava troppo probabile che si potesse usare anche come femminile di “il politico”, mentre “la segretaria”, come s’è visto, faceva finora pensare alla dattilografia e all’archivistica, non certo alla capa di un partito. Eppure ormai ci siamo, malgrado qualcuno si attardi in battaglie di retroguardia.
La Nazione ha scelto
È in genere poco prudente formulare previsioni nette in un campo come l’uso della lingua che, in quanto strumento di comunicazione di un collettivo vasto e stratificato (nel caso dell’italiano si ragiona pur sempre di circa 60 milioni di persone), può prendere anche pieghe inaspettate, ma è probabile che certi puntigli fuori tempo possano tutt’al più ritardare l’evoluzione in atto, senza riuscire a riportare indietro le lancette dell’orologio.
La femminilizzazione dei nomi di attività da poco desegregate è ormai a buon punto, e segue regole interne alla lingua italiana largamente applicate in tutti gli altri ambiti: al Signor Presidente del Consiglio la cosa potrà non piacere, ma sembra che la “Nazione” abbia già scelto.
Aspettiamo con trepidazione la prossima circolare.
. . .
Daniele Vitali, bolognese, è stato per anni traduttore alla Commissione europea. Ha al suo attivo vari lavori di glottologia su lingue e dialetti, fra cui “Ritratti linguistici: il romeno” (Inter@lia 2002), “Parlate italo-lussemburghese? Appunti sulla lingua degli italiani di Lussemburgo” (Inter@lia 2009), “Pronuncia russa per italiani” (con Luciano Canepari, Aracne 2013), nonché il grande “Dizionario Bolognese-Italiano Italiano-Bolognese” (Pendragon 2007 e 2009, con Luigi Lepri), “Dialetti emiliani e dialetti toscani. Le interazioni linguistiche fra Emilia-Romagna e Toscana” (Pendragon 2020) e “Mé a dscårr in bulgnaiṡ. Manuale per imparare il dialetto bolognese” (Pendragon 2022).