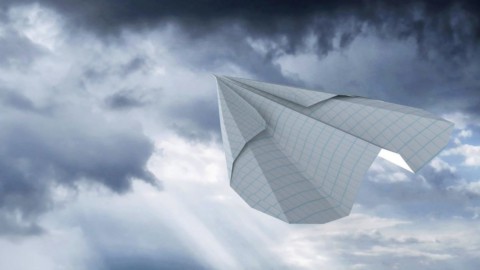Made in Italy senza Italy? Stiamo diventando la Cina del lusso? Sono due domande – legittime – poste al convegno sui “Nuovi scenari della Moda e del Lusso” organizzato da Pambianco e Intesa Sanpaolo presso la Borsa di Milano, alla presenza di alcuni dei grandi protagonisti italiani del settore, da Cucinelli a Luxottica, da Salvatore Ferragamo a Renzo Rosso, a Lapo Elkann e tanti altri.
La risposta è “ni”. Sarebbe no perché da un lato, come è ormai arci-noto, è vero che sempre più brand italiani vengono acquistati da gruppi stranieri, in particolare dai due principali poli aggreganti provenienti dalla Francia, quelle Lvmh e Kering (ex Ppr) che da sole fatturano quasi 40 miliardi di euro e possiedono 13 marchi d’eccellenza italiani, tra cui Fendi, Bulgari e Gucci; per un totale di 27 aziende di moda e lusso passate in mani straniere dal 1999, con un fatturato complessivo (delle imprese acquistate) di quasi 10 miliardi nel 2012.
“Il caso di scuola – ha illustrato alla platea di Palazzo Mezzanotte David Pambianco vicepresidente di Pambianco – è quello di Bottega Veneta, che passano nelle mani di Kering ha decuplicato il proprio giro d’affari in pochi anni, da 100 milioni a 1 miliardo di euro”. E’ altresì vero però che altre aziende italiane non sono rimaste a guardare e hanno fatto lo stesso all’estero, seppur in misura ridotta e comperando aziende dal fatturato minore: dal ’99 Prada ha preso la scarperia inglese Church, Tod’s la Roger Viver, OTB (Only The Brave, la holding di Renzo Rosso) Martin Margiela e Viktor&Rolf, ma soprattutto Luxottica ha fatto il pieno con 6 marchi di occhialeria inglobati, tra i quali l’appetitissimo Ray Ban.
A prescindere dalla proprietà, il made in Italy sarebbe comunque salvo finché il know how restasse al 100% italiano. La tendenza però è quella per cui l’Italia sta diventando appetibile non solo per i suoi prestigiosi e richiesti marchi, ma anche per il suo preziosissimo know how e per la qualità della sua filiera produttiva: e dunque adesso gli stranieri non solo comprano i nostri marchi, ma vengono a “fabbricare” i loro da noi. Si avvalgono cioè delle nostre maestranze, in particolare per la parte più di alta gamma delle loro collezioni, per produrre beni che poi saranno “made in France”, “made in Usa” e quant’altro.
“Il valore totale delle façon – spiega ancora Pambianco – nei settori abbigliamento, calzature e pelletteria viene stimato in 2,2 miliardi di euro. Valore abbastanza alto tenuto conto che nella catena del valore si riferisce al primo 15% del costo del prodotto”.
Nulla di male, apparentemente, visto che anzi il fenomeno di produzione “a façon” per gruppi esteri accelera la crescita e i fatturati delle aziende façonista, ovvero quelle artigianali e piccole che fanno del know how la loro forza ma che per motivi di dimensioni rimangono tagliate fuori dalla grande corsa all’export. Il problema potrebbe però sorgere nel lungo termine, quando potrebbe esserci il rischio che il consumatore internazionale, in particolare quello asiatico che continua a dominare questo mercato, inizi ad attribuire più importanza al brand (straniero) e meno alla produzione (italiana).
“Il focus – sintetizza Pambianco – passerebbe così da ‘made in’ a ‘made by’”. Si corre quindi il rischio non tanto che il Bulgari di turno venga considerato francese perché acquisito da francesi, ma piuttosto – e forse sarebbe ancora peggio – che l’ipotetico Bulgari francese, che si equivarrà con quello italiano producendo in Italia, venga riconosciuto esclusivamente come francese. E allora sì, addio made in Italy. E allora sì che diventeremmo la Cina del lusso.