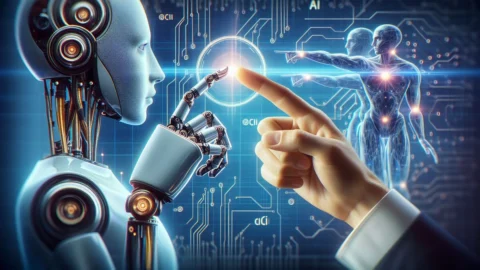Nel post della scorsa settimana il glottologo Daniele Vitali, autore di goWare, ha raccontato come sia entrato nella nostra Costituzione, andata in vigore il 1 dicembre 1948, il principio del riconoscimento e della tutela della lingua parlata dalle minoranze non di madrelingua e cultura italiana. Queste lingue minoritarie durante il fascismo erano state marginalizzate e ostracizzate nel tentativo di imporre la lingua e la cultura italiana a quelle popolazioni.
Per decenni il principio del riconoscimento delle minoranze linguistiche, sancito dalla Costituzione, è rimasto un bel paragrafo nella nostra carta fondamentale. È infatti mancata una legge attuativa arrivata solo alla fine del secolo, il 15 dicembre 1999, a mezzo secolo di distanza.
Nel post di oggi Vitali passa in rassegna le serie carenze della legge e il suo taglio parziale e minimalista nei confronti delle lingue minoritarie parlate in Italia.
Buona lettura!
La lista dei dialetti
Aldilà delle obiezioni glottofobe che furono sollevate allora contro la legge 482, e dunque contro l’articolo 6 della Costituzione, è in realtà in un’ottica favorevole alla tutela delle minoranze che si possono muovere le maggiori critiche al testo.
Tanto per cominciare, riguardando solo le minoranze linguistiche storiche, la legge esclude, oltre alle lingue degli immigrati, che hanno esigenze diverse e sono sparse sotto forma di diaspora sul territorio, anche i cosiddetti “dialetti”.
La lista delle lingue minoritarie è infatti quella tradizionale dell’ambiente accademico nazionale, che vedeva dialetti italiani in tutti gli idiomi neolatini senza un addentellato estero: l’occitano e il francoprovenzale sono o erano parlati soprattutto fuori dall’Italia, e così naturalmente il francese e il catalano; in un certo senso ciò valeva anche per il friulano e il ladino, in quanto collegati al romancio parlato in Svizzera, per cui l’unica eccezione, che risale al fondatore della glottologia in Italia Graziadio Isaia Ascoli, è sempre stata fatta per il sardo.
Per la verità, in un celebre articolo pubblicato alla fine del XIX secolo e intitolato “L’Italia Dialettale”, Ascoli aveva escluso dagli idiomi facenti capo al sistema toscano anche i dialetti “gallo-italici” (piemontesi, lombardi, liguri ed emiliano-romagnoli), ma i suoi successori, rendendosi conto delle conseguenze politiche di quella classificazione, avevano effettuato una rapida marcia indietro.
I dialetti esclusi
Ora, già prima della fase secessionista della Lega Nord esistevano, in Piemonte, Lombardia e Veneto, movimenti che chiedevano il riconoscimento di piemontese, lombardo e veneto come lingue regionali (e del resto c’è un sentimento di alterità anche in Sicilia, dove alcuni ambienti parlano apertamente di lingua siciliana).
Quei movimenti esistono ancora adesso che la Lega è diventata nazionalista e sovranista, e covano un forte risentimento verso una legge che li taglia fuori: conosco personalmente un attivista secondo il quale “piuttosto che una legge che esclude il piemontese è meglio non avere nessuna legge”.
Anche mettendo da parte le puerilità del tipo “tanto peggio tanto meglio”, è vero però che la legge 482 è piuttosto parziale nella sua copertura, da cui resta esclusa anche una minoranza linguistica storica, sebbene non stanziata in modo compatto e stabile, ossia i rom e i sinti, cioè quegli zingari che, anche se tutti credono che parlino “rumeno” o “slavo”, hanno in realtà una lingua propria, proveniente come loro dall’India: il romanés o romaní, che fra l’altro ha dato un certo apporto ai gerghi e, tramite questi, ai dialetti italiani.
Il testo originario della legge prevedeva infatti il riconoscimento di 13 minoranze linguistiche storiche, ma i leghisti si opposero (certo per ragioni squisitamente filologiche di cui loro avevano esclusiva contezza), e così le lingue tutelate scesero a 12.
La pecca più grave però a me sembra un’altra, ossia la debolezza, e dunque l’inefficacia, delle norme.
La scelta della frammentazione decisionale
Tanto per cominciare, la legge non elenca le aree di lingua minoritaria, pur perfettamente note sin dalla fine dell’Ottocento, ma soltanto le minoranze, il che ha due conseguenze.
La prima è che la tutela scatta solo laddove i consigli provinciali e comunali prendano la decisione di dichiarare i rispettivi territori come di lingua minoritaria.
Quel che a prima vista può sembrare un principio democratico, perché basato su un’espressione di volontà degli amministrati tramite i loro amministratori, è in realtà un modo per rendere la tutela debole e lacunosa.
Proviamo a immaginare se, per salvare l’orso marsicano dall’estinzione, lo Stato italiano si fosse limitato a vietarne la caccia, ma non avesse istituito il Parco Nazionale d’Abruzzo: rimasto senza habitat per l’occupazione edilizia del territorio, l’animale si sarebbe estinto comunque, magari anche a colpi di doppiette illegali con la scusa che “invadeva” gli insediamenti umani.
Proviamo poi a pensare a che razza di tutela del patrimonio urbanistico nel centro storico di una città d’arte si avrebbe se si decidesse il divieto di abbattimento solo per le case antiche dal numero civico pari, lasciando campo libero alle ruspe per i numeri dispari: non rimarrebbe neanche una strada intatta dalla speculazione, e tanti saluti alla coerenza urbanistica e paesaggistica.
Il caso sardo
Senza voler coniare una nuova definizione opinabile del tipo “la lingua è un ecosistema”, risulta evidente che una cosa è tutelare il sardo con efficaci norme nazionali e regionali in tutta la Sardegna (sorvoliamo qui sulle questioni di diversità dialettale interna all’isola), e un’altra invece farlo solo laddove e come ciò piaccia ai consigli comunali.
Eppure è proprio questa seconda strada che ha scelto lo Stato italiano, e tutto ciò, ripetiamolo pure, in una regione a statuto speciale: in effetti, la Regione Sardegna avrebbe già deliberato due volte per rendere il sardo lingua co-ufficiale accanto all’italiano, il che avrebbe potuto trasformare l’isola in una specie di grande Sudtirolo romanzo, ma per ben due volte lo Stato è ricorso alla Corte costituzionale.
Sostenuto che questa materia era di sua competenza (e non dei rappresentanti diretti dei sardi!), si è pure visto dare ragione dalla Corte, così che della co-ufficialità del sardo non si è mai fatto nulla, e della sua tutela in buona sostanza neanche. Chi ritenesse queste riflessioni un’esagerazione potrà fare un giretto per Cagliari, e constatare quale sia l’uso effettivo del sardo in città: evidentemente il livello comunale, almeno per le zone ampie e compatte, non è una gran soluzione.
Il caso di Messina
La seconda conseguenza del non indicare su quali territori si parlano le lingue minoritarie è che qualunque comune può dichiararsi francofono, o germanofono, o catalano, o quel che gli pare, senza che nessuno ci trovi nulla da obiettare, sottraendo così fondi alle minoranze vere.
Fantapolitica? Purtroppo no: basti pensare che la città di Messina si è dichiarata di lingua greca, quando tutti gli interessati alla materia sanno che la minoranza grecofona d’Italia abita 5 comuni in provincia di Reggio Calabria e 9 comuni in provincia di Lecce.
La Sicilia non c’entra un bel nulla, se non che in tempi ellenistici era Magna Grecia. Ma allora tanto varrebbe riconoscere una minoranza etrusca e poi mandare finanziamenti per la tutela al comune di Volterra.
Il modello svizzero
Per concludere, è senz’altro un bene che si sia lasciato inapplicato l’articolo 6 della Costituzione per “soli” 52 anni (è andata molto peggio alla disposizione finale XII “È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista”), però la norma applicativa francamente non suscita soverchi entusiasmi, e andrebbe drasticamente modificata, per esempio traendo ispirazione dal modello territoriale svizzero.
Sempre che per “tutela” s’intendano “politiche per un’effettiva sopravvivenza della diversità culturale” e non semplicemente “contentini per non farsi accusare di inazione”. Perché, in questo secondo caso, anziché mandar baiocchi al comune ellenofono di Messina sarebbe meglio esporre in piazza un bell’orso.
Impagliato [forse meglio scolpito in legno NdR]
Chi è Daniele Vitali
Daniele Vitali, bolognese, è stato per anni traduttore alla Commissione europea. Ha al suo attivo vari lavori di glottologia su lingue e dialetti, fra cui “Ritratti linguistici: il romeno” (Inter@lia 2002), “Parlate italo-lussemburghese? Appunti sulla lingua degli italiani di Lussemburgo” (Inter@lia 2009), “Pronuncia russa per italiani” (con Luciano Canepari, Aracne 2013), nonché il grande “Dizionario Bolognese-Italiano Italiano-Bolognese” (Pendragon 2007 e 2009, con Luigi Lepri), “Dialetti emiliani e dialetti toscani. Le interazioni linguistiche fra Emilia-Romagna e Toscana” (Pendragon 2020) e “Mé a dscårr in bulgnaiṡ. Manuale per imparare il dialetto bolognese” (Pendragon 2022).