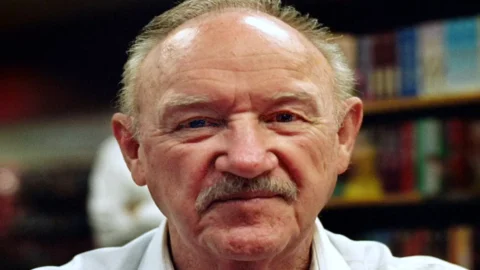Almeno per l’Europa, gli anni Novanta sono stati caratterizzati dalla traumatica crisi del Sistema monetario europeo (SME), istituito nel dicembre del 1978 e messo – di fatto – fuori uso dalle vicende dell’estate e dell’autunno del 1992 , e dalla repentina ripresa del processo di creazione dell’area monetaria unica, riavviato con l’inatteso (anche se formale) ripristino dello SME e – soprattutto – con l’attuazione del precedente Trattato di Maastricht e concluso con successo nel maggio del 1998 . Peraltro, più o meno negli stessi anni, a livello internazionale si realizzavano altri due fatti di portata storica: il diffondersi di un nuovo paradigma tecnologico (la cosiddetta “information and communication technology”: ICT), paragonabile alle innovazioni della rivoluzione industriale e a quelle dell’inizio del XX secolo, e il definitivo imporsi dei Paesi emergenti (primi fra tutti, i cosiddetti BRICS) nel commercio mondiale . Ovviamente, qui non è possibile soffermarsi su vicende di questa portata; basti trarne poche implicazioni per il caso italiano e per il problema delle rendite.
L’Italia, che a partire dall’inizio degli anni Settanta aveva mantenuto tassi di crescita economica superiori o allineati alla media degli altri Paesi economicamente avanzati soprattutto grazie alle svalutazioni competitive della lira e agli ingenti flussi di spesa pubblica e che aveva una struttura economica imperniata su servizi arretrati e su imprese manifatturiere di piccola e piccolissima dimensione (per di più, specializzate in comparti a media o bassa tecnologia), è stata incapace di fronteggiare la sfida competitiva imposta dalle novità degli anni Novanta. Per partecipare al varo dell’Unione monetaria europea (UME), essa ha dovuto correggere i suoi squilibri macroeconomici procedendo, con il ritardo di un decennio e in una congiuntura economica europea meno favorevole, a quegli aggiustamenti che i Paesi concorrenti avevano attuato – con maggiore gradualità – già negli anni Settanta od Ottanta. Per di più, tali aggiustamenti hanno avuto un impatto negativo sull’economia ‘reale’, in quanto si sono sommati alla forzata cancellazione delle passate ‘droghe’ (svalutazioni competitive, trasferimenti pubblici, e così via) e all’incapacità delle nostre piccole e piccolissime imprese industriali di incorporare il nuovo paradigma tecnologico, caratterizzato dalle innovazioni organizzative e dall’integrazione con servizi avanzati. Il nostro sistema produttivo è diventato, così, molto vulnerabile rispetto alla concorrenza dei Paesi emergenti; e ha aumentato il proprio ritardo rispetto agli altri grandi Paesi europei che, nel frattempo, attuavano riforme microeconomiche volte ad accrescerne la competitività.
A fronte di questa situazione, gli attori economici italiani hanno reagito dilatando ulteriormente le aree di rendita. Gran parte delle nostre residue grandi imprese industriali private ha sfruttato i processi di privatizzazione senza liberalizzazione dei mercati (1992-2001) per riconvertire l’attività e rifugiarsi in settori protetti rispetto alla concorrenza, trasformando così vecchi monopoli pubblici in quasi-monopoli privati; l’inefficienza dei servizi pubblici e privati è aumentata, investendo soprattutto gli enti decentrati e le imprese locali; la parte prevalente delle piccole e piccolissime imprese ha cercato di costruirsi ‘nicchie’ protette nei mercati nazionali, ricorrendo a espedienti spesso illegali (evasione fiscale, lavoro nero o ‘grigio’, fittizi rapporti di lavoro temporaneo od autonomo); è cresciuta la porzione privilegiata di lavoratori dipendenti che, sfruttando la scarsa pressione concorrenziale, ha dilatato le proprie retribuzioni incorporando robuste componenti di rendita; i lavoratori autonomi privilegiati hanno rafforzato le loro barriere monopolistiche (ordini, barriere di mercato, ecc.) e hanno continuato a prosperare; lo stesso settore bancario, che pure ha attuato uno straordinario processo di consolidamento e di dismissione del controllo statale (1990-2002), ha mantenuto e accresciuto gli intrecci proprietari (presieduti dalle fondazioni di origine bancaria) per proteggersi dalla concorrenza internazionale. Di conseguenza, lo sparuto drappello delle medie e piccole imprese italiane, che – sfidando le negative esternalità ambientali (alimentate dalle posizioni di rendita, sopra esaminate) e le difficoltà di adattamento al nuovo – ha saputo costruire e rafforzare rilevanti posizioni competitive nei mercati internazionali, non ha avuto apprezzabili impatti a livello aggregato.
Non può quindi sorprendere che, fra la seconda metà degli anni Novanta e il 2005 – ossia, in concomitanza con il periodo a più elevata (anche se distorta) crescita a livello internazionale, l’economia italiana abbia dapprima realizzato bassi tassi di crescita del PIL e sia, poi, caduta in una prolungata fase di stagnazione. Tale situazione è emblematicamente rappresentata dalla dinamica della produttività: dalla metà degli anni Novanta, in Italia la produttività del lavoro e la produttività totale dei fattori hanno registrato i più bassi tassi di incremento fra i Paesi dell’Unione europea). E non può neppure sorprendere che, pur disponendo di un settore bancario rimasto ai margini della crisi finanziaria internazionale del maggio 2007 – aprile 2009, l’Italia sia stato uno dei sistemi economici avanzati con il peggiore andamento del PIL e con la più alta incidenza di fallimenti di imprese dall’inizio della crisi ‘reale’ (autunno 2008) a oggi. Per giunta, la selezione delle imprese non ha portato all’espulsione di quelle più inefficienti: fatta eccezione per l’esiguo sottoinsieme di imprese di successo nei mercati internazionali, nel mercato nazionale sono sopravvissute le imprese più solide e quelle più protette da posizioni di rendite e sono uscite molte di quelle in fase di ristrutturazione e più esposte alla concorrenza. Pertanto, l’economia italiana rischia di emergere seriamente azzoppata dalla lunga crisi europea e di diventare la più consistente minaccia per la sopravvivenza dell’UEM.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, appare evidente che la critica di Claudio Napoleoni alle rendite e le relative proposte di politica economica rappresentano un lascito prezioso per fare i conti con le drammatiche prospettive dell’economia italiana di oggi. Il nostro Paese non è stato in grado di adattarsi al nuovo regime di funzionamento dell’economia a livello internazionale (ICT, euro, Paesi emergenti), che si è imposto negli anni Novanta, soprattutto perché è stato soffocato da una crescente e pervasiva area di rendita. Le posizioni di rendita, come definite da Napoleoni, si sono rafforzate sia nella pubblica amministrazione che nelle attività private, sia nei servizi che nell’industria, sia fra gli imprenditori che fra i lavoratori autonomi; addirittura, specie in alcune fasi (primi anni Settanta, anni Ottanta e metà degli anni Novanta), esse hanno anche coinvolto fasce di lavoratori salariati a reddito medio-basso. Oggi, dopo la più prolungata e severa crisi della nostra economia nella storia contemporanea, il costo sociale delle rendite e il soffocante coacervo di legami consociativi, che ne è il corollario, non sono più compatibili con l’appartenenza dell’Italia all’UEM e allo stesso novero dei Paesi economicamente avanzati.
Le analisi di Napoleoni nel periodo della Rivista Trimestrale e le sue proposte di politica economica nella seconda metà degli anni Settanta, così come i travagli teorici dell’autore che ne hanno consentito l’elaborazione, tornano quindi a essere assai utili. Si tratta, ovviamente, di adattare queste analisi e queste proposte alla situazione italiana attuale e di interpretarle anche alla luce dell’evoluzione della teoria economica.
Riguardo al primo aspetto, la crescente e pervasiva diffusione di aree di rendita mostra che sia la borghesia produttiva che i lavoratori salariati trarrebbero grande giovamento se il capitalismo italiano fosse riformato grazie a quello ‘scambio’ cooperativo e conflittuale, che Napoleoni delinea negli articoli su la Repubblica del 1976 e approfondisce nelle due successive riflessioni di politica economica sopra citate. Tale prospettiva comporta l’attuazione di riforme, che si potrebbero denominare – con l’autore – “riforme-grano” ma che cesserebbero di essere parziali – nel senso di funzionali ai soli interessi capitalistici – per diventare condizione preliminare e necessaria al riavvio dell’accumulazione e dello sviluppo dell’economia italiana e alla realizzazione di riforme più radicali. Si tratterebbe di “riforme-grano” rivolte non solo a rendere più efficiente l’ambiente, in cui le imprese italiane si trovano a operare, ma anche a prosciugare le molteplici aree di rendita interne al settore dell’industria e dei servizi. Per soddisfare il loro obiettivo, queste riforme dovrebbero colpire i sedimentati privilegi di molti aggregati sociali e aprire alla concorrenza e alle innovazioni economiche; e, siccome i passaggi dall’attuale capitalismo italiano delle rendite a un capitalismo efficiente e aperto impongono cambiamenti profondi e socialmente costosi, esse dovrebbero anche erigere protezioni pubbliche efficaci per le fasce più deboli della popolazione.
La programmazione nazionale, anche nella versione indebolita di Napoleoni, non dovrebbe avere uno spazio significativo nell’attuazione delle nuove “riforme-grano” per la lotta alle rendite. I sistematici fallimenti dello Stato programmatore italiano consumatisi fra gli anni Settanta e gli anni Novanta, la diffusa inefficienza della nostra attuale pubblica amministrazione centrale e locale, l’implosione del sistema italiano dei partiti e la connessa e crescente diffusione della corruzione, l’esclusiva attenzione all’emergenza da parte dei governi succedutisi in Italia negli ultimi quindici anni renderebbero velleitario affidare le riforme e i conseguenti investimenti strategici per il superamento delle rendite a una programmazione pubblica nazionale, ancorché declinata per specifiche aree di intervento. Grazie all’altro aspetto qui considerato (la recente evoluzione della teoria economica) e ai progressi della governance economica dell’UEM, dovrebbe però essere chiaro che ciò non implica il ridimensionamento del pubblico o l’esclusivo ricorso a meccanismi di mercato. Si tratta invece di impegnare l’amministrazione pubblica in compiti cruciali di razionalizzazione e di varare innovative iniziative di politica economica, di politica industriale e di politica sociale che combinino i diversi livelli istituzionali, si avvalgano di apporti sia del pubblico che del privato e – soprattutto – utilizzino le regole europee come opportunità prima ancora che come vincoli.
In particolare, le autorità nazionali di politica economica avrebbero, almeno, sei difficili compiti da svolgere: (i) l’eliminazione delle posizioni di rendita che sono la (diretta o indiretta) conseguenza di una distorta allocazione della spesa pubblica; (ii) la destinazione di una parte dei risparmi di spesa pubblica, così ottenuti, al miglioramento qualitativo dell’istruzione e della ricerca e – in generale – dei servizi alle imprese anche mediante il ricorso a iniziative private; (iii) la destinazione della parte residua di tali risparmi e dei maggiori introiti, derivanti da una più severa tassazione delle persistenti posizioni di rendita, alla riduzione delle imposte sui redditi famigliari medio-bassi e sulle attività delle imprese produttive; (iv) una radicale semplificazione normativa e regolamentare che assicuri la stabilità e l’efficace salvaguardia dei diritti e dei doveri degli attori di mercato e che poggi su presidi di policy making, su una riorganizzazione della pubblica amministrazione e su un’efficiente regolamentazione dei mercati; (v) la fissazione di linee-guida di policy che individuino, mediante l’interazione con i segnali di mercato e con quelli provenienti da istituzioni intermedie, la possibile compatibilità fra la minima discrezionalità e la massima selettività degli interventi pubblici; (vi) un profondo ridisegno del welfare state, volto a cancellare le attuali e pervasive distorsioni e a offrire efficaci protezioni e opportunità di reinserimento a quanti saranno emarginati dai processi di cambiamento.
Così facendo, il nostro Paese innescherebbe davvero quella lotta alle rendite, auspicata da Claudio Napoleoni, e recupererebbe margini di competitività nel mercato interno europeo e nei mercati internazionali. Ciò potrebbe dar luogo a un circolo virtuoso: cessando di rappresentare la peggiore minaccia per la sopravvivenza dell’UEM e ritornando invece a svolgere la funzione di suo influente Stato membro, l’Italia sarebbe in grado di spingere per la costruzione di quelle istituzioni europee necessarie all’attuazione di riforme più radicali.