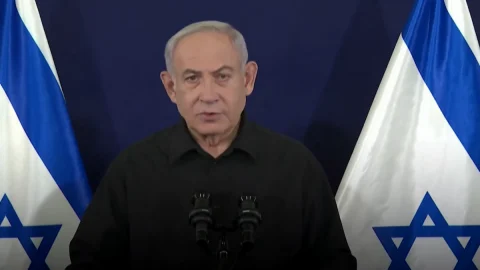I titoli dei giornali, come gran parte dei commenti al discorso alle Camere del Presidente Mattarella, hanno registrato l’inconsueta, sorprendente sottolineatura della parola dignità, che vi ricorre per ben 18 volte. Ma io sono rimasta colpita dalla sua immediata banalizzazione. Invece di avanzare qualche interrogativo sul senso dell’utilizzo così insistito di un termine carico di storia e di valore, i commentatori hanno virato tutti su lidi semantici più familiari: hanno tradotto dignità con diritto, e così la lunga serie di figure e temi evocati dal Presidente è stata trasformata in un’elencazione di diritti sociali, certo enunciata nella lingua alquanto desueta della cultura cattolico-democratica.
Insomma, un’iterazione solenne diventa un’iniezione di afflato sociale ed etico in un presente dominato dalle disuguaglianze e dalle povertà. Ma davvero si può tradurre dignità con diritti invocando l’eco di vecchie distanze ormai ampiamente superate? In effetti la lezione che si ricava è che il termine dignità proviene da una cultura, nobile sì, ma ormai esaurita mentre può rivivere solo immettendosi (traducendosi) nella moderna cultura dei diritti. No! Non credo affatto che l’uso del termine dignità sia un omaggio alla tradizione o peggio un residuo arcaicizzante. Non intendo certo esercitarmi nell’esegesi del discorso del presidente, non sarebbe appropriato. Vorrei solo far presente alcune questioni che rendono problematica quella traduzione lineare.
Dignità è un termine, ereditato dalla civiltà umanistica, con cui si è provato – da parte di alcuni movimenti e gruppi di donne (a cui anch’io ho partecipato) – a sfuggire ai dilemmi, alle vere e proprie contraddizioni che il proliferare sconnesso dei diritti soggettivi produce nelle nostre società ormai pienamente post tradizionali.
In effetti la presa dei dettami religiosi sui comportamenti sociali e individuali si è del tutto allentata e la secolarizzazione ha fatto passi da gigante; le norme etiche derivanti da ordinamenti gerarchici sono state scalzate dal principio dell’eguaglianza degli individui. Ad esempio, nella famiglia in cui è stato soppresso il principio di autorità maritale e paterno; non esistono più istituzioni inaccessibili ad alcuni soggetti (come la magistratura e l’esercito alle donne). Insomma, secolarizzazione e scomparsa della gerarchia e dell’autorità tradizionale si sono imposte.
Certo alcune minoranze richiedono di vedere riconosciuti e affermati diritti civili ancora per certi aspetti negati. Ma dalla prospettiva della rivoluzione delle donne, risulta problematico pensare la libertà femminile in termine di diritti. Fino a quando il processo di liberazione delle donne riguarda la lotta contro tutte le forme di dominio patriarcale, di oppressione e di subalternità ereditate dal passato appare del tutto scontato ricorrere al modulo della modernità contro tradizione e declinare la tensione verso la libertà in termini di diritti: diritto al lavoro, all’uguaglianza con gli uomini, diritto alla parità in tutti gli ambiti.
Ma cosa accade nel momento in cui il processo emancipativo consuma, erode simboli, strutture e forme della tradizione e la libertà delle donne si confronta solo con se stessa, nel pieno della modernità dispiegata? Accade che quella equivalenza tra diritti e libertà mostra la corda, incrinando la pervasività della cultura dei diritti: lo si è già sperimentato con l’aborto (cioè con il riconoscimento di una specificità della cittadinanza femminile) per cui la libertà di scelta assicurata dalla legge 194 non è declinata in termini di diritto ma di autodeterminazione.
Mai come dalla prospettiva delle donne il paradigma del diritto soggettivo diventato dominante nell’economia come nella politica o nell’etica appare non solo inadeguato ma generatore di dilemmi: li abbiamo sotto gli occhi con lo scambio della concezione della libertà come affermazione positiva dell’integralità e della dignità della persona con l’idea mercantile della libertà come assenza di vincoli nel disporre di sé sul mercato. Fino al punto di invocarla per giustificare la pratica aberrante della maternità surrogata o per ridurre la prostituzione a sex work, a un lavoro come un altro.
Il modello atomistico che è alla base della grammatica dei diritti non contempla alcun nesso di dipendenza e responsabilità fra le persone e quindi non prende in considerazione forme di relazione nelle quali i soggetti coinvolti non sono egualmente liberi, uguali ed autonomi (ad esempio adulti-bambini, medico-paziente), mentre le nuove forme di potere che si affermano non sono riducibili a un rapporto di proprietà. Così il potere procreativo non configura, o almeno non dovrebbe configurare, un diritto soggettivo, giuridicamente garantito, alla maternità o alla paternità.
Stiamo assistendo a svolgimenti contraddittori propri di una crisi di sistema: crescita positiva degli ambiti di libertà degli individui ma difficoltà crescente a organizzare tale libertà, con il rischio di un ritorno pericoloso di tendenze reazionarie pronte a restaurare autoritariamente vincoli normativi.
Evocare la dignità a me sembra un richiamo a visioni più consapevoli della complessità che segna il cammino del progresso.
°°°L’autrice è stata a lungo docente universitaria di Storia delle dottrine politiche, parlamentare del Pd e tra le fondatrici del movimento femminista “Se non ora, quando?”