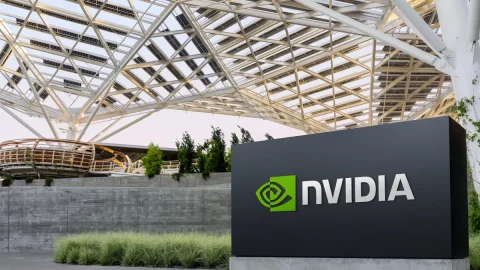Il nostro è un paese ben strano. Dopo 60 anni di dibattiti c’è ancora chi ritiene deleteria la presenza nella penisola di tante piccole aziende. E giù a lamentarsi della difficoltà di fare impresa non mancando di esibire classifiche internazionali la cui inconsistenza dovrebbe essere dimostrata dal semplice fatto che i registri camerali segnavano alla fine del marzo scorso oltre 6 milioni di ditte! Con nuove iscrizioni (nascite) di oltre 115 mila unità nel 2013 (dati Unioncamere). Anche di recente, in pregevoli programmi televisivi di largo ascolto, è capitato di sentire che i nostri problemi (per giunta “storici”) originano dalle pmi e dalla mancata crescita della loro produttività. Ma come è possibile che imprese non competitive si facciano carico di “tutto” il saldo commerciale attivo della nostra manifattura?
Recentemente ho avuto occasione di esporre le mie considerazioni in due convegni, il primo a Modena e il secondo al Senato della Repubblica. Il lettore trova allegate qui sotto le due presentazioni alle quali aggiungo solo pochi punti fermi:
1) La manifattura vede in Europa cinque grandi protagonisti: in ordine di volumi, Germania, Italia, Francia, Regno Unito e Spagna. Ognuno di loro produce ogni anno beni per più di 100 miliardi di euro; sono questi i paesi che servono nei confronti essendo inutile riferirsi ai “piccini” (ad esempio i pur bravi scandinavi). Ciò premesso, come si vede dalla prima slide proiettata in Senato, è assai chiaro che in Europa i “modi” di produrre differiscono soprattutto per la dimensione prevalente delle imprese. In altre parole, è possibile essere “grandi” nella manifattura operando con imprese di grande taglia (vedi Svizzera, che però conta poco, e Germania, dove peraltro esiste un corposo Mittelstand che somiglia assai al nostro Quarto capitalismo), oppure con piccole aziende (Italia e Spagna); la Francia sta a metà strada.
2) Perché mai le imprese piccole sono competitive in Italia (visto che è più di mezzo secolo che si ostinano a non morire)? E’ l’effetto distretto, bellezza, verrebbe da dire chiosando i finanzieri di Wall Street! La concentrazione produttiva in alcuni luoghi e la divisione del lavoro in fasi collegate in filiera consentono economie “esterne all’impresa”, ma “interne al luogo”, che minimizzano i costi esattamente come avveniva nella vecchia fabbrica automobilistica di Henry Ford; ma oggi la stessa impresa fordista è tramontata avendo imparato dalla Toyota ad integrarsi con i fornitori per ridurre il fabbisogno finanziario. Ma i nostri distretti hanno in più i contesti sociali che rendono i “luoghi” autentici laboratori di innovazione dove si inventano nuovi prodotti e nuovi modi di produrli. Pensate al modenese per i motori, alla Riviera del Brenta e all’ascolano-maceratese per le calzature, al veronese dove sopravvive assai migliorata l’azienda del figlio di Dante Alighieri che produce Amarone, uno dei migliori vini nazionali (v. Rapporto 2014 dell’Osservatorio Nazionale Distretti italiani).
3) E’ vero che l’Italia va male perché è entrata nell’eurozona? Per rispondere occorre maneggiare con cura le statistiche e soprattutto i raffronti internazionali. L’Italia è stata a lungo penalizzata da tecniche di calcolo del Pil inappropriate e comunque disomogenee rispetto agli altri paesi (rinvio al mio saggio su European Planning Studies del dicembre scorso per i dettagli). Il modo migliore di stabilire se andiamo meglio o peggio è quello di vederci “in rapporto” agli altri principali competitor (cioè Germania, Francia, Regno Unito e Spagna). Nelle due relazioni allegate vi è una slide assai indicativa. Nei primi anni dell’euro la nostra manifattura ha accresciuto il suo peso e non poteva essere altrimenti. In un mercato internazionale più fluido, più esteso e più raggiungibile grazie ai progressi delle comunicazioni le nostre “piccole” imprese (meglio, i nostri sistemi distrettuali e del Quarto capitalismo) hanno raccolto successi innegabili. Il massimo peso lo abbiamo raggiunto nel 2009, proprio il primo anno dopo la grande crisi finanziaria. Cosa è successo dopo? La crisi dei debiti sovrani ha rallentato lo sviluppo di molti paesi, con l’aggravante di (errate) politiche restrittive imposte dai Commissari Ue. E’ rincarato il denaro, ma soprattutto il credito è divenuto molto più scarso. Le banche hanno razionato la clientela senza rendersi conto che stavano uccidendo la loro vera fonte di reddito e cioè le imprese; oggi cercano di riparare chiedendo risorse ai loro azionisti per ricostituire la proporzione del capitale deteriorato dalle stesse difficoltà dei clienti di cui in molti casi sono responsabili. Crisi, cassa integrazione, fallimenti, moltissimi a seguito di richieste di rientro dettate da un sistema bancario (tutti allineati, banca centrale compresa) incapace di interpretare forze e debolezze del nostro apparato produttivo ci hanno spinto sempre più in basso. Il punto di minimo lo abbiamo toccato nel terzo trimestre 2013 e oggi stiamo ancora sul fondo del burrone, nonostante le “luci” fuori dal tunnel che alcuni governi precedenti a quello di Matteo Renzi affermavano di intravedere con una certa sicurezza.
4) E’ vero che siamo meno produttivi degli altri paesi? I raffronti vanno effettuati su basi omogenee. Nel Quarto capitalismo (che insieme con i distretti copre circa i tre quarti della nostra produzione manifatturiera) non è certo così come dimostrano le analisi dell’Area Studi di Mediobanca. Non solo abbiamo livelli di produttività comparabili (ovviamente misurando “a valore” le produzioni), ma godiamo di un vantaggio sul costo del lavoro. I nostri margini (ovvero, la nostra competitività) sono superiori persino a quelli tedeschi. E non poteva essere altrimenti se è vero che nel 2013 le aree distrettuali hanno battuto il record di saldo attivo commerciale verso l’estero. Ma cosa ci manca per battere la Germania? Il nostro Quarto capitalismo affronta con successo il loro Mittelstand. Lo svantaggio sta tutto nelle grandi imprese: la vera sfida per il Governo attuale è farle tornare indietro (visto che in gran parte hanno delocalizzato) e attrarre investimenti di multinazionali estere. Ma prima, riferendosi ai nostri “grandi” imprenditori, serve una profonda conversione culturale: la chiave del successo di un paese avanzato, quale deve essere il nostro, sta nel puntare su una competitività da ricavi e non da costi. E’ il principio alla base delle imprese del Quarto capitalismo (rimando alla verifica econometrica eseguita con Daniela Venanzi che sarà nel libro “I nuovi distretti industriali” curato per il Mulino da Marco Bellandi e Annalisa Caloffi).
5) E’ vero che l’Italia è vittima di un ritardato aggiustamento alla globalizzazione? Per rispondere in modo appropriato basta guardare alla dinamica del fatturato della nostra industria: cade o ristagna quello verso il mercato interno e cresce quello verso l’estero. Dunque, contrariamente a quanto molti affermano, è una grande fortuna che questi nostri sistemi di piccole imprese siano stati capaci di “aggiustarsi” al meglio. E il Quarto capitalismo non è un fenomeno di “qualche” impresa di successo: è la vera novità degli ultimi venti anni, una precisa evoluzione delle aree distrettuali nel contesto della stessa globalizzazione. Ma restano molti problemi. Keynes ci ha dimostrato che un’economia può restare in equilibrio anche in condizioni di sottoccupazione (è il nostro caso). Occorre perciò “spingerla” con politiche appropriate se si vuole farla ripartire per dare lavoro ai molti disoccupati che abbiamo. Con Lino Mastromarino abbiamo messo a punto una proposta metodologica di politica attiva incentrata su un piano strategico (v. Relazione in Senato e il saggio che sarà pubblicato a breve nel seguito del Rapporto 2014 sui distretti “Idee, esperienze e progetti per rafforzare o ricostruire la competitività dei territori”). Tengo a precisare che occorre darsi una metodologia: se rilancio deve esserci, le “spinte” debbono valere per i territori che restano promettenti, ma che richiedono ristrutturazioni e riconversioni. Inutile disperdere gli incentivi, ad esempio attraverso un credito d’imposta rilasciato a chiunque. La regola deve essere quella dell’ “imprenditore intelligente”: non disperdere risorse scarse, concentrarsi sulle attività di maggior successo, verificare attentamente i risultati ex-post (pratica questa che le amministrazioni pubbliche non conoscono). Per condurre politiche attive servono strumenti capaci di sostenere (e attrarre) le imprese e di incidere sui territori. In questa prospettiva, il ruolo delle camere di commercio andrebbe rafforzato e riqualificato.
Chiudo con il titolo di questa riflessione: il nostro è essenzialmente un problema di cultura. Non resta che augurarsi che si interrompa finalmente la decadenza della nostra classe dirigente.