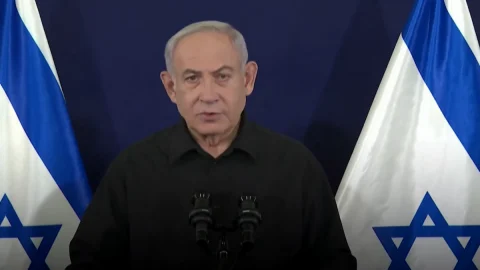Arriva nei negozi online di libri e nelle librerie il saggio di Heidrun Friese dal titolo “Limiti dell’ospitalità. I profughi di Lampedusa e la questione europea”, edito da goWare e tradotto dal tedesco da Tiziano Tanzini, che vive in Germania da oltre un trentennio. La studiosa tedesca conosce molto bene l’Italia, dove risiede da oltre vent’anni pur continuando la sua attività accademica e pubblicistica in Germania e in tutt’Europa.
Quelle che si affronta in questo libro sono tematiche alle quali la Friese lavora da più di tre decenni (il primo lavoro sul campo a Lampedusa è del 1986) e che ha avuto modo di approfondire, a più riprese, attraverso la collaborazione con Università e istituzioni sparse in tutta Europa delle quali l’autrice fornisce un lungo e dettagliato elenco.
Si tratta di un lavoro meditato e originale con un respiro e una conoscenza dei fatti che rincuora nei confronti con l’attuale deprimente dibattito politico europeo sull’immigrazione, l’ospitalità e la mobilità.
Di seguito offriamo un ampio stralcio che costituisce proprio l’inizio del libro dove l’autrice racconta i suoi primi contatti con Lampedusa, con gli harragas e con il fenomeno degli sbarchi clandestini.
Arrivo a Lampedusa
1986 Lampedusa. Sono arrivata per la prima volta su questa minuscola isola — dispersa tra la Sicilia e la Tunisia e, a quel tempo, sconosciuta ai più — circa vent’anni fa. A Lampedusa ho vissuto un anno perché volevo ricostruire la storia degli insediamenti umani che vi si erano succeduti.
Ma Lampedusa era arrivata sulle prime pagine dei giornali molto prima, nell’aprile 1986 in seguito al (presunto) lancio da parte di Mu’ammar al-Gheddafi di due missili Scud che sarebbero stati diretti contro la base americana LORAN di stanza sull’isola. Nessuno aveva subito danni. Ma la popolazione dell’isola si trovò unita nella protesta perché il Presidente degli Stati Uniti, Reagan, aveva fatto bombardare Tripoli e Bengasi come rappresaglia per l’attentato alla discoteca La Belle di Berlino.
Le storie delle “periferie” d’Europa sono collegate a luoghi e a interessi geopolitici, annidati altrove ed eterogenei, nonché alla storia mondiale. E tuttavia i loro destini si intrecciano anche ai resoconti dei media globali che diffondono nel mondo le immagini di Lampedusa (in seguito ai quali degli italiani del Nord scoprirono l’isola come meta turistica, alcuni terreni comunali cominciarono a essere venduti a privati per costruirvi case estive. Qualcuno ci guadagnò: anche parecchio).
Poi, a partire dagli anni ’90, Lampedusa è divenuta una tappa obbligatoria per coloro che, provenendo dai Paesi del Maghreb, dagli Stati subsahariani o dal Corno d’Africa, erano in cammino verso l’Europa: proprio lì, infatti, si incrociano vie che tuttora collegano vari territori ex coloniali e il Mar Mediterraneo, al deserto e alle altre regioni del mondo.
Benché la maggior parte dei “senza-documenti” giunga in Italia con normali, e poco spettacolari, visti turistici per poi scivolare nell’illegalità e divenire “invisibili” (nel vero senso della parola, proprio perché clandestini*, non appena scadono i visti) — le immagini drammatiche di persone sfinite che, più morte che vive, riescono a raggiungere Lampedusa a bordo di precarie imbarcazioni colme fino all’inverosimile, rafforzano nell’immaginario sociale e politico l’idea di una mobilità clandestina che, assumendo forme di catastrofe umanitaria o di minaccioso assalto a un benessere europeo, che si starebbe esaurendo, rivendica però non solo drastiche misure contro i “mercanti di uomini” ma pretende anche uno stato di emergenza permanente.
Ritorno nel 2007
Sono tornata sull’isola nel 2007 per investigare una delle frontiere dell’ospitalità europea e osservare i mutamenti avvenuti negli ultimi anni a livello locale. L’accoglienza degli impiegati, e non solo negli uffici amministrativi del Comune, era ora mista a sospiri di sopportazione: per qualche tempo, infatti, l’ufficio avrebbe dovuto essere di nuovo condiviso con la tedesca smaniosa, in nome della scienza, di gettare occhiate curiose in ogni tipo di documento e di copiare per settimane registri polverosi e, forse chissà, anche segreti d’ufficio, (per poi magari contraccambiare l’ospitalità con statistiche e tabelle tridimensionali sui mutamenti della struttura sociale o sugli arrivi di passeggeri per via aerea).
Molto era rimasto immutato: l’ufficio tecnico, seguitava a essere un importante centro di potere e anche il tessuto politico continuava ad essere quello di sempre. Eppure, qualcosa era cambiato: le famiglie non vivevano più principalmente di pesca e di lavorazione del pesce, ma di turismo che, nei mesi estivi, riusciva a portare sull’isola fino a 50.000 villeggianti.
Orti e giardini si erano arricchiti di appartamenti estivi; nel paesaggio brullo erano spuntate numerose villette. La popolazione era salita ufficialmente a 6.000 abitanti. Lampedusa era divenuta “multiculturale”, aveva accolto famiglie provenienti dallo Sri Lanka, dal Pakistan, dal Marocco, dalla Tunisia, dalla Romania e dalla Bulgaria, famiglie che traevano i mezzi per vivere prestando servizi e assistendo gli anziani. “Non sono mica prostitute” assicurava immediatamente il sindaco di allora, e aggiungeva “Chi vuole lavorare, qui è il benvenuto”, accoppiando l’ospitalità al lavoro in modo da dissipare possibili accuse di razzismo.
Nel frattempo era sorto nell’isola anche un centro di accoglienza (Centro di Soccorso e Prima Accoglienza, CSPA) per i nuovi arrivati senza documenti e che occupava ormai 150 dipendenti circa. Intorno a questa struttura si erano coagulati anche nuovi interessi economici, congeniali all’attivazione di nuove e vecchie reti clientelari.
L’Hospitality Industry
Lampedusa è divenuto il crocevia tra forme di mobilità desiderate e altre indesiderate, e vive ormai di persone mobili e di “Hospitality Industry”. Secondo il Ministero dell’Interno italiano, tra il 2000 e il 2009, sono sbarcate a Lampedusa circa 111.000 persone senza documenti. Nel 2016, 181.436 persone, nel 2017, 119.369 e fino al 19 febbraio 2018, 4.864 persone avevano raggiunto le coste italiane.
La maggior parte di esse proveniva dal Maghreb o aveva già alle spalle lunghi viaggi da paesi subsahariani o dal Corno d’Africa. La politica italiana ha cercato, anche attraverso l’accordo di amicizia con il dittatore libico del 2008, di interrompere questi flussi e di chiudere la via del mare. Il numero di coloro che, in seguito a ciò, sono riusciti a valicare la frontiera marittima italiana è drammaticamente diminuito.
La politica era riuscita — almeno per qualche tempo — a modificare le rotte, il mio campo d’indagine si era spostato e io avevo l’impressione di perdere di vista il problema originario e di lavorare, invece, a una sorta di “antropologia storica” dell’isola (Friese, 1996).
Chi mi conosceva, ora mi accoglieva segnalandomi che “al bar del porto c’è uno studioso che conosce il tuo libro”. Chi non mi conosceva, si informava chiedendomi: “Sei giornalista?”, sottintendendo: “Vuoi piantar grane?”. Il discorso scientifico e il discorso mediale si erano incuneati nelle relazioni umane e nell’immagine di sé: Lampedusa era diventata uno dei simboli della gestione europea dei confini, quella cioè che detta anche i confini dell’ospitalità.
Tunisi
2009, Tunisi. Volevo conoscere i posti della Tunisia dai quali partivano le barche. Ho incontrato Tariq e i suoi amici nell’estate del 2009 — al tempo del dittatore Zine elAbidine Ben Ali — in un bar di Tunisi. Le donne, in realtà, sarebbero state fuori posto in quei territori maschili. Un amico siciliano (che si ricordava di me e della mia prima ricerca sul campo degli anni ’80 in un villaggio siciliano, benché fosse, allora, solo un bambino) aveva intanto trovato lavoro a Tunisi, conosceva ogni bar e ogni spia del regime, mi presentava come sua zia, permettendomi di superare indenne i più severi controlli.
La sua presenza maschile e la mia età garantivano una certa immunità. Offrivo sigarette e birra, conversavamo Arriva nei negozi online talora nel retrobottega tra casse di bibite.
Quando un bar chiudeva, ci si spostava in un altro e così, poco a poco, cominciammo a conoscerci attraverso le nostre storie. Quanti coetanei di Tariq e dei suoi amici erano disoccupati e sopravvivevano alla giornata! “Siamo nella merda” esclamava quasi sempre alla fine dei suoi ragionamenti. Tariq viveva a casa della sua famiglia. Il padre lavorava in una piccola fabbrica e “sperpera tutti i soldi con altre donne” aggiungeva Tariq irrispettosamente, alludendo forse anche alla perdita di autorità di una generazione che aveva ben altre idee su cosa fosse un’esistenza degna di questo nome.
Pur legatissimo a sua madre e a suo fratello dodicenne, passava il tempo aspettando l’occasione propizia per sfuggire a quella vita vissuta male; pur essendo lì, era al tempo stesso già del tutto altrove. Il fratello maggiore di Tariq non aveva voluto attendere. Era annegato in mare l’anno prima nel tentativo di fuggire verso Lampedusa, verso l’Europa.
Grazie all’aiuto di persone appartenenti alla Guardia Costiera, era sicuro di farcela. Invece, non ce l’aveva fatta e il mare ne aveva rigettato il cadavere sulla spiaggia. Quante volte Tariq mi ha mostrato il tatuaggio “A MIO FRATELLO” e i suoi avambracci segnati dai tagli dell’autolesionismo, l’uno e gli altri espressione della sofferenza e del lutto per la perdita del fratello. Ogni volta che raccontava questa storia, gli occhi gli si riempivano di lacrime, incapace di articolare parole. Ogni volta, mi sentivo impotente. Per caso ho un passaporto europeo; per caso, sono nata sul lato privilegiato del Mediterraneo; per caso, non mi servono visti per entrare in Tunisia.
Gli harragas
Proprio a causa delle pressioni politiche esercitate sui paesi delle excolonie europee del Mediterraneo, l’espatrio senza visto dagli Stati del Maghreb è ora un reato e viene perseguito penalmente in Marocco (dal 2003), in Algeria (dal 2008) e in Tunisia (dal 2004). Ciò che gli europei sentono ormai come una cosa ovvia, cioè la libera circolazione, viene ad altri impedito dall’accordo di Schengen e dai regolamenti sui visti, costringendo una moltitudine di persone a rischiare la vita nella traversata.
Nonostante il suo lutto e la consapevolezza dei rischi mortali, Tariq e i suoi amici (come anche molti loro coetanei in Tunisia, Algeria e Marocco) volevano approfittare della prima occasione per fuggire in Europa. Harga: così si chiama nel Maghreb questo ardente desiderio. Harga significa “bruciare, ardere” e gli harragas sono coloro che bruciano i propri documenti, che calpestano le regole e che, da veri uomini, prendono in mano il proprio destino e inseguono il proprio diritto alla dignità e alla libertà.
Praticamente nessuno di essi aveva un “progetto di emigrazione” in qualche modo pianificato e neppure un’idea precisa di come sarebbero andate avanti le cose una volta giunto in Europa. Harga è uno spazio dinamico d’immaginazione e di azione di uomini giovani, che non è possibile ridurre a motivazioni puramente economiche. Tariq e i suoi amici si affidavano a sogni e visioni di un Altrove, immaginario ma “che penetrava in profondità”, e vivevano contemporaneamente in due mondi diversi.
Presidiata da condizioni sociali che permettono così poco da rendere addirittura probabile la partenza, questo presente si nutre in continuazione delle immagini e delle proiezioni di una vita diversa. La mobilità prende avvio nell’immaginazione: “Indeed, from the moment that the departure is imagined and the desire enunciated, the subject is transformed into someone that is alwaysal ready elsewhere” (Alaoui 2009:7). Le speranze di cambiare le condizioni di vita sono diventate, per Tariq e i suoi amici, una situazione di “attesa senza fine e senza prospettive” (Boltanski 2011:121), uno stato di sospensione tra un qui e un lì, una presenza bloccata e congelata. L’attesa non si limita solo a sottolineare la “dipendenza dalle decisioni e dal benestare di altri”, che hanno il potere di decidere “sull’accesso a un minimo di condizioni di vita accettabili” (2011:60): essa genera anche una particolare struttura del tempo perché il futuro avviene nell’immaginazione, in un altro luogo.
La speranza dell’Europa
L’Europa diviene un segno di speranza anche se questo futuro in Europa sarà anch’esso caratterizzato da disoccupazione, marginalizzazione ed esclusione. Giunti in Italia, Tariq e i suoi amici da harragas diventeranno clandestini, una designazione che sottolinea le pratiche politiche e giuridiche dell’illegalità e che già mostra ciò che sarà un aspetto specifico della futura vita quotidiana: il fatto cioè di diventare “invisibile”, di non dare nell’occhio.
“Non avrei mai sgobbato per tre spiccioli, come mio padre”, ripeteva Tariq tra l’assenso degli amici. Nella desolante attesa quotidiana, ognuno di essi aveva aspettative diverse da quelle degli altri ma tutti erano assolutamente certi che in Europa ce l’avrebbero fatta, che sarebbero stati all’altezza della loro aspirazione alla dignità, che avrebbero ottenuto la loro parte di benessere e dimostrato di essere uomini: un buon lavoro, un’auto, un DVDplayer e lo schermo al plasma.
Nessuno avrebbe mai potuto immaginare la spossatezza che si sarebbe impadronita di loro, braccianti senza alcun diritto, nelle campagne della Sicilia, della Calabria, della Puglia per un paio di euro l’ora, o la necessità, come sanspapiers in Francia, di eludere ogni giorno la polizia. Mi avevano promesso di copiarmi un CD del rapper RimK e del musicista raï Reda Taliani nel quale era inciso Partir loin, l’inno degli harragas del Maghreb, un inno cliccato milioni di volte su YouTube.
L’anelito a una vita diversa non sarà più diffuso solo da emittenti europee, che trasmettono immagini di società ricche, libere, trasgressive, né sarà più influenzato da chi rientra per il Ramadan trascinando nelle città e nei paesini del Maghreb le testimonianze concrete di un progetto migratorio riuscito. I siti, i blog gli spazi dedicati di Facebook, Twitter, YouTube, per citarne alcuni, si sono ritagliati un ruolo importante non solo nella mobilitazione politica.
La cultura della fuga
La sensazione di vivere in condizioni precarie e senza prospettive e il desiderio di una vita diversa sono nel frattempo divenuti gli ingredienti di una cultura giovanile transnazionale, di cui sono i simboli e le semantiche, rielaborati creativamente anche nella musica popolare raï e rap, spazi — ormai — d’intesa quotidiana sulla situazione contingente, capaci di mobilitare l’immaginazione. Non so esattamente in che senso Tariq e i suoi amici abbiano inteso il mio interesse alle loro storie, agli affari “illegali” e alla musica: avrei potuto essere la loro nonna, non corrispondevo a nessun normale cliché femminile e non ero interessata neppure all’amour (sulla ricca signora europea, alle cui spalle è possibile una vita lussuosa in un’abbondanza da favola, si rincorrono le storie più fantastiche).
“Illegalità’, harga e atteggiamenti di rottura con le convenzioni si sono sempre aggirati nelle nostre conversazioni. Speranze di libertà individuale, di libertà dalle pastoie familiari e dalle regole della morale pubblica, angherie poliziesche e infine, non meno importante, la pressione di gruppo (spesso si mettono insieme amici o vicini di un villaggio, per iniziative comuni) alimentano l’immaginazione e svuotano i bar e caffè in cui si attende una vita diversa. “Meglio morire che restare qui”: si è imposta una vera e propria cultura della fuga.
Tunisi 2012. Nel quadro di ciò che si chiama ormai “ricerca sul campo multisited”, mi sono nuovamente recata a Tunisi. Lì ho anche partecipato, il 14 gennaio, alle dimostrazioni per festeggiare il primo anniversario della rivoluzione. “La Tunisia è libera” (Tounis hurra), “Il popolo vuole […]” (al’sha’b yureed) erano slogan e graffiti che esprimevano ciò che noi chiamiamo, in modo un po’ asettico, la sfera pubblica. I pescatori, che, durante i giorni turbolenti della rivoluzione, avevano protetto porti e imbarcazioni da eventuali “sovversivi esterni”, acclamavano ora la deposizione di “ZABA” (Ben Ali) e della “parrucchiera”, come veniva chiamata con disprezzo sua moglie.
E, come sempre, molti harragas continuavano ad aspettare la prima buona occasione per evadere da quello stato di cose e a cercare il modo di raggiungere l’Europa… per 1.000 euro di “tassa sul visto”.
L’autrice
Heidrun Friese è professore di Comunicazione Interculturale e di Teoria della Cultura all’Università (TU) di Chemnitz. Ha insegnato e diretto progetti di ricerca alla Humboldt-Universität di Berlino, all’École des hautes études en sciences sociales (Parigi), all’Istituto Universitario Europeo, IUE (Firenze), alla University of Warwick, all’Università Ebraica di Gerusalemme, alla University of California (Berkeley), all’Istituto HyperWerk (Basilea). I suoi studi si estendono dalle teorie sociali e della cultura, alle prospettive postcoloniali, alla mobilità (fuga, migrazione, e pratiche transnazionali) e comprendono le problematiche sull’identità (culturale) in riferimento soprattutto alla zona del Mediterraneo. Ha condotto ricerche pluriennali sul campo, tra l’altro, a Racalmuto e a Lampedusa.