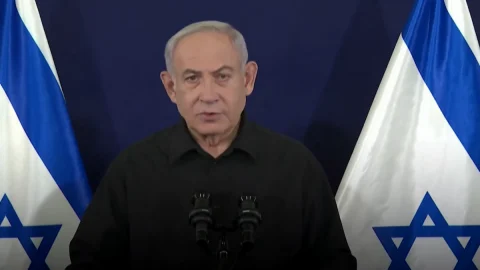Non sono mai stato comunista. Ma ho avuto tanti amici militanti del PCI che ammiravo sinceramente per l’impegno culturale e politico, anche se non ho mai capito bene come si faceva a dirsi comunisti di fronte agli evidenti fallimenti di quei regimi.
Claudio Petruccioli – esponente storico del PCI, e uno degli artefici della svolta della Bolognina – nel 2001 pubblicò un “Rendiconto“ che già allora non si sottraeva a nessuno dei temi scottanti del comunismo italiano. La nuova edizione, aggiornata e arricchita, di “Rendiconto – La sinistra italiana dal PCI a oggi” (edizioni La Nave di Teseo), offre risposte convincenti su tre piani: su quello, per così dire antropologico, che riguarda i caratteri tipici del militante comunista, sulla storia di un quinquennio cruciale (dal 1989 al 1994) non solo per il PCI ma per l’intera democrazia italiana, e infine sui caratteri e le contraddizioni della sinistra di oggi e in particolare del PD ancora in mezzo al guado tra salvataggio del vecchio stile comunista e avvio di una nuova costruzione politica.
L’adesione al PCI, almeno dalla fine degli anni Sessanta, non era principalmente motivata dall’ideologia e tantomeno dal mito della rivoluzione di ottobre e dal funzionamento del socialismo reale, ma dal fatto che il partito era un luogo di vita sociale oltre che politica, di identificazione, di sicurezza psicologica ed esistenziale. I comunisti italiani non solo si sentivano dalla parte giusta della storia, ma grazie alla vita di partito, si distinguevano dalla chiusura e dalle grettezze piccolo borghesi. Era una specie di mondo parallelo: chi vi apparteneva poteva viaggiare in tutta Italia e all’estero (almeno in Occidente) stando sempre dentro una rete di accoglienza, una trama di rapporti e di amicizie che univa all’interno e distingueva dall’esterno. Ricordo ancora che, nel 1980, quando arrivai come capo redattore a Il Mattino di Napoli, Antonio Bassolino, allora segretario regionale campano del PCI, volle incontrarmi di prima mattina in un bar di periferia perché “non sta bene – mi spiegò – farsi vedere con un giornalista borghese”.
Ma questa separatezza portava a chiudere gli occhi di fronte a quanto accadeva nel mondo esterno. Già era stato arduo giustificare la repressione in Ungheria nel ‘56 e quella in Cecoslovacchia nel ‘68. Agghiaccianti poi sono state certe reazioni di intellettuali vicini al partito e di tanti vecchi dirigenti che avevano passato parte della giovinezza in URSS, al momento del crollo del muro di Berlino che trascinava sotto le sue macerie tutti i regimi dei paesi dell’Est europeo che si reggevano solo grazie ai carri armati dell’Armata Rossa. Il regista Nanni Loy disse, in un convegno, che i cittadini della Germania Est che si riversavano dall’altra parte “credono che l’acquisto di un frullatore sia la libertà“.
Giancarlo Pajetta rimase sconvolto dai fatti del 1989: la sua mente si rifiutava di accettare quanto era accaduto. Si lamentò perché Piero Fassino era andato a visitare a Parigi la tomba di Imre Nagy, primo ministro ungherese ucciso dai comunisti, e difendeva ancora Ceausescu pochi giorni prima del disfacimento totale del suo regime. Alessandro Natta, che era stato segretario del PCI dalla morte di Berlinguer al 1988, prese il crollo del muro come una sventura e disse che era come se avesse vinto Hitler.
Da queste reazioni si comprende cosa voglia dire essere stato comunista in Italia e le cause del mancato compimento della svolta impressa da Achille Occhetto al PCI dopo il crollo del muro di Berlino. Negli sconvolgenti avvenimenti, che mettevano fine ai regimi dell’est europeo, molti vedevano l’occasione per dar vita a una nuova sinistra, capace di abbandonare le vecchie ipocrisie e la classica doppiezza togliattiana del PCI, per aprirsi non solo ai partiti socialisti ma alle altre forze liberal progressiste, con l’intento di offrire una vera alternativa agli oltre quarant’anni di gestione democristiana del potere. Altri invece ci vedevano un modo per svoltare salvando il passato, salvaguardando l’organizzazione partitica esistente, conservando la capacità di essere rivoluzionari a parole e gestori di fette di potere nella pratica.
Furono questi ultimi a vincere, capeggiati da Massimo D’Alema che offrì un punto d’appoggio al gruppo dirigente per perpetuare il suo potere anche avvicinandosi all’area di governo. Di qui poi il prevalere della conservazione perfino nelle ultime mutazioni, quel considerare sempre il partito come la propria “ditta“ – definizione di Pierluigi Bersani – da cui andavano estromessi i corpi estranei, come Matteo Renzi che pure era stata più volte votato alle primarie dalla stragrande maggioranza degli elettori del PD. Insomma il popolo elettore era pronto alla svolta, ma erano i dirigenti che frenavano la voglia di novità, accusando i nuovi (quelli che non potevano vantare la nobiltà comunista) di non essere di sinistra. Renzi fu visto come un infiltrato, uno che se l’intendeva con il nemico (e infatti lodava Marchionne), uno che voleva fare le riforme istituzionali il che, secondo la sinistra tradizionale, equivale ad un colpo di stato, a un pericolo per la democrazia.
Proprio qui sta il problema italiano. Il fallimento della sequela PCI-PDS-DS-PD nel portare a compimento la svolta originata dalla caduta del muro di Berlino. Nel contempo l’incapacità della novità berlusconiana di dar vita a un vero partito liberale di massa. Infatti, dopo il crollo dei partiti tradizionali della Prima Repubblica, si sarebbe dovuti approdare non solo a nuove formazioni politiche, ma anche a un modello costituzionale diverso, basato sull’alternanza al governo, e su un assetto istituzionale capace di offrire ai cittadini una democrazia governante, efficiente e trasparente.
Nel quinquennio ‘89-‘94, dalla caduta del muro di Berlino al Governo Ciampi, si accavallarono gli avvenimenti che avrebbero potuto portare a disegnare un nuovo futuro per l’intero paese. Purtroppo dalle ceneri del PCI non riuscì a nascere una sinistra diversa, capace di dare una lettura nuova e originale della realtà mondiale e quindi di fare proposte insieme ideali e concrete e non utopistiche, come quelle dell’uomo nuovo nato dal superamento dell’assetto capitalistico. Insomma una sinistra capace di capire che tanti vecchi arnesi ideologici non servivano più. Che il concetto di capitalismo non ci dice più nulla essendoci tanti capitalismi alcuni più politici, altri più di mercato. Che il Governo non è sovrastruttura dei padroni, ma è quello che dirige il gioco. Altro che accusare Renzi di parteggiare per Marchionne! Ma proprio perché il manager venuto dall’America cercava di svegliare il sonnacchioso capitalismo nostrano accucciato tra Stato e Mediobanca, avrebbe dovuto essere un alleato contro la vecchia ideologia sindacale di Maurizio Landini che difendeva tutto il passato.
Questo rimanere ancorati alla vecchia “Ditta”, ha portato alla diffusione di una profonda insoddisfazione per la politica. I cittadini si aggrappano con la forza della disperazione a movimenti nuovi e improvvisati. Ma sono pronti ad abbandonarli al primo accenno di delusione. È evidente che l’eccessiva mobilità elettorale segnala che c’è – come dice Petruccioli – una sfasatura tra domanda e offerta politica. Occorre cioè creare forze politiche capaci di offrire soluzioni alle paure e prospettive di crescita credibili, senza rifugiarsi nel passato, senza puntare a destra sull’autarchia e sul sovranismo, e a sinistra su vecchie ricette di statalismo e di assistenzialismo che hanno già fallito nella loro applicazione storica. Purtroppo non si vede chi sia in grado di superare il quotidiano tirare a campare, per proporre una visione del futuro realistica e credibile intorno alla quale mobilitare le energie dei cittadini. Il cambio di passo dell’Europa con la ritrovata solidarietà e le risorse finanziarie messe a disposizione potrebbero essere l’occasione di un rinnovamento politico?