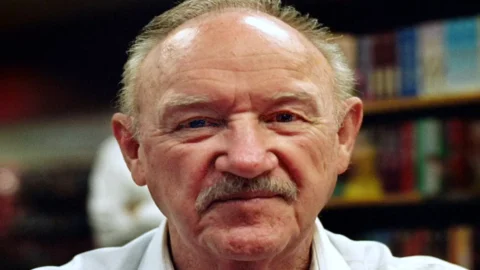“Era il tempo migliore e il tempo peggiore, la stagione della saggezza e la stagione della follia, l’epoca della fede e l’epoca dell’incredulità. Il periodo della luce e il periodo delle tenebre, la primavera della speranza e l’inverno della disperazione. Avevamo tutto dinanzi a noi, non avevamo nulla dinanzi a noi.” Si potranno, un giorno, usare le parole che Charles Dickens usa per raccontare gli anni della Rivoluzione francese e quelli immediatamente successivi del Regime del Terrore, per descrivere la nostra epoca? Il tempo che viviamo, schiacciato tra la rivoluzione tecnologica e il terrore della grande crisi economica, si potrebbe paragonare a quello?
Mervy King, l’ex Governatore della Banca d’Inghilterra, con il suo libro “La fine dell’alchimia”, è entrato nel vivo del dibattito sulla crisi che vive la nostra società con una posizione al riguardo molto netta che ha il pregio di arrivare al nocciolo della questione affermando che “questa non è una crisi delle banche o delle politiche – nonostante il sistema bancario debba essere ristrutturato e di certo la politica (economica e non) abbia fatto molti errori – bensì una crisi delle idee”. Che si tratti di una preoccupante crisi delle idee e, dunque, di crisi della cultura nel senso più ampio, è opinione che si sta facendo sempre più diffusa e apre così a un problema di portata enorme sulle cui origini e sulle possibili vie d’uscita, al contrario, troppo poco si indaga assecondando la facile vulgata che tutto riconduce alla contrapposizione tra popolo e populismo – dando di esso una valutazione poco importa se positiva o negativa – da una parte ed élite dall’altra.
Nel tentare di affrontare il tema senza fermarsi alla sua superficie, possono esserci d’aiuto le intuizioni che, quasi cento anni fa, ebbe il premio Nobel, T. S. Eliot definendo la cultura “religione incarnata” e strutturata su una gerarchia di classe indispensabile per la creazione e la conservazione, appunto, della “vera cultura”. Il concetto di classe di Eliot non prende in considerazione – è bene precisarlo – la funzione economica o politica ma è declinato in termini culturali quale condivisione di un modo di vivere acquisito attraverso la famiglia di appartenenza, la propria terra, la propria comunità, attraverso l’educazione, le attività del tempo libero, la partecipazione a forme associative su scala ridotta e di carattere personale. La classe offre alla persona il terreno più adatto affinché anche la sua creatività letteraria e artistica possano esprimersi al meglio.
Una cultura sana, è, dunque, secondo Eliot, sostenuta da una gerarchia di classe che realizza se stessa su due piani, uno relativamente incosciente – la cultura “popolare” e l’altro relativamente cosciente e riflessivo – “l’alta” cultura. Nel momento in cui una società diventa puramente secolare, si trasforma in società “livellatrice” – dal termine inglese “levelers” – dominata dall’élite producendo qualcosa di assai diverso dall’alta cultura e molto simile al mondo nel quale viviamo. I livellatori, mossi dalla più diverse e anche nobili motivazioni – uguaglianza o meritocrazia – si pongono l’obiettivo di distruggere la stratificazione delle classi ma, così facendo, inevitabilmente, distruggono anche l’intera vita dei nuclei familiari e delle comunità locali, dei valori e delle tradizioni. In poche parole la distruzione delle classi produce la distruzione della cultura della quale la società, così facendo, si priva necessariamente.
Dunque, per Eliot, una società puramente secolare e non religiosa che abbia “privatizzato” la religione relegandola al livello delle vite individuali è priva di cultura, è anti-culturale, allo stesso modo di una società che respinge le istituzioni sociali esistenti e invoca la loro sostituzione diventando così anch’essa parimenti anti-culturale. Si impone un’anti-cultura dell’élite che ignora totalmente la cultura popolare, si compiace nella profanazione del sacro, proponendosi trasgressiva contro la vita ordinaria e, anziché costruire sul passato, lo distrugge deliberatamente, proponendosi senza radici, senza alcuna coesione e continuità sociale, con l’unico collante dato dalla tecnica e dalla managerialità e dal supremo interesse dei “mercati”.
In questo, e contro questo, contesto andrebbe letto con una maggiore attenzione il diffondersi di quelli che, con un certo disprezzo e molto sbrigativamenti, vengono definiti “populismi”. Il populismo può essere, infatti, considerato una reazione ragionevole – seppur inconsapevole – al dominio delle élite e, dunque, alleato naturale del conservatorismo nella ricostruzione dell’alta cultura quale riarticolazione della cultura popolare su un piano più cosciente e riflessivo. Così inteso il populismo può svolgere un ruolo di eccezionale protagonismo nel tempo della crisi delle idee e nel deserto culturale prodotto dal dominio incontrastato – almeno fino ad oggi – delle élite.
Potrebbe farlo proprio ridando centralità a ciò che le comunità virtuali, le multinazionali, la grande finanza, Wall Street hanno tentato di distruggere: la famiglia, le comunità locali, le piccole imprese, le banche locali e del territorio. In questo cambio di passo, intellettuali, studiosi, critici, artisti, educatori, genitori potrebbero e dovrebbero tornate ad assumersi la responsabilità di trasmettere ai giovani la tradizione dell’alta cultura, riconoscendo che i prodotti dell’anti-cultura non sono utili per una società sana e intelligente. Se ciò accadrà, allora, come Dickens, potremmo dire che anche questo di oggi è stato “il tempo migliore e il tempo peggiore”.
°°° L’autore è il Segretario Generale dell’Associazione Nazionale fra le Banche Popolari (Assopopolari)