Da quando è nato il capitalismo è stato criticato perché fonte di diseguaglianze, di instabilità, di alienazione degli uomini costretti ad una competizione “innaturale”. Interi scaffali di qualsiasi libreria casalinga contengono volumi che si interrogano sul futuro del capitalismo. Non solo Marx ma anche Colletti e Napoleoni si interrogavano negli anni settanta sul futuro del capitalismo (crollo o sviluppo?) ed anche Soros, un diavolo per i populisti e i sovranisti di tutto il mondo, dichiara la “crisi del capitalismo globale”. Non molti hanno avuto il coraggio di parlare di “Capitalismo buono” come ha fatto Stefano Cingolani nel libro appena giunto nelle librerie edito dalla LUISS University Press, sottotitolato in maniera chiara “perché il mercato ci salverà”.
La crisi finanziaria del 2008-2009 non è stata ancora completamente assorbita non tanto dal punto di vista della crescita del PIL, quanto per il trauma psicologico che ha provocato spazzando via tante certezze sul futuro, generando sfiducia nel mercato e nella globalizzazione che avevano fatto tante promesse che alla prova dei fatti si sono dimostrate illusorie. A rincarare la dose è intervenuta l’epidemia di Coronavirus che ha messo a nudo l’incapacità delle nostre strutture sociali di prevenire e combattere con efficacia e immediatezza un evento straordinario. Il risultato è stato quello di una diffusa richiesta al potere politico dei vecchi Stati nazione (l’unico ancora esistente anche se un po’ ammaccato) di protezione, di controllo delle frontiere, di limiti alla globalizzazione per evitare di redistribuire il lavoro tra varie aree geografiche, di ritorno del pubblico nella gestione diretta delle imprese per sottrarle così alla concorrenza ritenuta eccessiva e quindi distruttiva, di aumento della funzione fiscale per combattere le diseguaglianze tramite la distribuzione di sussidi.
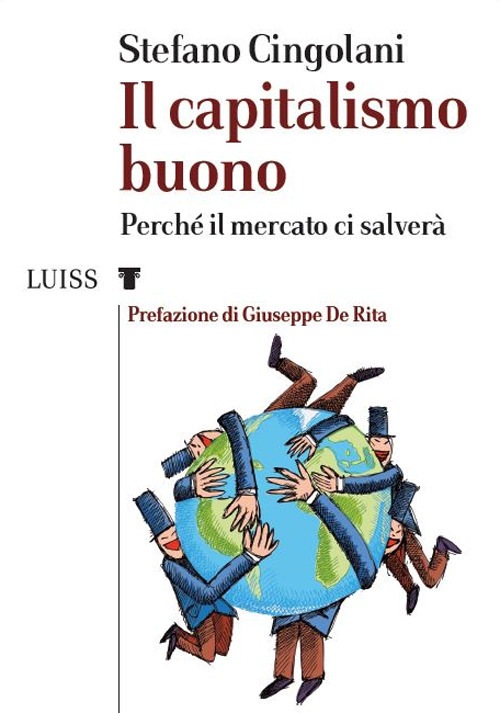
L’analisi di Cingolani consente in primo luogo di confutare i luoghi comuni più diffusi ma anche più errati sia politici che economici. Sotto il primo aspetto, ad esempio, si dimostra che i regimi autoritari o quelli dominati da un forte nazionalismo, come in Gran Bretagna, negli USA o in Cina, non sono stati affatto più efficienti delle democrazie liberali nel contrastare l’epidemia, ed anzi hanno commesso errori molto grandi con conseguenze tragiche sulla popolazione, come ad esempio in Brasile o nella stessa Russia.
Dal lato dell’economia tutte le ricette di chiusura autarchica, e di interventi massicci dello Stato nella gestione delle imprese, hanno già dimostrato in passato di ostacolare lo sviluppo del reddito dei cittadini, elargendo sicurezza in cambio di un progressivo impoverimento del paese e dei singoli, come del resto era avvenuto nell’ URSS comunista. Si rischia di creare come già avvenuto nel secolo scorso, un “ capitalismo Politico” che con la scusa di offrire barriere protettive contro l’incertezza dei mercati, mette in discussione anche le forme di democrazia liberale che, sia pure tra errori ed imperfezioni, hanno assicurato ampie libertà individuali e, almeno fino a qualche anno fa, un avanzamento economico e sociale che ha ben pochi precedenti nella storia dell’umanità.
Ora sicuramente la globalizzazione e certe forme di capitalismo basato sulle multinazionali a guida manageriale, sono andati incontro a notevoli problemi. Difficile dire se le crisi sono derivate da un eccesso di globalizzazione o da una sua carenza dovuta al contrasto tra le leggi rimaste per lo più nazionali e la mancanza di norme globali per dare regole alle aziende multinazionali. Ma quello che è sicuro, e la storia lo ha dimostrato, è che il pregio maggiore del capitalismo è la sua grande capacità di rinnovarsi, affrontare la distruzione creatrice, che abbandona vecchie aziende e vecchi schemi gestionali, a favore di nuove modalità di produzione e di vendita. Cambiano i riferimenti culturali, si modifica la domanda dei consumatori e subito nasce chi è capace di cogliere la novità. Lo Stato gestore per sua natura è conservatore: tende a conservare il vecchio, a soddisfare le richieste di stabilità provenienti dalla popolazione, a scapito del nuovo, della gestione del passaggio delle persone dai vecchi mestieri ai nuovi.
Oggi ci troviamo in bilico tra un senso comune che di fronte al pericolo tende a richiudersi entro fortezze ritenute robuste e una realtà dei fatti da cui si deduce che solo il capitalismo è capace di adattarsi rapidamente alle nuove richieste sociali ed economiche continuando ad assicurare la sopravvivenza della democrazia liberale e nello stesso tempo una adeguata crescita dell’economia. È chiaro che quando si ha paura il primo impulso è quello di accucciarsi in un posto ben protetto. Ma come insegnano i migliori manuali di arte della guerra, la “ miglior difesa è l’attacco”. E cioè se non riusciremo a trovare un assetto economico e politico capace di accompagnare e sostenere la trasformazione dell’economia e della cultura già in atto prima del virus, allora davvero saremo condannati al declino che le chiusure a difesa non solo non riusciranno ad evitare, ma che anzi saranno i decisivi fattori di accelerazione della decadenza.
Alla fine Cingolani si pone giustamente la domanda su chi sarà il nuovo driver di questa trasformazione che peraltro è già in atto ma che ora dovrebbe correre di più. Quale gruppo sociale prenderà la testa del processo trainando con forza tutta la società anche le parti più riottose. Non c’è ancora una risposta sicura a questa domanda. Si intravedono però alcune linee di tendenza che potrebbero prendere la testa del rinnovamento: si tratta non di una nuova e solitaria leadership politica, o di un rivoluzionario gruppo sociale che conquista la preminenza, ma di un processo orizzontale diffuso e che parte dal basso, ma che sulla base di una rete sempre più fitta di raccordi dovrebbe far muovere l’intera società nella direzione giusta. È un po’ un ritorno alla concertazione tra governo e parti sociali, come auspicato di molti. Potrebbe essere positivo, purché le parti sociali siano capaci di superare le loro chiusure corporativi e pensare in termini strategici, mostrare quella lungimiranza che tutti reclamano a gran voce, ma che pochi sono disposti ad applicare alle proprie cose.





