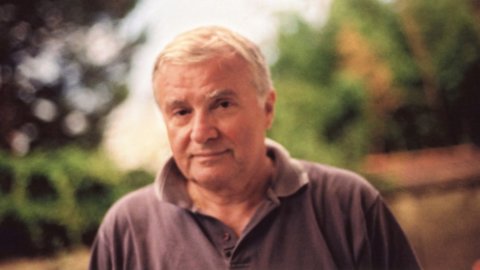Non si capiscono bene i temi, le presenze e i messaggi della convention virtuale del Partito democratico conclusa idealmente a Milwaukee il 20 agosto se non si hanno presenti prima di tutto alcune realtà di fondo della politica americana. La prima e più importante è che l’elettorato è diviso in tre blocchi: un quarto repubblicani sicuri, un terzo democratici tenaci, il resto cioè più del 40% indipendenti, divisi a loro volta in tre gruppi, quelli che tendono verso i repubblicani, quelli più sensibili ai democratici, e un 15-20% di indipendenti puri, disposti a passare senza esitazione da un partito all’altro.
E’ fra gli indipendenti che si gioca la vittoria o la sconfitta. Ed è chiaro quindi che se la fede progressista pura compatta un’ala importante del partito, troppo progressismo fa perdere voti dall’altro lato. Ben 206 contee per un totale di oltre 7 milioni di voti sparse in tutto il Paese ma concentrate nel Midwest a ovest e a nord-ovest di Chicago avevano votato Obama nel 2008, ancora Obama ma meno nel 2012, e votarono Trump nel 2016, e una manciata di queste gli concessero la risicata vittoria nel cruciale electoral vote.
Il secondo da tenere a mente fra i numerosi tratti fondamentali è che per ritrovare una maggioranza ai democratici nel voto dei blue collar di etnia bianca, voto operaio bianco diremmo noi in gergo europeo, occorre risalire a Lyndon B. Johnson, nel lontano 1964 l’ultimo candidato democratico a raccogliere la maggioranza di quel voto. Da allora i bianchi che si sono fermati a un diploma di high school o neppure quello, non hanno varcato la soglia di un’università e fanno un lavoro manuale o omologato, votano a netta maggioranza repubblicano.
Ed è fra loro, oltre che fra la costante corrente ultranazionalista che da almeno un secolo combatte il “cosmopolitismo” delle élite americane, e fra i gruppi ultrareligiosi protestanti e cattolici, che Trump ha trovato la sua base. Non si è inventato un elettorato che già c’era, lo ha solo coltivato e istigato. Trump ha raccolto così i frutti estremi della ormai ben più che conclusa fine della New Deal Coalition, quella composita alleanza messa insieme negli anni 30 dai democratici di Franklin Roosevelt su tre pilastri, i sindacati di una vasta area da Boston a New York a Chicago a St.Louis, le minoranze etniche, europee, dell’America industriale, e il voto rurale del Sud, razzista essenzialmente, ma anche populista, il tutto tenuto insieme dall’ostilità verso le élite finanziarie di New York, allora tutte o quasi repubblicane.
In Europa si tende a dimenticare che Roosevelt dovette, per vincere, sempre fare appello ai sudisti, in nome dei diritti del little man, che però a Sud e non solo era razzista. E infatti la legislazione dei diritti civili non si mosse con Roosevelt, che assumeva il più possibile usceri e autisti neri a Washington ma pensava al voto del Sud, e dovette aspettare Harry Truman, Dwight Eisenhower e soprattutto John Kennedy e Lyndon Johnson. E Johnson sapeva benissimo, e lo disse dopo il passaggio nel 1964 del Civil Rights Act, che il suo Sud (era texano) avrebbe lasciato il partito democratico.
Richard Nixon e soprattutto Ronald Reagan ne trassero grandi vantaggi, Bill Clinton recuperò a destra spostando il partito verso la prudenza sui temi sociali, Obama fu insieme un trionfo progressista, il primo afroamericano alla Casa Bianca, e una delusione per chi si aspettava di più anche come attacco all’establishment che invece Obama ha abbracciato. E alla fine Trump promettendo to flip the bird, di fare il gesto dell’ombrello a tutta Washington, ha capitalizzato su paure, risentimenti, sospetti. E razzismo.
“L’insicurezza a sfondo razzista è di gran lunga un metro più sicuro di previsione del supporto per Trump, più affidabile di qualsiasi altro fattore, compresa l’ansia economica”, dice il politologo Alan Abramowitz della Emory University di Atlanta, fra i maggiori esperti presidenziali. Trump la sta sfruttando a fondo: “Se volete violenza e saccheggi votate democratico”, ripete in questi giorni dopo un’estate di disordini. Questo tampona le falle enormi, lui spera, aperte dalla inadeguata risposta alla pandemia e dal conseguente crollo economico.
La partita per il 3 novembre 2020 è ancora aperta e, nonostante i sondaggi che favoriscono Biden ma oggi un po’ meno di ieri, piuttosto incerta. Peserà l’economia, se ci sarà a ottobre una netta ripresa o no; peserà una possibile recrudescenza del virus; conteranno molto, più del solito, i dibattiti tv. E’ molto probabile che il tutto finisca ai punti, come nel 2016. Pochi avevano visto per tempo allora che Trump aveva chances reali, date le dinamiche dell’elettorato. Oggi forse ne ha meno, causa pandemia, crollo dell’economia, e grazie alla sua deludente performance alla Casa Bianca. Biden può farcela, anche a 77 anni.
Ma non è assolutamente da prendere per scontato. La base di Trump, costruita attorno al sostegno del 60% circa dei non-college-educated whites, non si sgretola, anche se mostra cedimenti interessanti che in varie contee potrebbero fare la differenza. E’ una base comunque in netto declino numerico, scesa dal 52% dei votanti nel 2004 a poco più del 40% oggi. C’è inoltre l’indebolimento di Trump fra i college-educated, soprattutto donne. I repubblicani, che dal 1976 al 2016 hanno ricevuto in media circa il 55% del voto bianco contro il 39% circa dei democratici, hanno sempre più bisogno del voto bianco, e i democratici sempre meno, date le dinamiche della popolazione.
Quella della convenzione democratica è stata un’altra America, dell’apertura e dell’inclusione, senza terrore della fine della supremazia numerica dei bianchi, che secondo le previsioni statistiche ufficiali non saranno più con l’anno 2044 la maggioranza degli americani. E’ un modello che mira a comprendere nella cultura nazionale, essenzialmente bianca ed europea nei principi fondamentali della sfera socio- politica, milioni e milioni di persone di altro colore che sono e vogliono essere americani come tutti.
E’ una visione del futuro. Trump, come molti suoi sostenitori, confonde futuro e passato. La convenzione democratica si è mossa quindi con prudenza sul terreno complesso di un partito che deve tenere insieme progressisti mai così assertivi come oggi, fin troppo a volte, e moderati, acquisendo consensi anche su questo secondo fronte. Alexandria Ocasio-Cortez, il deputato iper-progressista di New York, ha avuto un solo minuto per parlare, e nemmeno ha nominato Biden, per lei un cripto-conservatore.
Come già altre volte in passato, la convention si gioca a sinistra per celebrare l’unità del partito ed evitare fughe e assenteismi mentre la parte decisiva della campagna elettorale, settembre e ottobre, la si fa più a destra per recuperare più voti possibili. Ce ne sarà bisogno. La partita è enorme, la paura è una molla da usare per scuotere gli indecisi e Obama ha cercato di smuovere tutti sfiorando i contorni di una possibile sconfitta. Per l’America molto dipenderà da questo voto. E anche per il mondo, l’Europa in prima fila.
Trump non sa che cosa vuole, se non spremere più voti possibili dalle illusioni di un elettorato digiuno di storia e convinto che da sola l’America sarebbe un paradiso e che occuparsi del mondo ha portato solo guai. Per questo il manifesto pubblicato il 21 agosto da 70 ex protagonisti della diplomazia, della difesa e dei servizi di sicurezza, tutti repubblicani, e che invita a votare Biden e a mandare a casa un Trump “inadeguato al ruolo presidenziale”, ha colpito nel segno. Ma solo per chi vuole leggerlo. Per gli altri sarà una prova in più che l’élite è infida e solo Trump può guidare il Paese. Dove?