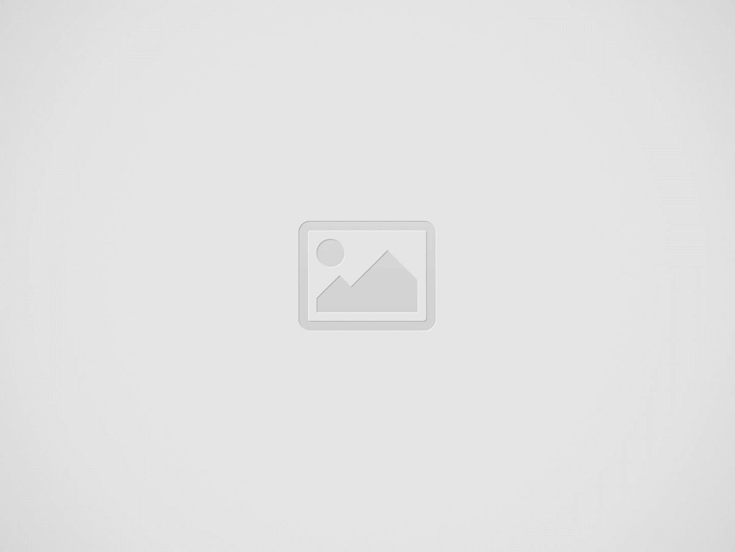C’era una volta il banchiere centrale che guidava con il pilota automatico, confidando che i mercati avrebbero creato da soli la crescita economica e il benessere sociale. Sembra un secolo fa, ma sono passati solo 15 anni da quando Bernanke, allora presidente della Fed, teorizzava che, grazie alla credibilità anti-inflazionistica accumulata, la Banca centrale di un paese avanzato potesse stare alla finestra a guardare l’economia incamminata su un sentiero di “grande moderazione”, con bassa disoccupazione e prezzi stabili. Purtroppo, quello scenario idilliaco fu bruscamente spezzato dalla crisi finanziaria globale del 2008, poi venne messo alla prova dalle crisi sovrane europee e, di recente, è stato del tutto scombussolato dal coronavirus. Queste crisi hanno costretto i banchieri centrali a rimboccarsi le maniche, scendendo in campo con strumenti spesso inusitati e sempre più potenti. Insomma, da un atteggiamento liberista si è passati alla svelta a politiche fortemente interventiste. Se prima accettavano il giudizio del mercato, con una funzione quasi notarile, oggi i banchieri centrali sono diventati giocatori attivi che, per mestiere, il giudizio del mercato lo vogliono plasmare, visto che, lasciato a se stesso, il mercato non riesce a tornare fuori da questa ondata di crisi ripetute e sempre più profonde.
La metamorfosi del banchiere centrale è ben rappresentata dall’evoluzione del pensiero di Mario Draghi che, pur non essendolo più, lo è stato molto a lungo, prima alla Banca d’Italia e poi alla Bce. In effetti, forte della sua preparazione, delle esperienze maturate, del pragmatismo e dell’acume strategico, Draghi si è mostrato abilissimo domatore dei mercati. In questo, ha dato prove certo non inferiori a quelle dell’illustre predecessore Guido Carli. Infatti, pur essendo espressione di quell’Italia debole, che nel secondo conflitto mondiale era entrata dalla parte dei perdenti per uscirne tra i vincitori, il giovane Carli seppe in qualche modo contare al tavolo dei negoziati di Bretton Woods e poi segnò la storia del Paese in vari modi e ruoli, incluso da Governatore della Banca d’Italia. Vi è una qualche analogia con l’arrivo di Draghi a capo della Bce: sia pur in tempo di pace, l’Italia che lo esprime è debole, fiaccata dalla crisi sovrana. Nonostante ciò, in pochi mesi riesce a domare i mercati. Il 26 luglio 2012, mentre gli speculatori arrotavano le lame pronti a banchettare sulle spoglie dell’euro, il neopresidente della Bce irrompe nella fossa dei leoni e li doma con il flauto magico. Il suo memorabile discorso del “Whatever it takes” nella City di Londra cambia improvvisamente il clima. Se un minuto prima quasi tutti scommettevano sull’imminente implosione dell’euro ad agosto (mese consueto per le crisi valutarie perché gli scambi sono rarefatti) quel discorso fece crollare le certezze. È vero che dichiarare allora interventi illimitati della Bce poteva essere un bluff, perché ci sarebbe voluto tempo per vincere le opposizioni interne, che non mancavano, ma il rischio di rimetterci veniva d’un tratto innalzato. E, in ogni caso, nessuno se la sentì di andare a vedere le carte di Draghi, il quale è perciò riconosciuto come salvatore dell’euro. Nei sette anni di presidenza della Bce ha introdotto altre innovazioni, talora discusse, come nel caso dei tassi di interesse negativi. In ogni caso, l’immagine è quella di un banchiere centrale interventista, votato a correggere i malfunzionamenti del mercato.
E, anche ora che non ha più un ruolo istituzionale forte, la reputazione di domatore del mercato conferisce agli interventi di Draghi un significato particolare. Perciò, vale la pena di considerare con attenzione il suo impegnativo discorso al Meeting di Rimini di agosto. In quella sede, l’ex-presidente della Bce ha dato due messaggi principali. Il primo è stato sulla necessità di dare una risposta pronta e ampia alla crisi economica da pandemia. In pratica, Draghi ha sostanzialmente approvato quanto fatto in sede nazionale e Ue. Non era scontato. A marzo scorso, dopo l’improvvido scivolone della Lagarde, che aveva inizialmente dichiarato che la BCE non doveva preoccuparsi dello spread dei tassi di interesse tra i debiti sovrani dei vari paesi euro (giudizio peraltro rapidamente rivisto), era stato tirato per la giacca a fare un accorato editoriale sul Financial Times in cui si appellava alle autorità Ue perché rinnovassero lo spirito del “Whatever it takes”, potenziandolo alla luce di una crisi ancor più grave. Ebbene, oggi Draghi constata che, varando i programmi Sure (a sostegno dei disoccupati) e Next Generation Eu (per il rilancio dello sviluppo sostenibile), oltre che confermando lo European Green Deal (Egd) e attivando il Messanitario, le autorità Ue hanno saputo dare risposte all’altezza della sfida. In particolare, apprezza che i nuovi programmi amplino in modo significativo il bilancio comunitario e intravede in ciò il viatico verso un vero Ministero del tesoro Ue, cruciale per sanare il deficit istituzionale tuttora presente a Bruxelles. A lungo andare, per domare i mercati, cioè per ridurre il rischio e l’incertezza e far funzionare bene l’economia evitando le crisi, non basta la politica monetaria comune, deve essere comune anche quella fiscale.
Tuttavia, l’aspetto più interessante sta nel suo secondo messaggio, che ci fa apprezzare ancora una volta la grande caratura dello statista. Non basta accontentarsi di far ripartire l’economia senza avere una visione su dove si vuole e deve andare. Soprattutto perché lo si sta facendo a debito, accrescendo a dismisura quello che lo Stato dovrà ripagare in futuro. E a farlo saranno in specie le nuove generazioni, i giovani di oggi, che dalla crisi sono colpiti in modo sproporzionato. Consapevole che in tedesco “Schuld” significa sia “debito” che “colpa”, Mario Draghi propone allora di distinguere tra debito buono e debito cattivo. Il giudizio va ricavato da una miscela tra analisi economiche e considerazioni etiche. Dato che a ripagare gli impegni finanziari di oggi saranno i giovani, il debito diventa colpa, o “debito cattivo”, se si scialacquano i capitali per mantenere in vita imprese e programmi senza futuro, mentre è “debito buono”, senza colpa, se quei capitali vengono canalizzati a salvare e far cresce imprese e programmi innovativi. Oltre a caldeggiare la transizione verso lo sviluppo sostenibile come fattore di competitività, perciò, Draghi indica come chiavi di volta l’innovazione tecnologica e, soprattutto, il potenziamento dei programmi d’istruzione. Il vero grimaldello sta nel rafforzare l’istruzione: da un lato, accresce il capitale umano, rinforzando la competitività di sistema, e riduce le disuguaglianze; dall’altro, orienta la spesa pubblica al servizio di coloro che dovranno sopportarne gli oneri maggiori, cancellando la “colpa”.
Ne abbiamo fatta di strada: da notaio abulico, il banchiere centrale è diventato sempre più interventista. Dall’inarcare impalpabile il sopracciglio destro scorgendo l’inflazione un decimale oltre il previsto, a domatore sudato e scarmigliato, con tanto di fruste, bastoni e paletti acuminati, per convincere i mercati con le buone o con le cattive nell’interesse collettivo. È poi rimarchevole che la saggezza di Draghi invochi l’istruzione per definire il debito buono, laddove dieci anni prima qualcuno diceva: “Non è che la gente la cultura se la mangia”.