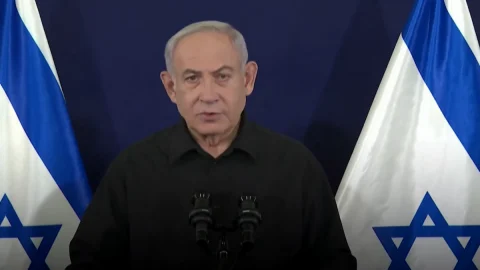Dei tanti libri dedicati a Craxi nel ventennale della sua morte, quello di Claudio Martelli (L’Antipatico, edito da La Nave di Teseo) è forse il più bello. Non è un’agiografia e neppure una puntigliosa ricostruzione delle vicende politiche di cui Craxi fu protagonista. E’, invece, una attenta ed insieme affettuosa biografia politica e culturale del leader socialista morto ingiustamente in esilio.
Il Craxi di Martelli è innanzitutto un tenace socialista riformista che si fa le ossa a Sesto San Giovanni, nella Stalingrado d’Italia, e che partecipa attivamente alla vita del movimento operaio senza alcun complesso di inferiorità nei confronti dei comunisti, allora egemoni. E’ un combattente per la libertà dei popoli, siano essi palestinesi, latino americani o dissidenti nei paesi dell’Est ed è anche un sincero patriota che ama l’Italia e non lo nasconde, come nel PCI solo Giorgio Amendola faceva.
Ma Craxi è soprattutto un “garibaldino”, che muove guerra alle grandi potenze che tarpavano le ali al Paese: ai comunisti innanzitutto, la cui egemonia sul movimento operaio condannava la sinistra italiana ad essere opposizione per l’eternità; alla DC che, consapevole della rendita di posizione di cui godeva, tende a trasformarsi, con Fanfani, in una sorta di Partito-Stato e crea quell’intreccio inestricabile fra politica ed economia e fra imprese e Stato che contribuirà, più di ogni altra cosa, ad alimentare la corruzione nel nostro paese a partire dagli anni ‘50 sino al ‘92 ed oltre ed, infine, contro quello che Martelli chiama il 4° Potere, vale a dire i grandi gruppi dell’industria e della finanza che ben volentieri si adattarono a quel sistema, a loro cosi favorevole, salvo poi rinnegarlo quando cessò di esserlo.
Ci voleva del coraggio ed una notevole dose di self confidence per condurre, da una posizione di minoranza, una simile guerra. Ma a muovere Craxi non fu l’arroganza (che peraltro non gli apparteneva) quanto piuttosto una “profonda convinzione politica e morale”. La stessa che aveva animato nel passato gli uomini che più ammirava e che ne ispiravano l’azione: Garibaldi, Mazzini e Bixio. In questo senso Craxi fu davvero, come giustamente rimarca Martelli, “un uomo profondamente morale, nel senso crociano del termine”.
Ma cosa ne è stato delle sue battaglie politiche? Martelli si concentra su tre di queste battaglie: quella per l’Unità Socialista che mirava, per citare le parole di Norberto Bobbio che di quella proposta fu artefice, a “ricomporre su di una base limpidamente riformista le sparse membra del socialismo italiano”; quella per l’alternanza alla DC, da realizzarsi attraverso una “grande riforma istituzionale”, e, infine, quella per un nuovo sviluppo del Paese, da realizzarsi attraverso le riforme ed una programmazione democratica dell’economia (non il Gosplan ma la programmazione pensata da Antonio Giolitti e Giorgio Ruffolo).
Vasto programma! che avrebbe certamente cambiato il volto dell’Italia se solo si fosse realizzato. Ma così non è stato. Ciascuno per la propria parte, il PCI da un lato e la Dc dall’altro, ne hanno decretato il fallimento e le conseguenze ancora pesano sul Paese. L’Unità Socialista fallì perché il PCI vi si oppose con tutte le sue forze e ad opporvisi con maggiore determinazione non fu la vecchia guardia togliattiana ma furono i giovani turchi che ne avevano preso il posto: Occhetto, D’Alema e Veltroni.
D’Alema, a posteriori, ha riconosciuto che quella dell’Unità Socialista era l’unica via percorribile ma, ha aggiunto, la si poteva imboccare soltanto se Craxi si fosse fatto da parte. Si tratta di una meschinità politica e di un’evidente bugia: nel ‘92 Craxi fu effettivamente costretto a farsi da parte a seguito dell’intervento della Magistratura milanese ma la sua “rimozione forzata” non fece fare alcun passo in avanti al progetto dell’Unità Socialista. Anzi, lo archiviò definitivamente. La verità è che Occhetto, D’Alema e Veltroni tutto volevano, tranne che trasformare il PCI in un moderno partito socialdemocratico.
Dall’89 in poi abbiamo assistito ad una estenuante quanto vana metamorfosi del vecchio PCI (politicamente morto ma mai definitivamente sepolto) in PDS, poi in DS e ora in PD. Domani non si sa! Ma se oggi la sinistra italiana, più che al “campo grande” del quale favoleggiano Zingaretti e Bersani, assomiglia ad un arido “deserto dei Tartari”, la colpa principale è proprio degli eredi del PCI. Anche la grande riforma istituzionale che avrebbe dovuto favorire l’alternanza della sinistra unita alla Dc non si è realizzata.
E anche qui l’opposizione del PCI è stata, se possibile, più dura e determinata di quella della stessa DC. Per il PCI parlare di governabilità, di alternanza e di semi presidenzialismo equivaleva a mettere in discussione l’impianto stesso della Costituzione, la cui essenza è quella di “costringere” le forze politiche a consorziarsi piuttosto che a dividersi. Su questa base la rottura a sinistra era inevitabile, ma non lo era però il modo in cui quella rottura si consumò. Il PCI accusò Craxi di essere un avventuriero e del suo governo disse che rappresentava “una minaccia per la democrazia”.
Del PSI Berlinguer denunciò l’irreversibile mutazione genetica mentre D’Alema decretò che il PSI si era trasformato in un gruppo affaristico avvinghiato al potere democristiano. La rottura fu drammatica e le sue conseguenze per la sinistra e per la democrazia italiana sono state nefaste. Da lì, infatti, origina la campagna di delegittimazione del sistema dei partiti che culminerà poi, anche grazie all’intervento della Magistratura, nella loro pratica distruzione. Dal ‘92 la democrazia italiana vive una perenne transizione verso un nuovo assetto istituzionale al quale non riesce ad approdare per la semplice ragione che non ci sono più forze politiche in grado di gestire questo passaggio.
Solo i cretini possono gioire per la scomparsa dei partiti e solo una Magistratura irresponsabile può accanirsi contro ogni forma di organizzazione politica e persino culturale, come le Fondazioni. Ma la verità incontestabile è che senza partiti la democrazia rappresentativa semplicemente non esiste. Come dicono gli americani: “non c’è America senza democrazia, non c’è democrazia senza politica e non c’è politica senza partiti” e questo vale anche per l’Italia.
Più controverso è il bilancio della politica economica del governo Craxi. Qui, curiosamente, Martelli, anziché rimarcare i risultati positivi conseguiti nella lotta all’inflazione e nella crescita del Pil (sono gli anni in cui l’Italia superò l’Inghilterra), mette l’accento su due fatti che, a suo modo di vedere, avrebbero minato le possibilità dell’Italia di crescere e cioè: il divorzio fra il Tesoro e la Banca d’Italia (primi anni ‘80) e le privatizzazioni (primi anni ‘90). A suo parere il primo avrebbe provocato un’esplosione del debito pubblico, a causa degli interessi passivi da pagare, e le seconde avrebbero portato ad una liquidazione di fatto del rilevante patrimonio industriale dello Stato.
Francamente mi sembrano due accuse poco fondate. Il divorzio fra il Tesoro e la Banca d’Italia si rese necessario per porre un limite alla pessima abitudine dei governi dell’epoca di finanziare la spesa corrente (soprattutto quella relativa al Welfare) stampando moneta anziché aumentando le tasse. L’accumulo del debito sino a raggiungere l’odierno 134% del Pil è dovuto in larghissima misura all’aumento della spesa corrente e agli interessi che su quel debito il paese ha dovuto pagare. Se il debito fosse stato contratto per fare investimenti pubblici produttivi, quegli investimenti, sia pure nel tempo, si sarebbero ripagati e il debito non sarebbe cresciuto.
Il problema non è dunque se indebitarsi o no ma per che cosa farlo, e questo è vero sempre e comunque, sia che ci sia il divorzio sia che non ci sia. Anche sulle privatizzazioni il giudizio dovrebbe essere più calibrato. Per quanto costi doverlo ammettere va ricordato che, al di là di un nucleo di imprese di eccellenza che andavano salvaguardate in ogni modo, il patrimonio industriale pubblico era oberato da imprese decotte e cronicamente in perdita. Imprese che avrebbero dovuto essere ristrutturate, risanate o dismesse prima del fatidico 31 dicembre ‘92, data di apertura del mercato Unico Europeo.
Noi non lo abbiamo fatto e, di conseguenza, lo abbiamo dovuto fare dopo, con l’acqua alla gola e pagando un prezzo salato (basti ricordare la liquidazione coatta dell’Efim, lo smantellamento della Gepi, la svendita o la chiusura degli impianti chimici dell’Eni e di quelli siderurgici dell’Iri). Certo si sono fatti degli errori, il più imperdonabile dei quali è stata la privatizzazione della Telecom (totalmente diversa dalla apertura al mercato di Eni ed Enel). Ma di tutto ciò è responsabile la Politica e non i poteri forti che, in questo caso, c’entrano poco o nulla.
In generale, guardando a quel periodo e al modo in cui Craxi operò, non si può non riconoscergli la statura politica e la capacità di governo che Martelli, giustamente, gli attribuisce. Sarebbe giusto però che a farlo fosse ora il Paese nel suo complesso anche perché di politici di simile vaglia avrebbe oggi un disperato bisogno.