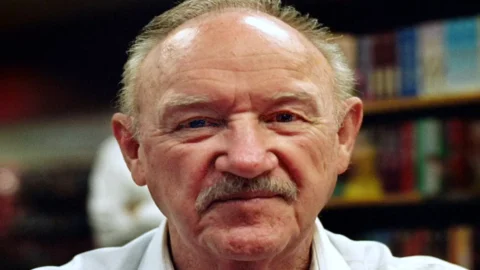Quando vi trovate in un luogo pubblico, ma anche in una occasione familiare, provate a fermare l’immagine e osservate quante persone sono connesse, parlano o hanno in mano un telefono cellulare. Oppure, se notate qualcuno intorno a voi fare abuso di Facebook, Whatsapp, Instagram etc, provate a dirgli se non ritiene eccessivo il tempo dedicato a socializzare attraverso il cellulare piuttosto che quello dedicato a relazioni umane più dirette, frontali, guardandosi negli occhi. Non sembra che ci siano più dubbi sulla nuova dimensione sociale, culturale, antropologica che l’umanità intera sta attraversando da quando sul pianeta sono comparsi i primi apparati di telecomunicazione mobile, comunemente intesi come “cellulari” e non sono pochi coloro che ritengono che siamo prossimi ad una nuova patologia di tossicodipendenza dove invece di una sostanza c’è la frequenza di trasmissione.
Al cinema il tema è stato sollevato bene dal noto film di Paolo Genovese “Perfetti sconosciuti” dove i protagonisti erano adulti alle prese non tanto con gli scherzi del destino tecnologico, quanto più sulle loro concrete difficoltà relazionali.
Di tutto questo si parla nel film di Federico Moccia “Non c’è campo”, appena uscito nelle sale italiane. Si tratta di una fotografia, di una sequenza estesa di immagini dove si racconta di un gruppo di adolescenti, liceali alla quinta classe, in gita scolastica in un paese della Puglia dove, appunto, non c’è campo, i cellulari non hanno tacche, non prendono. I ragazzi, nonché l’insegnante – Vanessa Incontrada – appena si rendono conto di non essere più collegati con il loro mondo virtuale, entrano in crisi e sono costretti a scendere dai tre metri sopra il cielo, tanto per citare il titolo del libro di grande successo di Moccia, e confrontarsi con la banda larga dei sentimenti in prima persona, diretti, dal vivo, senza mediazione dei social network.
Il film è tutto qui ed è tanto e poco allo stesso tempo. È tanto perché affronta un tema, l’uso e l’abuso della comunicazione via cellulare, di grande complessità e di non facile soluzione per i problemi che si pongono oggi e si porranno ancor più per le prossime generazioni. È poco perché affronta questi temi con una specie di rassegnata contemplazione, con un vago auspicio che con un po’ di impegno le relazioni umane in presa diretta possono, dovrebbero, essere migliori di quelle realizzate attraverso i selfie o i messaggini.
“Avevo vent’anni e non permetterò a nessuno di dire che quella è l’età più bella della vita” (Paul Nizan) rimane ancora una delle citazioni più importanti della letteratura sui dilemmi e conflitti giovanili perché coglie appieno le complessità, le difficoltà che ognuno ha affrontato o affronta in un momento di passaggio esistenziale tanto centrale nella vita. Da questo punto di vista “Non c’è campo” rappresenta a sufficienza quella parte di mondo che attraversano gli adolescenti, nel pieno dei turbamenti affettivi, sociali e culturali. Il racconto propone un po’ di tutto e un po’ di niente: c’è tutto il vissuto quotidiano, di giovani e adulti, che in presenza di campo, dimensionano le loro azioni e misurano il peso dei comportamenti, individuali e collettivi. Allo stesso tempo, c’è il niente, quel vago senso di vuoto pneumatico che assale quando si osserva un mutamento in corso difficilmente comprensibile e condivisibile. , appaiono eccessivamente allo stesso tempo concentrati in un microcosmo di relazioni a corto raggio, fluide, leggere, e svagati quanto basta per sembrare assai distanti dal mondo reale.
La pellicola scorre bene, i tempi sono giusti, la sceneggiatura regge. Nel merito, la discussione è aperta: il film si può anche vedere, con l’avvertenza di spegnere prima il cellulare.