Da qualche anno, soprattutto in Italia, per oggettive ragioni dovute all’arretramento relativo dei nostri sistemi industriale, di istruzione e ricerca, all’invecchiamento demografico, all’aumento della povertà e delle disuguaglianze soprattutto a danno delle giovani generazioni, crescono le esigenze di rafforzamento dell’intervento pubblico. Oggi esso è reso urgentissimo dalla catastrofe sanitaria ed economica legata alla pandemia da coronavirus.
Da più voci viene però inspiegabilmente richiesta la ricostituzione dello Stato imprenditore, nell’esperienza storica italiana rappresentato dall’Iri, dall’Eni e dagli enti pubblici autonomi, notoriamente liquidati nel 1992 con la privatizzazione della grandissima parte delle imprese controllate, rimanendo tuttavia in mano al Tesoro sotto forma di Spa, le ancor oggi nostre migliori e più competitive industrie, tra cui l’ENI.
Una economista americana dal dignitoso ma non strepitoso profilo scientifico, è stata addirittura chiamata in Italia come consulente del Presidente del Consiglio Conte, proprio in quanto sostenitrice della riattualizzazione dell’esperienza dello Stato imprenditore in Italia, e specificamente del modello dell’IRI, considerando ciò condizione per la necessaria iniezione di innovazione nel sistema industriale italiano.
L’opinione politica più autorevole espressa in questi giorni è quella di Romano Prodi, avendo presieduto l’Iri tra il 1982 e il 1989 e nel 1993-94, oltre che successivamente il Consiglio dei Ministri; essendo stato dunque responsabile e artefice di una parte significativa proprio delle privatizzazioni.
Oggi, di fronte al declino italiano, all’indebolimento del progetto europeo e alla catastrofe generata dalla pandemia, Prodi si duole della lunga assenza di una politica industriale nazionale; stigmatizza il decennale dominio di una cultura e azione “neoliberista” e indirizza verso un Piano dello Stato, che contrasti la forza della finanza speculativa, dei monopoli privati, e metta l’Italia in linea con l’azione di grandi paesi europei che, come la Francia e la Germania, difendono con capitali pubblici e operazioni di reshoring i loro interessi nazionali.
Il Piano dello Stato accennato da Prodi, tra i migliori rappresentanti della nostra classe dirigente nazionale ed europea, è ben articolato e complesso: insiste sull’importanza dell’edilizia e delle opere pubbliche, sottolinea la centralità della ricerca e della formazione per il rilancio dell’industria, invita alla sinergia tra i vari settori dell’economia e alla attuazione di un programma di coordinamento e innovazione con risorse pubbliche (dal credito alle partecipazioni) per un inderogabile salto di qualità della nostra dominante piccola e media impresa.
E guarda anche ad una nuova missione strategica della grande impresa pubblica. Non si tratta di rifare l’Iri, che giudica anacronistico, ma di istituire una struttura pubblica delegata non a gestire le aziende ma a sorvegliarne la gestione: o dando tale funzione alla Cassa depositi e prestiti, o istituendo una task force a livello ministeriale.
Tra le forze politiche al governo affiorano proposte che vanno dalle “nazionalizzazioni” dei 5 Stelle, finora peraltro solo annunciate, allo “Stato oculato” proposto dal vicesegretario del Pd Andrea Orlando, che avrebbe il compito di vigilare sui consigli di amministrazione di imprese eventualmente capitalizzate.
“Stato imprenditore o no”, che restano le ipotesi alternative, aleggia sul dibattito e sulle scelte governative di questi giorni, l’istituzione di una struttura ad hoc per l’industria pubblica (una specie di nuovo ministero delle partecipazioni statali che si presume protetto dalle contaminazioni conosciute nel passato).
Fortunatamente una simile struttura non figura finora nelle interviste e dichiarazioni del Ministro dell’economia, giustamente impegnato a rappresentare in questo momento le difficoltà e le potenzialità di tutta l’imprenditoria italiana e a tenere le fila di un difficile equilibrio di governo che non aiuta le trattative in corso in sede Ue per affrontare la recessione.
Il fatto è che nei casi ricordati, come tra le forze di governo, la scelta in discussione risponde quasi sempre ad una visione ostile all’impresa privata prima che all’esigenza di rigenerare il sistema economico-industriale italiano; rischia pertanto non solo di indebolirlo, ma persino di depotenziare le poche grandi industrie e strutture finanziarie che, solidamente in mano allo Stato, e senza sovrastrutture politiche di indirizzo e coordinamento, ne costituiscono oggi i maggiori punti di forza.
Perché lo Stato eserciti il proprio intrinseco ruolo di coordinamento, di indirizzo e di intervento diretto o indiretto in ogni settore, continuano ad essere fondamentali la qualità delle politiche, tra cui la politica industriale – oggi non c’è neanche il Ministero dell’Industria- e la qualità ed efficienza della pubblica amministrazione. Lo dimostrano vistosamente anche le attuali difficoltà nella gestione dell’emergenza sanitaria e nell’erogazione degli aiuti economici alle imprese e al lavoro soffocati dal lockdown.
E’ indiscutibile che di fronte alla gravità della catastrofe generata da un virus ancora sconosciuto, urga il massimo dell’intelligenza dell’azione pubblica, la quale, per essere tale, deve necessariamente fondarsi sul massimo della condivisione possibile e spogliarsi da ogni impostazione particolaristica o da nostalgie ideologiche. Per questo vanno fissati alcuni paletti nella memoria e nella consapevolezza storica.
Il primo è che l’Iri di cui si ripropone oggi l’attualità, non è quello originario ideato da Alberto Beneduce su mandato in bianco di Mussolini e poi divenuto protagonista della Ricostruzione postbellica italiana. E’ piuttosto quello di Pasquale Saraceno (da nessun documento risulta peraltro aver partecipato al primo incontro di Beneduce con Mussolini), con suo stesso grande dolore, testimone negli anni 70-90 della subalternità dell’Istituto, anche se non di tutte le sue imprese, agli interessi particolaristici in quei decenni esercitati da correnti partitiche ma anche dalle stesse imprese pubbliche e private.
L’Iri di Beneduce nacque nel 1933 come ente finanziario, autonomo dallo Stato, dovendo realizzare una radicale riforma del credito fondata sul salvataggio della Banca d’Italia, sul controllo pubblico delle grandi banche, sulla specializzazione del credito industriale e sulla creazione di un mercato finanziario moderno basato sull’emissione di obbligazioni garantite dallo Stato e a basso rendimento.
Riguardo all’industria l’Iri si potrebbe persino definire un ente di privatizzazione, avendo risanato e rivenduto ai privati persino negli anni dell’autarchia la grandissima parte delle grandi, medie e piccole imprese finite in mano allo Stato in seguito al fallimento delle banche miste che ne possedevano o controllavano in tutto o in parte il capitale azionario. L’Iri conservò il controllo di grandi imprese di settori strategici, per la cui riprivatizzazione non esistevano sul mercato capitali sufficienti.
La proposta in discussione oggi è esattamente opposta: espandere la presenza e il controllo dello Stato sul capitale industriale. Il secondo punto fermo è che durante il fascismo e negli anni della Ricostruzione l’Iri non fu sottoposto al controllo di alcun organismo politico, sottraendosi persino al più volte tentato inquadramento entro il Ministero delle Corporazioni.
Il quarto punto fermo è che nella formulazione dello Statuto del 1948, morto Beneduce già nel 1944, Donato Menichella che lo aveva affiancato nell’intera storia dell’Istituto come direttore, si batté perché l’Iri mantenesse il carattere di Ente finanziario, perché non si espandesse ad altri settori e non si trasformasse in uno strumento delle politiche di sviluppo governative, in particolare di quelle meridionaliste.
Menichella si oppose alla ridefinizione dei compiti dell’Iri nel 1956 e alla nascita del Ministero delle partecipazioni statali, che furono invece sostenuti da Pasquale Saraceno, in base ad una visione meno liberale, laica e pragmatica, ovvero in base ad un progetto di rinnovamento economico e sociale dai forti connotati utopistici di impronta cristiana.
Secondo Saraceno con la sua nascita nel 1933 l’Iri avrebbe rappresentato il momento più significativo della storia del capitalismo industriale, rivelando per tutto il periodo trascorso la debolezza storica degli industriali privati e indicando per il futuro la superiorità dell’industria pubblica. Saraceno arrivò a retrodatare la nascita del sistema delle partecipazioni statali alla fine dell’800, al momento della costituzione delle banche miste, in quanto destinate a fallire con in mano i pacchetti azionari di grandissima parte delle imprese italiane.
Al tempo stesso, a suo avviso, il sistema delle partecipazioni statali sarebbe stato in grado di coniugare l’efficienza aziendale con l’economicità di gestione lasciando autonome le aziende nell’azione imprenditoriale, ma affidando la definizione e il finanziamento delle finalità sociali allo Stato. I più seri protagonisti dell’attuale dibattito conoscono bene questi fatti.
Sanno che il sistema delle partecipazioni statali è caduto sotto la scure del debito prodotto al suo interno e del debito pubblico italiano; che le privatizzazioni possono pure essere state fatte precipitosamente o inopportunamente in diversi casi, ma che gli eventuali errori non sono ascrivibili tanto a forzature iperliberiste, quanto all’urgenza della formazione dell’Unione europea e al rispetto delle regole dell’adesione.
Non sono dunque realistici né utili la contrapposizione ideologica all’impresa privata, la rimozione di tratti fondamentali di storia e la riproposizione di formule esposte per ragioni sostanziali al rischio di fallimento.
°°°°L’autrice è Professore Senior di Storia contemporanea all’Università La Sapienza di Roma





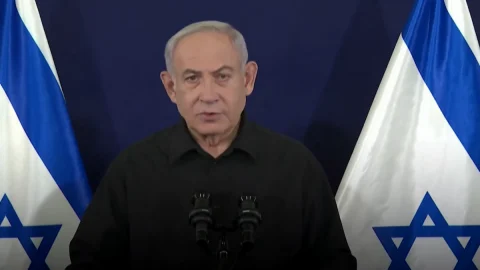
Gent.ma Prof.ssa visto che è anche una storica lei dimentica una cosa importante. Uno Stato esiste quando esiste un sistema-Paese. Solo alloro possiamo parlare della utilità o meno dello Stato-imprenditore oppure dello Stato-programmatore o dello Stato che assicura il rispetto delle regole. In Italia il sistema- Paese non esiste più, frantumato da una politica regionale-localistica ridicola e penosa. Nell’ultima emergenza si è oltrepassato i fondo con patetici personaggi che senza un minimo di buonsenso hanno “scimmiottato” a fare il Trump o il Putin “de noantri”, in territori locali le cui dimensioni sono spesso come un condominio di Roma. Quale programmazione, quali progetti ma soprattutto quale fiducia si può riscuotere nel mondo
..mi sa che non ha letto bene l’articolo. Magari ne parliamo dopo una lettura più attenta? Grazie