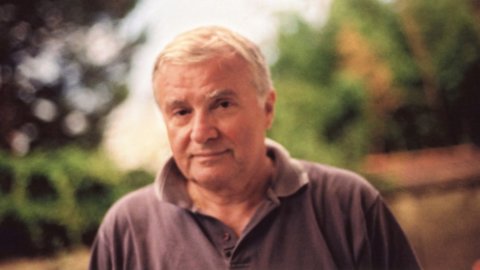Nel 1966 il senatore George Aiken del Vermont, repubblicano di vecchia scuola moderata, formulava un lapidario giudizio sulla strategia da adottare in Vietnam, così tramandato: “Dichiariamo vittoria, e andiamocene”.
E’ quello che gli Stati Uniti avrebbero dovuto fare da tempo in Afghanistan, dove inviarono le truppe nell’autunno del 2001, poco dopo gli spaventosi attentati di Osama bin Laden a New York e Washington. Chiamarono a raccolta contro i santuari del terrorismo, e l’Afghanistan lo era allora in pieno, tutti i partner Nato, con l’Italia fra i maggiori a contribuire dopo il Regno Unito, e altri alleati e volenterosi. Persino la Svizzera mandava allora un minuscolo contingente, prima missione militare all’estero dal 1815. Alla fine Washington ha speso almeno mille miliardi, assai di più secondo alcune stime, la parte di gran lunga maggiore per addestrare armare mantenere un esercito afghano di oltre 300mila uomini; ha avuto più di 2.400 militari uccisi (58.220 in Vietnam), più di 3000 contractors (spesso ex militari) uccisi, 20mila feriti, mentre gli alleati hanno avuto oltre 1100 morti (53 l’Italia), 10 mila feriti e speso complessivamente oltre 100 miliardi di dollari.
Non è servito a molto. Kabul è oggi uno dei maggiori disastri della politica estera e militare, americana e occidentale. La fine definitiva della Pax Americana scrivono molti oggi, e certamente con validi argomenti, e l’avvio definitivo di un mondo post-americano che Fareed Zakaria tratteggiava già nel 2008, mesi prima della grave crisi finanziaria, a genesi in gran parte americana, di quell’anno.
La tentazione di applicare la “legge di Aiken” si presentò più volte, e l’allora vicepresidente Joe Biden se ne fece ripetutamente interprete, soprattutto nei primi due anni della presidenza Obama. Ma il Pentagono aveva sempre un progetto che, dicevano, avrebbe portato frutti.
Washington ebbe tre finestre temporali che oggi appaiono chiaramente favorevoli alla “legge di Aiken”, ma che non furono colte anche per errori di fondo della diplomazia e della strategia americane che, avendo sostenuto in modo determinante l’Europa postbellica nel 1947-48 (nel proprio interesse, sia chiaro, ma anche nel nostro) con Piano Marshall, Nato e molto altro, hanno da allora ritenuto che con il progetto giusto si può ripetere ovunque qualcosa di non troppo diverso. Ma il mondo non è l’Europa.
Potevano uscire nel 2003-2004, dopo avere sconfitto la presenza di al-Qaida in Afghanistan; potevano andarsene nel 2011 dopo avere eliminato bin Laden, nascosto in Pakistan; e potevano andarsene nel 2015, quando decisero di sospendere di fatto le operazioni militari su ampia scala e di ridurre molto una presenza che era arrivata durante i primi anni di Barack Obama a 110 mila uomini. L’annuncio da parte di Washington ad aprile e della Nato a maggio di un calendario di uscita delle truppe è stato un errore. Ha dato ai talebani un calendario di guerra. Sfaldato il tutto, fuggito con la cassa il premier Ghani il 15 agosto, la ritirata è diventata una disfatta à la Saigon 1975. Anche nelle modalità dell’uscita, che doveva essere gestita con molta più accortezza, la guerra in Afghanistan è finita male.
I commenti americani, anche fra i più autorevoli e moderati osservatori, sono spesso di fuoco. Richard Haass, presidente del Council on Foreign Relations di New York ed ex diplomatico, stigmatizza la scelta di Biden, che ha troppo seguito la sceneggiatura finale già scritta da Trump, di fissare una data precisa, l’11 settembre; e ricorda che ora i talebani potrebbero creare seri problemi al Pakistan, che sempre li ha coperti nella sua complicata strategia anti-indiana ma che resta un Paese instabile. Charles A. Kupchan, dello stesso Council newyorkese, sostiene invece che se la scelta di colpire all’inizio (2001) il legame talebani-al Qaida fu giustifcata, il dopo si basò sull’illusione della possibilità di un Afghanistan centralizzato e avviato alla modernità, un sogno ingenuo in una realtà profondamente tribale; Biden non ha fatto altro che dire la parola fine “a uno sforzo perdente in cerca di un obiettivo irraggiungibile”.
Resta ora da vedere se la débȃcle american-occidentale rilancerà la strategia del terrorismo globale, con attentati sia nei Paesi islamici sia in Occidente. Molti ritengono che i rapporti fra i talebani, una parte di loro, e quanto resta di al-Qaida potranno rinsaldarsi, ma non è chiaro fino a che punto, mentre sarebbe da escludere una presenza afghana per l’Isis, che i talebani hanno in genere osteggiato. Djoormat Otorbaev, ex premier del Kyrgyzistan, insiste sulla necessità di un impegno economico collettivo anche occidentale perché il Paese non sprofondi del tutto, associando Cina e Russia, e ricorda come “la Russia con la sua profonda influenza in Asia centrale detenga le chiavi di tutto questo”.
Quanto agli Stati Uniti, e all’Europa, la lezione è chiara. Se qualcuno aveva ancora dubbi sulla fine della Pax Americana la lezione è servita. Questo non vuol dire però che l’America sparisce. Biden ha pagato un prezzo molto alto, anche di credibilità al momento, del Paese e sua personale, a un progetto di una rinnovata politica estera che condivide con quella di Trump una parte delle premesse, ad esempio la centralità del rebus cinese, ma per arrivare a obiettivi ben diversi. Quello di Trump era ed è il nazionalismo puro e duro, facciamoci i fatti nostri, intanto gli alleati non esistono e spesso, vedi la Ue, sono peggio degli avversari. Biden invece abbandona definitivamente alcune logiche dell’American Century, prima di tutto quella secondo cui tutto il mondo è vitale per Washington, ma vuole rinsaldare il campo, con l’Europa prima di tutto, perché degli alleati ha bisogno per una politica efficace verso la Cina, e per altro. Non crede a una America first, che equivale a una America alone. L’uscita disastrosa umilia gli Stati Uniti, ma è possibile che agli occhi dell’elettorato diventi presto più positiva che negativa, “perché i nostri soldi vanno spesi a Kansas City e non a Kabul”. Questa, fra repubblicani e democratici, è a netta maggioranza l’America di oggi. E senza tener conto di questo non esiste politica estera americana duratura.
Robin Niblett, direttore del Royal Institute of International Affairs di Londra, prevede rapporti più saldi e fruttuosi con l’Europa prima di tutto, ma anche con Giappone e alcuni altri. E nel caso europeo lo scambio di “favori” è evidente: “Parte del compenso tacito chiesto dall’Europa per aiutare gli Stati Uniti a gestire il nodo cinese è la continua partnership americana con l’Europa per gestire il nodo russo, che rappresenta il più incombente e persistente problema per molti governi europei. Biden non ha certo mai messo in discussione questa tacita intesa”.