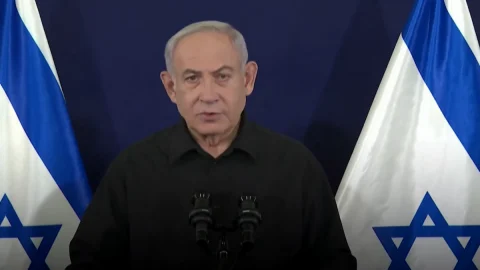Il 25 aprile del 1945 partì l’appello per l’insurrezione armata della città di Milano, sede del comando partigiano. Per questo motivo quella giornata fu scelta dal Comitato di Liberazione Nazionale come Festa della Liberazione. Questa Festa è ancora divisiva. Se grave è la responsabilità di coloro che rifiutano di riconoscere in quella data la rinascita dell’Italia come grande nazione libera e democratica è altrettanto grave veder brandire – purtroppo succede ad ogni anno – la Resistenza come una clava; come se certe forze politiche avessero la prerogativa di riconoscere o meno un pieno diritto di cittadinanza ad altre forze politiche “figlie di un Dio minore”, nonostante siano legittimate dal voto e abbiano accettato i valori della competizione democratica.
Dopo tanti anni, tuttavia, bisognerebbe avere il coraggio di raccontare tutta la verità, pur inquadrandola nel contesto difficile e crudele di quei tempi. La ferocia non fu da una parte sola e non si esaurì nell’aprile del 1945 o subito dopo. Il fatto che i vincitori (quelli che di solito scrivono la storia) fossero, per fortuna, dalla parte giusta non autorizza nessuno a negare – come è successo per troppo tempo – ogni comprensione e pietà per quanti scelsero, in quegli anni travagliati, la parte sbagliata. Allora, era molto difficile, per dei giovani, avere le idee chiare, capire quanto stava capitando intorno a loro. Decisioni tanto gravi, tali da ipotecare il destino delle persone, dipesero sovente da circostanze contingenti. Anzi, dal caso.
La storia (per fortuna non cruenta) che voglio raccontare è quella di due fratelli, Antonio e Bruno, ambedue nati in un paese della pianura bolognese, (Granarolo dell’Emilia), condannati dalla guerra a divenire formalmente nemici. Il primo, il più grande (del 1911), aveva combattuto, in fanteria, tutte le guerre del Fascismo. Il secondo (del 1920) era arruolato in Marina. I due fratelli – cosa altro potevano fare? – erano fascisti, nel senso che non erano antifascisti, al pari della grande maggioranza degli italiani. L’8 settembre del 1943 colse Antonio in Jugoslavia, col grado di sergente furiere; Bruno era imbarcato, come sottocapo silurista, sul cacciatorpediniere Centauro che incrociava nel Mediterraneo.
Antonio, insieme alla sua compagnia, si trovò inquadrato nella Repubblica Sociale. Le truppe italiane, in quello scacchiere, non avevano praticamente alternative, se non quella di fare la fine dei Caduti di Cefalonia o di passare coi partigiani titini, con la certezza di essere fucilati. Tanto gli ex amici quanto gli ex nemici non sarebbero stati generosi in frangenti siffatti. Sotto la guida di un bravo capitano, molto stimato dai suoi soldati, la compagnia di Antonio si acquattò nelle retrovie tedesche, si ritirò con loro, fino a quando, arrivati in Austria, riuscirono ad arrendersi agli inglesi.
Bruno, invece, fu inserito nell’Esercito badogliano, nei Battaglioni San Marco, combatté con gli alleati, risalendo la penisola, fino a partecipare alla Liberazione di Bologna. Nell’immediato dopoguerra, la famiglia del fratello maggiore si trasferì a Bologna, dove Antonio poteva passare inosservato. Al paese l’aria si era fatta pesante (tanto che fu epurato dal posto di lavoro), ma Antonio poté contare sull’aiuto e sulla protezione dei parenti e degli amici, compresa la solidarietà attiva del fratello Bruno. Purtroppo, fu congedato senza che gli fosse attribuita la promozione a cui aveva diritto (in pratica fu punito) e gli anni di guerra non gli vennero riconosciuti ai fini della pensione.
Tutto sommato ad Antonio andò bene. Trascorsi i primi difficili periodi, quando la legalità venne ristabilita grazie alla vittoria delle forze democratiche nel 1948, gli fu permesso di tornare, la domenica, al paese natio, per fare visita a gran parte della sua famiglia che lì abitava. Ma i veleni rimasero. Alla fine degli anni Sessanta, il figlio di Antonio (che nel frattempo era morto prematuramente nel 1965) si recò nella cittadina della pianura bolognese per partecipare a un dibattito, in rappresentanza del Psi (il partito a cui era iscritto), ma dovette fronteggiare la contestazione di uno sparuto gruppo di persone che lo accusava di essere “figlio di un fascista”.
Antonio e Bruno riposano in pace da tanto tempo. L’odio della politica (di cui erano incolpevoli) non logorò mai l’amore fraterno che li legava. Antonio era mio padre; Bruno mio zio. Io, che sono stato socialista ed antifascista per tutta la vita, come quasi tutti i componenti della famiglia, a lungo ho considerato quella (forzata) collocazione di mio padre nel campo dei vinti come un peccato originale, da nascondere persino a me stesso. Un atto vile di cui mi sono pentito, perché stimavo ed amavo molto mio padre, che mi ha lasciato quando avevo solo 24 anni. Da allora non c’è stato praticamente un solo giorno – compreso il 25 aprile – in cui non abbia pensato a lui.