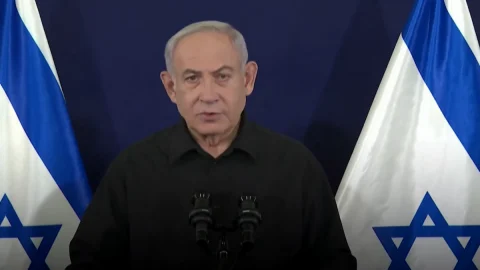La riforma dell’articolo 323 del Codice penale, inserita nel decreto legge 76/2020 con decorrenza 17.7.2020, rappresenta la risposta alla domanda di efficientamento della macchina pubblica. Da più parti, si era denunciata l’eccessiva invasività delle indagini negli ambiti propri della discrezionalità amministrativa che ha provocato il ripresentarsi della “sindrome della firma”, che aveva dato spunto alla riforma dell’articolo 323 compiuta con la legge 324/1997.
Anche in quegli anni, in particolare i Sindaci delle città dichiaravano che il timore di essere sottoposti a procedimento penale era uno dei principali freni dell’azione della pubblica amministrazione. Inoltre, lamentavano l’autoreferenzialità delle indagini che venivano compiute senza mai interloquire con i diretti interessati. Per questi motivi, il legislatore dell’epoca non si limitò a incidere sulla fattispecie, espungendo l’eccesso di potere dalla condotta materiale e inserendo l’elemento del dolo intenzionale, ma intervenne su quella che era una vera e propria patologia processuale e che, come vedremo, purtroppo ha continuato a perpetuarsi sino ad oggi.
I pubblici funzionari, i Sindaci delle città, lamentavano di essere citati in giudizio senza essere mai stati convocati dalla Procura della Repubblica. Giungevano, a sorpresa, citazioni davanti al giudice penale senza che il diretto interessato (oramai imputato) avesse potuto spiegare durante la fase delle indagini il merito amministrativo e la legittimità della scelta compiuta. Ciò comportava , allora come oggi, che la maggior parte dei processi, audita la difesa, si risolvevano in sentenze assolutorie con formula ampia.
Processi che, molto probabilmente, se avessero visto un’interlocuzione anticipata tra P.M. e indagato, non sarebbero mai iniziati, con notevole giovamento sia della macchina giudiziaria che del sistema della pubblica amministrazione, sollevato dei problemi che si presentano ogni qualvolta si esercita l’ azione penale nei confronti di un pubblico ufficiale in carica.
Ebbene, proprio per scongiurare questo corto circuito del processo, lo stesso legislatore (1996 – 2001), con la Legge 479/1999 introdusse l’art. 415 bis del codice di procedura penale che impone al Pubblico Ministero di notificare all’indagato, pena la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, “l’avviso di conclusione delle indagini preliminari” che , oltre a prevedere il diritto di accesso a tutti gli atti di indagine, riconosce all’indagato il diritto di farsi interrogare dal P.M. o di chiedere il compimento di atti di indagine a sua difesa.
Tale norma, nonostante la limpidezza del suo dettato (“Se l’indagato chiede di essere sottoposto a interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi”) è stata cancellata, di fatto, da molte Procure della Repubblica, che ne hanno inteso dare un’interpretazione meramente burocratica, delegando l’espletamento dell’atto processuale alla Polizia Giudiziaria (spesso a digiuno della indagine), così svilendo la funzione pregiurisdizionale deflattiva per la quale era stata introdotta. Interrogare l’indagato in prima persona non è considerato un dovere ineludibile da molti magistrati come, a mio avviso , dovrebbe essere. Non solo per una forma di lealtà dello Stato (in quel frangente rappresentato dal singolo magistrato della Procura) nei confronti dell’indagato, ma anche per gli evidenti benefici in termini di efficientamento del processo penale e della credibilità del sistema giudiziario.
Rendere interrogatorio innanzi alla Polizia Giudiziaria si è rivelato, nella maggior parte dei casi, inutile. Le argomentazioni rese in prima persona dell’indagato non raggiungono il Pm, che resta fermo nelle sue convinzioni, promuovendo un processo che, nella maggior parte dei casi , si poteva evitare, cioè un processo ineluttabilmente destinato a concludersi con sentenza di assoluzione.
Tale prassi distorta, a sua volta, ha alimentato la tendenza di molti difensori ad astenersi durante le indagini da qualsiasi interlocuzione con il Pubblico Ministero, avendo registrato la pregiudiziale impermeabilità anche rispetto alle più documentate e fondate ragioni della difesa. Un corto circuito che ha moltiplicato la celebrazione di processi che si sarebbero potuti evitare se si fosse realizzato un contraddittorio leale e giuridicamente credibile da ambo le parti. Il risultato è stato che , come prima della riforma del 1997, oggi la maggior parte dei processi per abuso di ufficio si concludono con assoluzione con formula piena.
Si potrebbe affermare che le criticità dovute all’applicazione estensiva del reato di abuso di ufficio che provoca invasioni nel campo della legittima discrezionalità sono dovute più allo svilimento dello strumento processuale introdotto con l’art. 415 bis c.p.p. che alla eccessiva genericità della fattispecie. Un legislatore attento avrebbe potuto, con la nuova formulazione del reato, preoccuparsi dei profili processuali , primo tra tutti, stabilendo espressamente che l’interrogatorio ex art. 415 bis c.p.p. debba essere compiuto necessariamente in prima persona dal Pm che ha condotto le indagini.
Si vedrà che applicazione avrà la nuova fattispecie dell’articolo 323, che appare circoscritta in un angolo, considerata la valenza meramente residuale delle ipotesi perseguibili. Infatti , la nuova norma delimita la condotta ai casi di violazione di specifiche regole di condotta previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità rispetto alla precedente, che contemplava la violazione di norme di legge o di regolamento. È evidente che l’azione amministrativa è per definizione discrezionale, quindi, sembra dire il legislatore, dove c’è discrezionalità non può esserci rilevanza penale: ci potrà essere eventualmente illegittimità amministrativa (la riflessione non potrà non estendersi anche alla recente deregulation in materia di appalti e ai rapporti con il reato di turbativa d’asta).
Il nuovo articolo 323 c.p. potrebbe definirsi omissione o inosservanza di atti di ufficio finalizzati a favorire o danneggiare un terzo. Ciò perché, eliminata la discrezionalità, l’abuso di ufficio sarebbe configurabile ove il pubblico ufficiale , violando un obbligo di legge, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, ma la violazione di un obbligo di legge integra anche la sua omissione. Propende per questa interpretazione la circostanza che non è stata modificata la parte della condotta che sanziona il conflitto di interessi e che impone, appunto, l’obbligo di astenersi. In questo caso, la violazione di legge integra proprio un omissione del dovere di astenersi. Obbligo che, per definizione, esclude ogni discrezionalità.