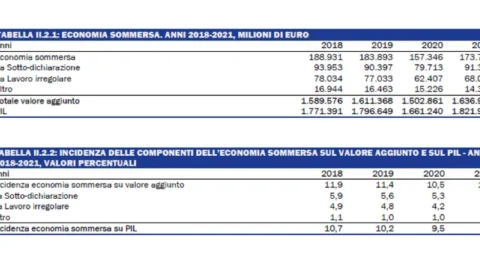L’affermazione che l’Italia, dopo la Germania, sia il secondo Paese manifatturiero in ambito europeo stupisce sempre molto l’ascoltatore televisivo o il lettore di giornali, forse perché le imprese che non raggiungono direttamente il consumatore finale con beni di consumo pubblicizzati mancano totalmente di visibilità. Solo quando salgono alla ribalta dei mass media l’Alcoa di Portovesme, l’Ilva di Taranto o la Fiat di Mirafiori si focalizza che siamo ancora produttori di acciaio, alluminio o automobili, anzi che la maggior parte dell’industria del Paese ruota proprio su queste produzioni, la cui scomparsa metterebbe a rischio non solo i posti di lavoro dei diretti interessati ma le sorti di altre decine di migliaia di lavoratori delle aziende manifatturiere che battono il “ferro”, come si diceva un tempo.
La verità è che non ci sentiamo più, o non vogliamo più, essere un Paese che ha il suo perno nel settore manifatturiero, nelle fabbriche, esposte alla crisi e alla concorrenza internazionale, risultando difficile valutare se la rilevanza dell’industria possa ancora essere il motore della ripresa e del dinamismo dell’economia italiana. C’è ormai una diffusa ed errata convinzione che la produzione di beni materiali sia destinata a spostarsi altrove, lasciando ai Paesi più avanzati come l’Italia un ruolo di progettazione, direzione e controllo (le braccia nei Paesi asiatici e nell’Est europeo e la mente qui), mentre bisogna crescere in settori diversi dalle industrie tradizionali ed in particolare in quei settori che appaiono più innovativi e dinamici come le telecomunicazioni e l’informatica, l’industria del lusso e del design, dello spettacolo o del tempo libero, del turismo d’arte e del benessere, oltre che nei settori dei servizi e del credito. E’ la soluzione, ad esempio, che la piazza del quartiere Tamburi di Taranto vorrebbe con la riconversione dell’area tarantina al turismo e alla mitilicoltura, ripercorrendo la storia dell’area siderurgica di Bagnoli con la sua destinazione a porto turistico, residenze alberghiere e centri commerciali (sic !).
Come ha urlato una signora ai microfoni di una recente trasmissione televisiva, riferendosi all’Ilva: “Ho il marito e il figlio disoccupati, ma non vorrei mai che andassero a lavorare in quella fabbrica”. La fabbrica, per chi non vi lavora, è considerata un luogo che fa pensare a fatica, noia, depressione, ambiente nocivo, tute sporche, catena di montaggio, ciminiere, inquinamento e gli operai sono per lo più visti come persone che non hanno avuto scelta, persone che non hanno un titolo di studio e si presentano sul mercato del lavoro senza qualifiche professionali, sostanzialmente che non sanno fare altro e hanno assolutamente bisogno di lavorare e non trovano di meglio. Una visione che non corrisponde alla realtà, ma è il risultato di quella cultura anticapitalista e antindustriale che trova ancora i suoi diffusori in molti intellettuali, sociologi o comunicatori mass-mediologi che, molto probabilmente, l’unica volta che hanno visto una fabbrica erano in visita scolastica con i calzoni corti.
Oggi in fabbrica il lavoro pesante e ripetitivo è compiuto dai robot, dalla macchine a controllo numerico o dalle trasferte meccanizzate, il rumore è quasi totalmente assente, gli spazi sono ampi e luminosi, i pavimenti sono a volte di parquet tirato a lucido, l’ergonomia è il pilastro dell’organizzazione del lavoro. Ma quello che più conta è che la fabbrica ruota tutta attorno alla sua risorsa più importante, quella umana: sia che siano professionali, impiegati o operai, peraltro indistinguibili per il visitatore esterno. La tuta blu è fisicamente scomparsa: ingegneri, tecnici, impiegati e operai portano tutti la stessa “divisa”, generalmente un camice o una tuta bianca pulitissima e non unta di olio, come la vecchia tuta dell’ immaginario collettivo. La maggior parte dei giovani operai ha oggi un diploma tecnico o di istruzione professionale e la diffusa organizzazione del lavoro in team favorisce la loro propositività e creatività: il termine “associati” sta sostituendo nel linguaggio di fabbrica quello di “dipendenti”, sia per gli operai che per gli impiegati. Rendere nuovamente attrattivo il lavoro in fabbrica, superando i luoghi comuni o le pregiudiziali ideologiche, è dunque uno dei compiti che il Governo e le parti sociali, imprese e sindacati, sono chiamati a svolgere per dare una prospettiva all’ occupazione giovanile.
I dati europei sulla disoccupazione giovanile evidenziano che in Italia il tasso di attività della popolazione giovanile, dai 15 ai 24 anni, è il più basso d’ Europa: 29% contro il 53% della Germania e il 37% della Francia e che oltre il 19%, sempre dei giovani tra i 15 e 24 anni, non è inserito in alcun circuito occupazionale, scolastico o di formazione professionale contro l’8% della Germania e il 12% della Francia. Per rilanciare la produttività del Paese, e in particolare del sistema industriale, è dunque necessario, come recentemente ha sottolineato il Presidente dell’Unione Industriale di Torino, Licia Mattioli, porre al centro dell’attenzione la formazione delle competenze e della cultura del “fare”, messe in crisi dal declino dell’Istruzione Tecnica e Professionale.
Non è una pura coincidenza, nel nostro Paese, il contemporaneo declino negli ultimi quindici anni della produttività industriale e il parallelo calo delle iscrizioni agli istituti tecnici e professionali: messi a confronto i sistemi formativi di Germania e Italia, in Germania solo il 30% dei giovani si indirizza verso percorsi liceali, mentre il 60% circa sceglie quei percorsi tecnologici, nei più diversi livelli formativi, che garantiscono maggiore occupabilità. Sul tavolo della “competitività” tra le parti sociali non dovrà pertanto mancare la questione della formazione e addestramento professionale, individuando le opportune modalità, ad esempio, per riavviare quelle “scuole aziendali”, i cui allievi, grazie al “sapere” tecnico acquisito, non solo sono stati nel passato la risorsa fondamentale delle loro aziende, ma in molti casi si sono trasformati in piccoli e medi imprenditori nell’indotto dell’impresa madre, contribuendo allo sviluppo di interi distretti industriali.