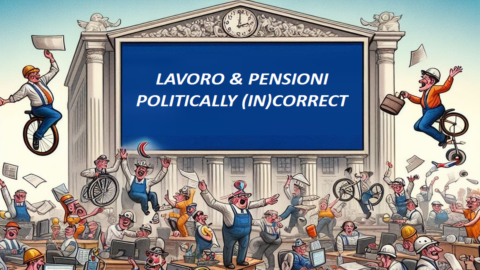La calda estate italiana del 2012 resterà nella nostra memoria come l’estate delle due crisi: quella dell’euro e quella dell’Ilva che, ogni giorno di più, diventa la crisi dell’industria italiana e delle sue regole. L’incertezza che continua ad incombere sul futuro della moneta unica, di fronte alla lentezza e alla contradditorietà con cui si attivano le pur giuste misure approvate dal Consiglio europeo di fine giugno e di fronte al tortuoso percorso a zig zag lungo il quale si muove la Bce, obbliga a concentrarsi sull’emergenza finanziaria che ci accompagna da cinque anni ma che vive da un anno un’escalation impressionante.
Non occorre andare in vacanza in Grecia o in Spagna per toccare con mano la drammaticità della crisi che arriva dai due capi del Mediterraneo e che tengono in ansia tutta l’Eurozona. L’ottimismo della volontà induce a credere che anche stavolta l’euro si salverà ed uscirà dalla tempesta ma il fattore tempo non è irrilevante per l’esito della partita. E la sola idea che l’euro possa saltare per aria travolgendo mezzo secolo d’Europa e dimezzando nel giro di un weekend i nostri patrimoni, i nostri stipendi e le nostre pensioni ma non il nostro debito basta e avanza ad alimentare paure che solo le generazioni che hanno vissuto una guerra conoscevano.
Può anche darsi che prima della fine dell’estate la Spagna decida di chiedere l’aiuto dell’Europa con ciò attivando il fondo salva-Stati e il conseguente intervento della Bce sui bond. Può anche darsi che la Corte costituzionale tedesca si decida a dare il via libera al nuovo fondo salva-Stati senza andare alle calende greche, ma che cosa avrebbe scritto la stampa tedesca se un altro Paese avesse tenuto in stallo l’Europa per tanto tempo? E può anche darsi che la nuova querelle tra la Grecia e la Germania sulla possibilità di allungare di due anni il tempo per l’attuazione del vincolante programma a cui Atene è sottoposta in cambio degli aiuti europei trovi una composizione.
Ma, anche ammesso che tutto si risolva per il meglio, è evidente come l’emergenza euro sia destinata a dominare i nostri pensieri e quelli dei mercati e dei governi. In questo momento il nostro futuro dipende interamente dall’euro e la sua difesa non può che essere in cima alle nostre agende. Il caso Ilva ci ricorda però che, quand’anche l’emergenza euro si risolvesse con la tenuta della moneta unica, non per questo il futuro dell’Italia sarà scontato.
E’ già sconvolgente che in Italia basti un Gip per mettere in discussione ruoli e competenze nella tutela dell’ambiente e per mettere in discussione le regole non solamente dell’impianto siderurgico di Taranto ma di quelle che stanno alla base dell’intero sistema industriale italiano. Ma il caso Taranto solleva domande inquietanti che vanno ben al di là del braccio di ferro tra un magistrato e il sistema di governo del Paese ed è l’ennesima occasione per interrogarci, in circostanze drammatiche, su quale pensiamo che debba essere il mestiere dell’Italia anche oltre il caso dell’impianto siderurgico e anche oltre la crisi dell’euro. Siamo ancora convinti che, senza trascurare lo sviluppo e la modernizzazione dei servizi, l’industria sia la vocazione centrale del nostro Paese o no?
Sarebbe davvero curioso che negli anni in cui perfino l’arrogante Inghilterra riconosce i suoi errori e ammette l’importanza di riscoprire l’industria manifatturiera dopo aver sacrificato tutto alla finanza, noi facessimo il contrario. Ma credere nell’industria come mestiere caratterizzante dell’Italia del ventunesimo secolo non può essere un gioco di vacue parole. Sono le politiche che fanno la differenza. L’allarme della Bce sui rischi di insolvenza delle nostre aziende ma anche la recente ricerca di Mediobanca-R&S sui “Dati cumulativi” dii oltre duemila imprese italiane della manifattura e dei servizi ci ricordano che non basta credere nell’industria perché avvengano i miracoli se alle promesse non seguono i fatti.
Che cosa serve all’industria e su quale industria puntare per un dignitoso futuro dell’Italia si sa da tempo. Il Made in Italy – che vuol dire industria meccanica, alimentare e dei prodotti per la casa e per la persona – resta il baricentro del nostro sistema produttivo anche se dovrà sempre più allargarsi all’energia verde e alle attività collegate con le scienze della vita. Ma il Made in Italy vincente è quello che sa internazionalizzarsi, darsi una gestione manageriale, puntare sull’innovazione e sulla ricerca e che sa crescere. Il successo delle medie imprese più dinamiche parla chiaro anche se non si possono coltivare sogni e un Paese che non ha o non valorizza i grandi gruppi – il caso Ilva ma anche il caso Fiat sono emblematici al riguardo – non ha un grande futuro.
Quale sia il cocktail indispensabile per vincere la sfida competitiva di oggi lo conosciamo da tempo: l’importanza delle infrastrutture materiali e immateriali, della crescita dimensionale e di qualità delle imprese, dello sviluppo delle liberalizzazioni e della concorrenza, della ricerca, dell’innovazione e della formazione dal capitale umano è sotto gli occhi di tutti. Ma prima di ogni cosa bisogna avviare una rivoluzione copernicana che cambi il contesto in cui l’industria opera e che renda l’ambiente ricettivo e favorevole, cancellando ogni risorgente anti-industrialismo. Su questo le forze politiche che si candidano alla futura guida del Paese devono essere chiare e i comportamenti elusivi o ambigui non sono più tollerabili. Tra i tanti meriti del governo Monti e della sua discontinuità c’è anche quello di non chiedere solo alle imprese che cosa possano fare per l’Italia ma il contrario: che cosa può e deve fare l’Italia per sostenere l’industria e per attrarre investimenti esteri nel nostro Paese, giunti ormai da tempo ai minimi storici. Ecco perchè sull’euro come sull’industria l’agenda Monti é un bene troppo prezioso che, nelle forme e nelle combinazioni di governo che usciranno dalle prossime elezioni, non va smarrito e che deve durare ben oltre questa legislatura.