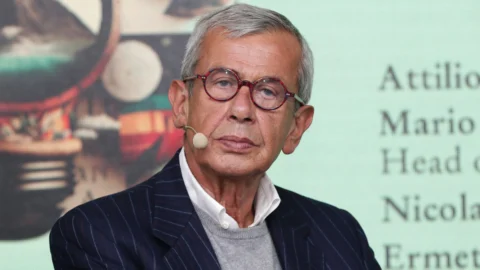È un po’ come quando hai mal di schiena, vai dal fisioterapista e ti senti dire che il tuo problema è un calo di tono muscolare. Che fare? Semplice, almeno a parole. Mettersi al lavoro, con fatica e costanza, per ricostituire il tono che manca. Un po’ la stessa cosa accade in economia, nella nostra economia italiana.
Recessione vuol dire calo della produzione. Per uscire dalla recessione altro rimedio non c’è che opporre al calo della produzione un aumento della produzione. Facile a dirsi. Difficile a farsi. Non impossibile, però. A credere nella missione non impossibile di “reindustrializzare” un’economia matura sono in pochi. Tra di essi, di recente, spicca il caso del presidente americano Barack Obama. Ben tre delle diciassette pagine dell’edizione 2012 del discorso sullo Stato dell’Unione sono dedicate al “blueprint for manufacturing”, il progetto per rilanciare l’industria manifatturiera americana attraverso una miscela di riduzioni dei costi delle imprese, di incentivi fiscali e di vantaggi al rimpatrio di posti di lavoro delocalizzati all’estero.
Sentire che negli USA si pongono l’obiettivo di spingere sul manifatturiero ci fa riflettere. Se ci pensano gli americani, perché non provarci anche in Italia? La questione manifatturiera andrebbe posta al centro dell’azione di contrasto della recessione corrente e di costruzione di un progetto di sviluppo sul medio-lungo termine. Nel 2008 si disse che la crisi finanziaria dei sub-prime americani avrebbe arrecato meno danni alla Germania e all’Italia perché le due economie disponevano una forte base manifatturiera e potevano trarre grandi e durevoli vantaggi dalla crescita dei nuovi mercati extra-europei. La previsione si è rivelata giusta a metà: azzeccata per la Germania, ma non per noi. I consuntivi tedeschi e le speranze americane possono ora aiutarci a comprendere cosa ci è mancato e cosa potrebbe ora aiutarci per invertire la rotta.
Due sono i deficit da ripianare per tornare a produrre di più in Italia: un deficit di domanda, e un deficit di competitività. La recessione certo non aiuta a colmare il deficit di domanda. È un gatto che si morde la coda. Più debole è la domanda interna, minore la produzione, più bassi redditi e occupazione, peggiore diventa la recessione. Per provare a spezzare il circolo vizioso lo strumento è quello della domanda estera, che continua a mantenersi significativamente più tonica delle spese domestiche. È la conseguenza del fatto che, a differenza del 2009, nel 2012 la recessione c’è in Italia, ma non c’è in Germania, Francia e, meno che mai, in Cina. Chi esporta, quindi, va meglio rispetto a chi vende solo sul mercato interno, e può continuare a giocare le sue carte, pur in un contesto difficilissimo. I dati della congiuntura lo confermano. Nel terzo trimestre del 2011, mentre il PIL e i consumi scendevano rispettivamente di due e di tre decimi, le esportazioni in volume sono cresciute di oltre un punto e mezzo percentuale. Le importazioni sono diminuite. I saldi commerciali dell’Italia, a cominciare da quelli con grandi partner come Germania e Cina, stanno migliorando.
Pur positiva, la dinamica dell’export italiano non è però sufficiente ad intaccare i venti punti percentuali di arretramento che, in media, la nostra produzione industriale complessiva accusa rispetto ai livelli della primavera del 2008, alla vigilia della scorsa recessione. Provare a staccarsi da quel fondo richiede di porre mano con decisione al ripianamento del deficit di competitività di cui soffrono le imprese italiane. Si tratta di un deficit che ha molte facce. La proposta è sceglierne alcune, e aggredirle. Un divario che da sempre inibisce una maggiore proiezione sull’estero delle nostre imprese è quello dimensionale. La taglia media delle imprese manifatturiere italiane ammonta a nove addetti, la quarta parte di quella tedesca. Siamo troppo piccoli per cogliere appieno i vantaggi dello spostamento sui mercati extra-europei del nuovo baricentro della crescita mondiale. Lo dimostra il fatto che, su un numero totale di quattro milioni e mezzo di imprese, gli operatori all’export superano di poco le duecentomila unità. Tra il 2001 e il 2010, mentre il valore del commercio internazionale cresceva di una volta e mezzo, il numero degli operatori italiani all’export aumentava di appena l’otto per cento. Non discutiamo se piccolo sia ancora bello, oggi. È, però, un dato statistico che la produttività del lavoro raddoppia quando una micro impresa non esportatrice con fino a nove addetti riesce a fare il salto dimensionale per diventare una piccola impresa esportatrice con un numero di addetti compreso tra dieci e diciannove.
Sappiamo bene quali e quante siano le difficoltà e le resistenze alla crescita dimensionale delle imprese più piccole. Tra le altre c’è la legittima aspirazione dell’imprenditore a rimanere al centro del processo di sviluppo della propria azienda, a non perdere la propria identità. Ma dimensione significa produttività e competitività. Dimensione vuol dire innovazione. Occorre, quindi, cercare di superare l’ostacolo. Una via nuova, intelligente, per crescere senza perdere l’identità dell’imprenditore oggi esiste. Si chiama rete di imprese. La legge 122 del 2010 ha consolidato il quadro di regole e la giusta dose di incentivi fiscali per far decollare le reti che superano ora le duecento unità e coinvolgono circa un migliaio di imprese.
Duecento reti e mille imprese associate sono ancora molto poco rispetto all’obiettivo di invertire la rotta e muovere verso la reindustrializzazione. La qualità dello strumento, però, c’è, perché le reti nascono e crescono sulla base di programmi di innovazione e di miglioramento della competitività. Guardando ai casi concreti – dal network pioneristico delle aziende metalmeccaniche bresciane del “Five for Foundry” alla rete della pasta delle imprese agroalimentari senesi, al caso del grande nome della moda che fa rete con i piccoli subfornitori italiani – si percepisce subito il potenziale di sviluppo delle reti. E, tra i vantaggi del nuovo strumento, non ultimo c’è quello di rendere più “bancabile” la piccola impresa. Il progetto di rete, quando è costruito bene sulla base di convincenti prospettive, può rappresentare un forte elemento di miglioramento del giudizio sul merito di credito assegnato all’impresa dalla banca. Non è un vantaggio da poco in tempi in cui rimangono tangibili i rischi di “credit crunch”. Fare rete per migliorare il rating. Per alcuni, sia imprese sia banche, è un cantiere già aperto, oggi.
Le reti di imprese sono uno strumento nuovo a cui è opportuno confermare il sostegno di adeguati incentivi pubblici. Sono soldi ben investiti, utili a innescare un circuito virtuoso mirato a sostituire crescita a recessione. Le reti tra le piccole imprese servono a trattenere il tessuto manifatturiero ed evitare ulteriori smottamenti. Oltre che sul fronte delle nuove reti, la leva fiscale può dare un grande contributo alla riduzione del deficit di competitività su un terreno più generale. Parliamo del cuneo fiscale che incide grandemente sulle condizioni di convenienza relativa a investire in Italia o in altri paesi. Per citare un numero basti ricordare la statistica riportata in una recente audizione presso la Commissione Finanze e Tesoro del Senato: in percentuale del costo del lavoro, l’ammontare del cuneo fiscale a carico del datore di lavoro nel 2011 è risultato in Italia del cinquanta per cento superiore a quanto rilevato in Germania (24,3% contro 16,2%). È un divario che va corretto, se si vogliono aumentare i flussi netti di investimenti diretti dall’estero in Italia. Parliamo di investimenti di imprese straniere, ma anche della possibilità di un rimpatrio in Italia di quote del lavoro localizzato all’estero da medie e grandi multinazionali italiane.
In America il programma di rilancio del manifatturiero annuncia interventi importanti a sostegno del cosiddetto “back-shoring”, ovvero delle rilocalizzazioni negli USA di almeno parte di quanto precedentemente delocalizzato nelle economie emergenti. Il dibattito è aperto. Sarà difficile. I divari di costo del lavoro tra l’Occidente e il Far East o la per noi più vicina Europa orientale rimangono ampi. I gap, però, hanno iniziato a ridursi e in alcuni casi importanti questo accade a ritmi più veloci di quanto previsto in passato. Nel 2009, dati Istat, il costo del lavoro pro capite annualmente sostenuto da un’impresa manifatturiera italiana per un addetto impiegato in uno stabilimento cinese è ammontato a quattromilacento euro, grosso modo la decima parte di quanto pagato in Italia. Solo un anno prima, nel 2008, il costo dell’addetto cinese era di duemilasettecento euro, il cinquanta per cento in meno. Certo, se il costo del lavoro in Cina continuasse a salire del cinquanta per cento all’anno, il deficit italiano di competitività si potrebbe risolvere in un numero non altissimo di esercizi. Il problema è che la manifattura italiana non può aspettare dieci o anche solo cinque anni. Sono le stesse “growth economies” del mondo emergente che ci chiedono di fare prima perché spostano continuamente in alto l’asticella della competizione, operando a loro volta delle delocalizzazioni produttive e accrescendo, attraverso investimenti e innovazioni, la qualità media delle loro produzioni. La sfida, quindi, è a trecentosessanta gradi.
Recuperare competitività per rilanciare la nostra manifattura si può, facendo rete tra le imprese, riducendo i cunei sul costo del lavoro e ponendosi ad ogni livello l’obiettivo di accrescere la capacità dell’Italia di attrarre gli investimenti produttivi, quelli delle imprese estere e quelli delle aziende italiane che all’estero hanno con successo costruito una rete di realtà imprenditoriali che nel 2009 occupava oltre un milione e duecentomila addetti di cui almeno settecentomila nel comparto della manifattura.
Tra la primavera del 2008 e l’autunno dello scorso anno la componente che in Italia è rimasta più indietro nei conti del PIL reale sono gli investimenti fissi lordi, più dei consumi e più dell’export. Dagli investimenti, dall’industria e dalla manifattura occorre ripartire, per dare tono ad un progetto vincente di crescita e contenere gli esiti negativi del passaggio recessivo.