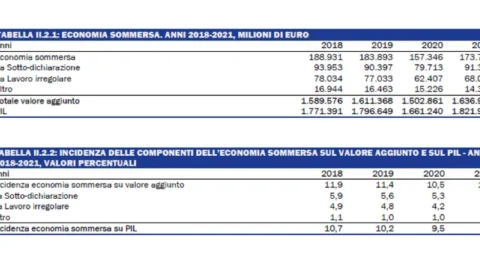È consolante che torni in primo piano nel dibattito pubblico, e non solo in occasione dell’8 marzo, la questione delle donne al lavoro. Ci voleva la pandemia, ci volevano le 93 mila lavoratrici senza lavoro nel 2020, le fatiche allo stremo della clausura, dell’apri e chiudi delle scuole, quasi tutte sulle spalle delle madri lavoratrici. Ci voleva insomma l’emergenza che risveglia i dormienti, magari per un attimo e senza conseguenze pratiche. Consolazione, dibattito e risveglio non risolvono però una briciola del disagio femminile, temperato soltanto da un mazzo di mimose, qualche parolina di circostanza, e una miriade di buoni propositi. E soprattutto non aiutano nell’attuazione della parità di genere, vera e piena.
Il divario di genere italiano si attesta a 18 punti (media europea 10). Il cammino verso la parità è fermo da anni, impigliato tra inefficaci quote rosa, torpide commissioni di pari opportunità e battaglie sul linguaggio, mentre da anni si ripete la litania dei nostri primati negativi: meno di un’italiana su due ha un lavoro remunerato (ma tante lavorano in casa e in nero); il saldo demografico negativo (1,27 figli per donna); gli asili nido (un quarto del fabbisogno); le differenze retributive (quasi un quarto in meno), l’asimmetria nelle cure familiari (con un carico maggiore per le donne).
Il risveglio sulla questione femminile non tocca necessariamente la parità. Due culture si confrontano in questo campo: quella della tutela e quella della libertà di scelta. La prima ha la sua radice nell’articolo 37 della Costituzione, primo comma («La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una adeguata speciale protezione») che, implicitamente, dichiara inessenziale il padre.
La seconda cultura, quella della libertà di scelta, non ha mai avuto e non ha tuttora un forte seguito, perché comporta un’azione di lungo periodo, di natura culturale più che politica, e chiede riforme costose. È più facile varare una legge, per esempio, sulla defiscalizzazione delle assunzioni femminili o sulle quote rosa, che convincere i datori di lavoro a non attuare alcuna discriminazione né sugli arruolamenti né sul trattamento giorno per giorno (le giovani di oggi lamentano un mobbing che è quasi impossibile dimostrare, una costante discriminazione nelle promozioni e negli stipendi, altrettanto difficile da combattere).
Sul finire degli anni Cinquanta la Rinascente non applicava più la “clausola di nubilato”, quel meccanismo che prevedeva il licenziamento automatico della lavoratrice in caso di matrimonio. L’azienda era culturalmente orientata all’innovazione e al pragmatismo: non conveniva formare e addestrare le giovani al lavoro di commessa per poi perderle, se sposate, e ricominciare da capo. Soltanto anni dopo la “clausola di nubilato” è stata proibita per legge, grazie alle numerose cause intentate dalle licenziate in nome della Costituzione. Quante sono oggi le aziende italiane che attuano la piena parità? Un pugno, spesso fondate e condotte da donne.
Il fatto è che l’ostacolo più roccioso alla parità in Italia sono gli italiani e le italiane. Si comincia con “auguri e figli maschi”, transitando per l’abbigliamento o i giocattoli di genere (il trenino al maschio, la bambola alla femmina), per approdare nell’adolescenza, quando le ragazze sparecchiano la tavola mentre i ragazzi guardano seduti. Alle bambine si insegnano tuttora la modestia, la paura, il riserbo; ai bambini l’audacia, la forza, la competizione; i maschi sono serviti e riveriti da madri tossiche che incombono sulle figlie al suono del monito che l’importante è trovare marito.
Il risultato è che milioni di persone in età adulta credono che il lavoro femminile sia un accessorio come la borsa griffata o il tacco 12; ritengono che soltanto il marito abbia diritto a decidere la separazione o il divorzio (lo ius corrigendi, le botte alla moglie e ai figli, è proibito dal 1956); che certi mestieri e professioni non siano adatti a una donna; che la “essenziale funzione familiare” delle donne dell’articolo 37 sia una verità assoluta e immortale e non un compromesso politico risalente al 1947. Non è esagerato dire che una moltitudine di datori di lavoro, capi e capetti di genere maschile vivono in una bolla, convinti della loro superiorità, che la società non mette in discussione con il vigore necessario.
Eppure le ragazze studiano, si diplomano, si laureano. Con il coraggio che poche madri hanno insegnato loro si avventurano nel mondo, capaci tanto di maneggiare l’algoritmo quanto il ferro da stiro (e quindi in condizione di netta superiorità su certi mariti). Si avventurano negli studi Stem (scienze, tecnologia, ingegneria, matematica) in misura crescente (40% dei laureati del 2018). Molte di queste giovani donne vanno poi a sbattere contro i più arcaici dilemmi: lavoro o figlio? restare o emigrare? ribellarsi o ingoiare il rospo?
Moltiplicare gli asili nido non è sufficiente, così come non sarà sufficiente un pugno di leggi e un pugno di miliardi del Next Generation EU. Dopo trent’anni di inerzia della famiglia e della scuola, di bombardamenti di pubblicità sessista, di indifferenza consumistica, sarebbe utile modificare la rotta. La parità non è una rivendicazione femminile contro i maschi o, peggio, un capriccio di poche femministe; è un principio di civiltà, oltre che una necessità economica (entro il 2025, dice il Fondo monetario, la parità di genere produrrebbe un aumento del PIL mondiale del 35%). In quanto principio di civiltà, tutti quanti, uomini e donne, dovrebbero battersi insieme per attuarla.
Ma l’Italia è il regno delle corporazioni e la corporazione dei maschi teme di perdere potere mentre la corporazione delle femmine si ostina ad accettare le regole della tutela: quando si affronta il cosiddetto “femminicidio” – che altro non è che un omicidio, non una categoria a parte – giustamente si compiangono le vittime ma ingiustamente non si sottolinea la povertà culturale e morale dei maschi violenti, e forse sarebbe il caso di prenderla in considerazione come elemento di inferiorità, di subordinazione al pregiudizio, piuttosto che preoccuparsi se si debba dire “ministra” o “falegnama”.
Certo, è complicato, quella della parità è una battaglia secolare. Ora, incoraggiati dal Next Generation EU, stimolati dai suoi miliardi, si potrebbe riprendere il cammino interrotto dalla fatuità degli anni Ottanta, dalle crisi economiche che accampavano altre urgenze (come se la parità non fosse un’urgenza ma un capriccio), eppure non spunta all’orizzonte alcuna chiarezza culturale e progettuale, non una visione di lungo termine. Gli asili nido saranno benvenuti ma non agevolano la parità, almeno fino a quando non sarà asserita l’ “essenziale funzione” degli uomini in famiglia e l’altrettanto “essenziale funzione” delle donne nel lavoro equamente retribuito. Poiché ha un grande valore simbolico, una modifica del primo comma dell’articolo 37 sarebbe, anche questa, auspicabile e benvenuta.