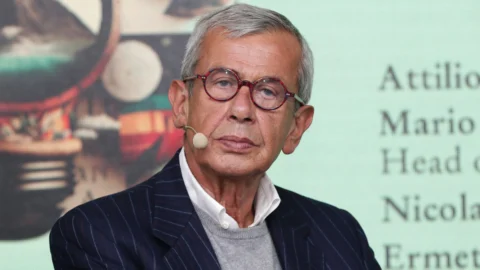Janesville, città di 63 mila abitanti nel Wisconsin, Stati Uniti, è ben lontana da Torino. O da Taranto o da altri luoghi industriali in declino nella nostra penisola. La geografia la colloca lontano ma i suoi drammi umani sono vicini e somigliano maledettamente a quelli di migliaia e migliaia di italiani e di europei. È questa una buona ragione per non restare all’oscuro di quel che è successo laggiù nell’ultima decina di anni e leggere il racconto di Amy Goldstein, giornalista del Washington Post, su quel che è successo in città prima e dopo i colpi della crisi del 2008 (Janesville. Una storia americana, LUISS, 24 euro).
È una narrazione a mosaico, che accosta la scena dell’industria dell’automobile a quella politica dello Stato, il Wisconsin, a quella dell’Unione, gli USA. Dalla scena di fondo si staccano le singole vicende familiari e domestiche, gli affanni personali e le sofferenze di uomini, donne, bambini. Entriamo, noi lettori, nelle case di Janesville, nelle cucine e nelle camere da letto, a seguire i tormenti che comporta la perdita di dignità, generata dalla fine del lavoro; ad assistere alla caduta nell’indigenza, un precipizio che non può essere evitato e non riesce a essere contrastato dalla volontà di riscatto e dagli innumerevoli programmi di assistenza e di recupero, nonché dalla filantropia. Perché la chiusura di una fabbrica si trasforma in un cataclisma che penetra così a fondo? La ragione è una sola: questa non è una crisi come le altre, ma uno degli episodi del crollo di un’epoca, l’era dell’industria nel mondo occidentale.
L’antivigilia di Natale del 2008 infatti chiude a Janesville la fabbrica di montaggio dei veicoli Suv della General Motors, esito della crisi devastante che dagli Stati Uniti si irradierà al mondo intero. Gli abitanti della città, gli operai e i lavoratori di ogni specie, gli imprenditori e i commercianti non sono nuovi agli alti e bassi dell’economia. Qui a Janesville l’industria ha messo piede presto, fin dalla seconda metà dell’Ottocento. È nata qui la penna Parker, qui si stende il grande distretto interstatale dell’auto, che ha il suo polo centrale a Detroit. Nel corso dei decenni certi stabilimenti hanno chiuso, poi riaperto, certi prodotti sono tramontati lasciando il posto ad altri, le tecnologie sono cambiate ma Janesville è rimasta una città industriale.
Dunque la chiusura del 2008 è un evento disastroso ma non fatale, almeno così è percepito nella sensibilità di gran parte dei lavoratori della città. Risanata, rivoltata la congiuntura negativa, la fabbrica riaprirà i cancelli. Quindi, con l’attitudine al cambiamento e l’abitudine alla mobilità che sono una prerogativa squisitamente americana, si ricomincerà con ottimismo e fiducia.
È quel che crede anche Paul Ryan, giovane astro nascente del Partito repubblicano, nato e cresciuto a Janesville, deputato al Congresso di Washington, il quale si mobilita subito e finirà per minacciare il capo della GM, Rick Wagoner: la fabbrica di Janesville deve riaprire, in un modo o nell’altro. Si mobilitano subito i capi famiglia, i sindacalisti, i filantropi, le banche, questa non è gente che aspetta la carità e anzi se ne vergognerebbe; non chiede, ma offre la propria forza, la propria intelligenza all’economia. Sono persone abituate a darsi da fare e soprattutto sono classe media, istruita, consapevole, indipendente.
È questo uno degli aspetti più interessanti e insieme più commoventi della storia di Amy Goldstein, il racconto della perdita di una condizione sociale e personale che lascia il posto al nulla. Fino a quel giorno del 2008 un operaio della fabbrica di montaggio GM guadagnava circa 28 dollari l’ora, pagava il mutuo della casa con giardino, magari con piscina, dove abita e che sarà tutta sua, possedeva più automobili, magari anche una motoslitta e un quad, un camper. La famiglia si concedeva le vacanze, qualche attività sportiva e ricreativa, pagava il college dei figli, tanto più facilmente se entravano due redditi. Insomma Janesville è un luogo di classe media, sicura di sé e fiduciosa nell’avvenire dei figli.
È un fatto certo che chi è nato povero e si abitua alla povertà, si arrangia e non si vergogna troppo di ricorrere ai sussidi, di ricorrere alla beneficenza o di tirare la cinghia. Invece chi ha assaporato la propria capacità di assestarsi nel benessere, affronta il tracollo economico in modo altamente drammatico, come dimostra la vicenda delle famiglie di questi lavoratori senza lavoro, cancellato dalla GM.
Non basta infatti la buona volontà, se la fabbrica non riapre e se la riconversione non si manifesta. Chiudono, dopo la fabbrica dei Suv, i fornitori, come la Lear che ne costruiva i sedili. Non basta iscriversi al college intorno ai quarant’anni, studiare con accanimento, prendere la laurea, presentarsi al collocamento, cercare su internet, se non arrivano in città nuovi capitali e altre iniziative, start up avveniristiche con i salari connessi. Lo scopre sgomento Bob Borremans, direttore dell’ufficio di collocamento, che non si è mai trovato di fronte a un blocco così totale delle offerte di lavoro e, per contro, a una valanga di domande dei disoccupati.
La famiglia Whiteaker, tra le altre, scopre che non è sufficiente usurare gli abiti, restringere il menu, vendere il camper, fare la spesa al discount, spendersi in lavoretti saltuari. Vendere la casa? A chi, se è crollato il mercato immobiliare? Il ceto medio, le famiglie un tempo sicure di sé, scoprono la fame. Tanto che Deri Wahlert istituisce alla scuola superiore una stanza delle provviste, dove i ragazzi possono trovare prodotti alimentari lì depositati da chi ha di più, e possono attingere con discrezione, quasi in segreto, senza subire la vergogna. Sotto questa enorme pressione, le famiglie si disgregano, e Ann Forbeck si dà da fare per offrire rifugio ai ragazzi abbandonati, che di notte dormono in strada e di giorno digiunano.
Per Mary Willmer, che dirige la M&I Bank, è urgente mettere in piedi progetti alternativi, trovare capitali, accogliere idee, avviare start up, ripartire. Cerca e trova capitali, ma con pochi e lentissimi risultati, non sufficienti a ridare fiato alla vita economica della città. Mike Vaughn, dopo diciotto anni alla Lear dei sedili, si adatta al trasferimento alla GM di Fort Wayne, nell’Indiana, a centinaia di chilometri da casa, lontano dalla famiglia che però mette al sicuro con il suo salario. Per Alyssa e Kayza Whiteaker, figlie di Jerad, per tredici anni operaio alla GM, l’adolescenza è appena cominciata e già si conclude: finiscono il liceo dividendosi tra lo studio e un lavoro o più lavori, mangiano grazie alla beneficenza, risparmiano per il college. Ce la faranno, e prenderanno la laurea.
La dinastia operaia dei Wopat, impegnata nel sindacato da due generazioni, assiste impotente al disastro che fa evaporare il lavoro, distrugge il tessuto sociale, mette in forse le antiche solidarietà, ferisce l’identità e sconquassa le relazioni. È la «storia della deindustrializzazione della più grande potenza industriale» come scrive Ferdinando Fasce nella postfazione, ma «vista dal basso» ovvero osservata nella carne viva delle persone che soffrono e non si arrendono (salvo Kristi Beyer, tredici anni alla Lear, poi studentessa al college, quindi guardia carceraria e infine suicida) ma sono comunque destinate a una vita ben peggiore di quella che hanno conosciuto prima del 2008.
I potenti no. I potenti schivano il danno e stanno tuttora bene, molto bene e di sicuro meglio di quel popolo di lavoratori che non hanno evitato di mandare al massacro. Paul Ryan occupa un posto di riguardo sulla scena politica nazionale, ha aspirato senza successo alla Casa bianca, è lontano dalla natìa Janesville con la mente e con il cuore. Rick Wagoner, il capo della GM, viene licenziato nel 2009 dopo che ha chiuso altre quattordici fabbriche, ricco di 10 milioni di dollari di buonuscita, più 1, 65 milioni in premi annuali per i primi cinque anni di pensionamento, più 74 mila di pensione all’anno e una polizza vita di 2,6 milioni di dollari. Senza indulgere al moralismo, occorre prendere atto che i responsabili del destino di milioni di persone, i dirigenti industriali, finanziari e politici, non hanno pagato alcun prezzo per la loro sconsiderata ambizione, per la loro avidità, ma lo hanno scaricato sulle persone inermi e sulle future generazioni.
A parte la commozione che le storie di Janesville suscitano nel lettore, Amy Goldstein ci consegna alcune riflessioni su una tale catastrofe, utili a provvedere a quelle che potrebbero seguire (ora, dodici anni dopo la vicenda di Janesville, è intervenuta la battuta d’arresto della pandemia da Covid19). Il mondo avanzato, fino a poco tempo fa benestante, è attrezzato per far fronte alla sparizione del lavoro, al disfacimento del tessuto sociale che questo comporta? Si direbbe di no, le masse scontente e i giovani infuriati riempiono le piazze (e i bar, le discoteche, le spiagge). Se non fosse per un sistema politico-amministrativo che non funziona, noi italiani – a differenza della classe media della Janesville del 2008 – abbiamo nella memoria recente un’epopea di riscatto che va sotto il nome di miracolo economico.
I nonni lo hanno attraversato, e non dimenticano che quel “miracolo” era semplicemente il frutto della libertà di darsi da fare, di sopportare la fatica, di sperare in un mondo migliore. Era il risultato dell’operosità e dell’intelligenza di persone in carne e ossa, quelle che a Janesville come altrove vengono sottovalutate, mortificate, liquidate. Certo, ci vogliono i capitali, ci vogliono le tecnologie, occorre guardare i mercati. Ma senza il fattore umano tutto questo non serve a niente.