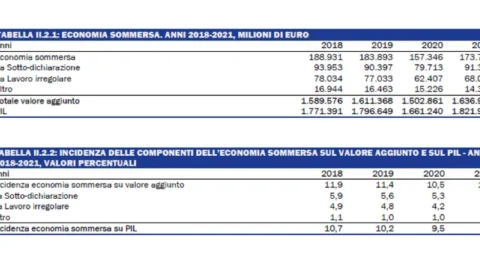Neppure un cortigiano consumato, cinico e scaltro come Polonio riuscirebbe a trovare un filo di logica in quella crisi schizofrenica che sta determinando – con la fuoriuscita dal gruppo ex Ilva di ArcelorMittal – un danno di dimensioni incalcolabili all’economia italiana, con la desertificazione di una vasta area del Mezzogiorno, perché sarà costretto a chiudere i battenti, insieme con la più grande acciaieria europea, persino il settore dell’indotto. Decine di migliaia di posti di lavoro sono a rischio.
Per rimediare a questa catastrofe annunciata (è dal mese di giugno che ArcelorMittalha fatto sapere che senza lo scudo penale se ne sarebbe andata), il Governo – che per le sue contraddizioni interne ha cambiato, su questo aspetto, le regole e le garanzie – sta cercando di nascondere un’enorme coda di paglia con un appello al patriottismo e all’unità nazionale contro lo straniero che, secondo le veline di Palazzo Chigi, si sta avvalendo di un banale pretesto (quale il volersi mettere al riparo da un atteggiamento persecutorio da parte della giustizia penale) per andarsene, dimostrando così di aver tramato per vincere la gara al solo scopo di ammazzare, come un cavallo azzoppato, un concorrente di peso sul mercato internazionale dell’acciaio. Siamo sempre lì: alle congiure dei poteri forti e delle multinazionali.
Ecco allora che si corre a chiedere aiuto alla magistratura, con la speranza che il tintinnar delle manette induca gli indiani spergiuri a fare retromarcia. Ma è insensata l’idea che una società straniera, come ArcelorMittal o qualunque altra impresa – grande o piccola che sia – possa essere obbligata da una sentenza ad investire in un affare andato a male e a gestire un’operazione fallimentare, in un territorio ostile. Come non sono previsti i lavori forzati, così non esiste l’attività imprenditoriale obbligatoria. Poi, passi che abbia deciso di occuparsi della vicenda, tuttora con un’indagine contro ignoti, la procura di Milano che dell’affaire è stata investita dalla società stessa allo scopo di verificare la facoltà e la legittimità della risoluzione del contratto.
Ma che i commissari straordinari – i medesimi che avevano preteso, a loro tutela, l’applicazione dell’impunità – presentino al tribunale di Taranto un esposto, denunciando, a carico di ArcelorMittal, “fatti e comportamenti, inerenti al rapporto contrattuale con ArcelorMittal, lesivi dell’economia nazionale”, ha il sapore di una tragica beffa. Ripetuta pochi giorni dopo a Milano. Certamente, la società non deve riconsegnare uno stabilimento morto, con gli altiforni spenti. E si è impegnata a non farlo in vista di un pronunciamento giudiziario. Ma quale era il contenuto dell’ordinanza del tribunale di Taranto che ha costretto ArcelorMittal a rinunciare all’operazione?
Recuperiamo il comunicato in cui la società ha spiegato le sue ragioni. “I provvedimenti emessi dal Tribunale penale di Taranto obbligano i commissari straordinari di Ilva a completare talune prescrizioni entro il 13 dicembre 2019 – termine che gli stessi commissari hanno ritenuto impossibile da rispettare – pena lo spegnimento dell’altoforno numero 2”.
Ora, sempre secondo l’azienda, le suddette prescrizioni “dovrebbero ragionevolmente e prudenzialmente essere applicate anche ad altri due altiforni dello stabilimento di Taranto”. Ma, tale spegnimento “renderebbe impossibile per la Società attuare il suo piano industriale, gestire lo stabilimento di Taranto e, in generale, eseguire il Contratto”.
Insomma, dove sta il problema? ArcelorMittal non lo dice esplicitamente, ma lo scudo penale, nella sua eccezionalità, era ritenuto un provvedimento necessario, in una realtà in cui la magistratura sembra avvalersi – dal 2012 ad oggi – dei suoi poteri per condurre una guerra spietata allo stabilimento siderurgico di Taranto, fino ad impedire, nei fatti, quei processi di risanamento richiesti, condizionandoli a modalità e tempi incompatibili con le caratteristiche dei processi produttivi della siderurgia e con un minimo di economicità dell’acciaieria (che attualmente perde due milioni al giorno).
È difficile dare torto a un investitore a cui si chiede l’impossibile, pretendendo che lo faccia, se non vuole incappare nei vincoli (e nei ceppi) della giustizia. Per meglio spiegare l’inghippo degli altiforni Marco Leonardi, a proposito del sequestro da parte della magistratura dell’altoforno numero 2, ha raccontato i fatti: “Dopo la morte tragica di un operaio nel 2015 il forno è stato sequestrato e per il dissequestro il custode giudiziario ne ha imposto l’integrale automazione. I Mittal sostengono che, se è così, essi dovranno procedere alle medesime innovazioni anche negli altiforni 1 e 4 (che sono del tutto simili al n.2), cosa molto complicata da realizzare nel breve periodo e che impedisce di arrivare alla produzione di 6 milioni di tonnellate prevista nel piano industriale (per essere automatizzato l’altoforno dovrà rimanere fermo per un periodo)”. E comunque non vi è tecnicamente la possibilità di automatizzare, entro la data stabilita, l’altoforno di cui si discute.
Al dunque il management dell’ex Ilva dovrebbe spegnere e contemporaneamente lasciare in funzione l’altoforno più importante dello stabilimento. In sostanza, rispondere penalmente sia della continuità del funzionamento che della chiusura degli impianti. Per compiere il loro dovere la procura di Milano dovrebbe indagare sui colleghi di Taranto, i quali dovrebbero inviare gli avvisi di garanzia, per danno all’economia nazionale, a se stessi, magari “fermo posta”.
Intanto, tardivi ragionamenti di disponibilità a riconoscere la crisi di mercato dell’acciaio – e a farsi carico delle conseguenze – provengono dalle organizzazioni sindacali, i cui leader sono stati ricevuti dal Capo dello Stato. Ma le difficoltà esistono anche al loro interno. Le denunciano l’immobilismo delle strutture territoriali tarantine e pugliesi, che hanno affidato ai soli lavoratori dello stabilimento l’onere di difendere il posto di lavoro insieme con un pezzo strategico dell’economia del Mezzogiorno e dell’Italia.