Non capita spesso che un giuslavorista sia in grado di influenzare le politiche del lavoro di un governo. Evitiamo di fare dei nomi e di portare degli esempi, proprio per sottrarsi a paragoni equivoci. Non tutti i giuslavoristi, maitre à pénser, elevati al rango di consiglieri dei ministri, hanno dato buoni suggerimenti; non tutti i governi, d’altra parte, sono stati in grado o hanno avuto la possibilità di capire e valorizzare compiutamente proposte tecnico-giuridiche apprezzabili. Oggi il giurista “di regime” è Pasquale Tridico, a cui Luigi Di Maio, “folgorante in soglio”, ha affidato la custodia dei gioielli della famiglia pentastellata ed in particolare di quel di “reddito di cittadinanza” che avrebbe dovuto cambiare la storia del Paese.
Tridico ci si è messo di impegno e ha impostato un provvedimento complesso, tanto articolato da essere sempre a rischio di smarrire il filo conduttore. Ma è riuscito a venirne a capo, anche se solo talune delle norme del dl n.4/2019 sono operative, mentre altre (le piattaforme digitali, l’outplacement, ecc.) sono messaggi rinchiusi in una bottiglia affidata alle onde del mare.
Tridico si è talmente immedesimato con la sua creatura da volerla seguire, fin dai primi vagiti, dal ponte di comando dell’Inps, l’Ente previdenziale e assistenziale più grande d’Europa, per il quale il fantomatico Reddito di cittadinanza è solo una delle tante prestazioni erogate, neppure tra le più importanti. Ma il ferro va battuto finché è caldo; e il successo coltivato finché c’è.
Col proposito di essere il protagonista di una nuova (o di una vecchia?) stagione del diritto del lavoro, il prof. Tridico si è lanciato in un’altra sfida: quella della durata dell’orario di lavoro. Così si è messo a spolverare la vecchia teoria del “lavorare meno per lavorare tutti”. «Siamo fermi in Italia all’ultima riduzione dell’orario di lavoro del 1969» ha affermato Tridico nei giorni scorsi, tenendo una lezione sulle diseguaglianze nel capitalismo finanziario alla facoltà di Economia della Sapienza, a Roma. «Non ci sono riduzioni da 50 anni e invece andrebbe fatta. Gli incrementi di produttività vanno distribuiti o con salario o con un aumento del tempo libero. Con questa riduzione aumenterebbe l’occupazione».
Con tali affermazioni il consigliere ministeriale ha inserito una pulce nell’orecchio del vicepremier Luigi Di Maio secondo il quale il tema sollevato «merita approfondimenti e massima discussione con le imprese e i rappresentanti dei lavoratori». In realtà, le argomentazioni del professore sono più articolate. Lorenzo Savia ha riportato sul Corriere della Sera un ragionamento più complesso che Tridico aveva svolto, in una occasione precedente e in veste di studioso, in un post sul blog del M5S. Le politiche per l’occupazione, aveva scritto allora Tridico, dovranno anche tener conto dell’avanzare della robotizzazione che mette a rischio i posti di lavoro. Per contrastare questa tendenza «il primo passo sarà la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario per aumentare l’occupazione e incentivare la riorganizzazione produttiva delle imprese». In quel post il professore proponeva anche la «banca delle ore come strumento per superare lo straordinario e la possibilità per il lavoratore di determinare l’inizio e il termine dell’orario di lavoro nell’ambito di una fascia di presenza obbligatoria».
Fino a qui la cronaca. Non c’è dubbio che l’uscita del neocommissario (e futuro presidente) dell’Inps, ha colto impreparati tanto il mondo della politica quanto i sindacati. Questa circostanza dovrebbe indurre ad una riflessione autocritica su come sono stati affrontati i due temi identitari del Reddito di cittadinanza e delle pensioni da parte delle forze politiche, sociali e culturali che si oppongono all’attuale maggioranza giallo-verde e al governo che essa esprime. Mentre su “quota 100 e dintorni” era ben visibile fin dall’inizio un filo rosso che legava, sia pure con uno sviluppo arabesco, le posizioni della Lega ad altre variamente presenti nel sindacato e nella sinistra dentro e fuori dal Pd, sul Reddito di cittadinanza l’atteggiamento del campo avversario è stato quello della incredulità, della convinzione che si trattasse di un ballon d’essai destinato a restare tale e quindi da non prendere sul serio. E invece ci troviamo in compagnia di una robusta manomissione della riforma Fornero e dell’istituzione del Reddito di cittadinanza: misure impastate, cotte e mangiate nei boudoir della maggioranza.
Per carità, il mio non è un rimpianto per una mancata collaborazione con questa maggioranza e con le sue politiche. È solo la sottolineatura dell’incapacità di proporre un’alternativa magari in anticipo. Come scrive Marco Leonardi nel saggio “Le riforme dimezzate” il REI – una misura più organica e meno pasticciata del Reddito di cittadinanza e rivolta al contrasto della povertà – è arrivato troppo tardi e con scarse risorse a disposizione. “Nel gennaio 2017, al passaggio del testimone da Renzi a Gentiloni, la legge delega sulla povertà era ancora da discutere al Senato, senza nessuna certezza sui tempi, tant’è che si rischiava di andare alle elezioni senza averne terminato l’iter. Fu trovato – prosegue Leonardi – non senza qualche difficoltà un accordo che prevedeva l’impegno del governo a scrivere molto rapidamente i decreti attuativi… in cambio della rinuncia, da parte del Senato, di non presentare emendamenti al disegno di legge delega”. In pratica il primo dicembre del 2017 il REI divenne operativo, ma non fu organizzata una pubblicità efficace e, soprattutto, le elezioni erano ormai a pochi mesi. In sostanza, sostiene Leonardi (già consigliere dei governi di centro-sinistra), se la scala delle priorità avesse anteposto l’adozione di uno strumento di lotta alla povertà ad altre misure, forse le cose sarebbero andate diversamente. Così non fu, nonostante che fosse arcinoto l’impegno propagandistico del M5S sul reddito di cittadinanza.
E che dire della questione salariale? Se fosse stata affrontata nel modo giusto attraverso una riduzione del cuneo fiscale e dell’incremento della produttività anche attraverso un maggior uso della contrattazione di prossimità, forse oggi non saremmo qui a dover rincorrere un disegno di legge sul salario minimo per sventarne gli effetti devastanti sulla contrattazione, sul costo del lavoro, sulle imprese e di conseguenza sull’occupazione.
È il caso, allora, di tornare ad occuparsi dell’orario di lavoro, prima di trovarci a fare i conti con una legge, affetta da “mal francese” che pretenda di ridurre l’orario settimanale di lavoro a 35 ore, in modo generale e astratto, allo scopo di contrastare l’avvento delle nuove tecnologie. Oltralpe caddero nella trappola del 35 ore alla fine del decennio ’90 e non sono stati più in grado di uscirne, nonostante l’evidente fallimento. In Italia in quegli stessi anni la mistica delle 35 ore persuase Rifondazione comunista a togliere l’appoggio al primo Governo Prodi. Ritornare su quei passi sarebbe un guaio, perché verrebbe applicata la stessa regola a situazioni in movimento e a processi graduali di modifiche dell’organizzazione del lavoro. Un conto è avvalersi dello strumento della riduzione dell’orario di lavoro in parallelo con l’ingresso di nuove tecnologie che cambiano i prodotti e il modo di produrre, allo scopo non solo di salvaguardare i livelli di occupazione, ma di assicurare quella flessibilità degli orari di cui hanno bisogno le imprese, all’interno della quale possono trovare risposta anche le esigenze dei lavoratori (per esempio grazie ad una maggiore diffusione del lavoro agile, magari attraverso la revisione di una regolamentazione ora ingessata).
È necessario allora un impegno straordinario delle organizzazioni sindacali, almeno all’altezza di quello che si sviluppò alla fine degli anni ’50 e nei primi anni ’60 del secolo scorso. In questi ultimi anni i sindacati si sono impegnati più sulle pensioni che sul lavoro, arrivando al punto di tutelare i giovani per quando andranno in quiescenza. In pochi (si veda il contributo di Marco Bentivogli nel libro “Contrordine compagni”) si sforzano di immaginare e proporre politiche rivendicative in grado di tenere il passo con lo sviluppo tecnologico.
Uno dei più grandi sindacalisti del secolo scorso, un maestro per intere generazioni di dirigenti sindacali, nella sua lettera-testamento rivolta a Cgil, Cisl e Uil, scriveva: ‘’Tra l’altro vi si dovrebbe aggiungere la necessità di una ripartizione del lavoro. Passaggio obbligato, se l’obiettivo del pieno impiego deve essere preso sul serio. Oppure l’esigenza di intervenire sul cuneo fiscale che oggi pesa in maniera squilibrata sul lavoro dipendente rispetto agli altri redditi. O ancora sulla urgenza di migliorare le competenze, e quindi la produttività, con investimenti, non puramente simbolici, sul “capitale umano” e quindi sulla formazione continua’’. Allora, il richiamo al “passaggio obbligato” della distribuzione del lavoro fu considerato – con troppa fretta e poca capacità di visione – una nostalgia del passato.


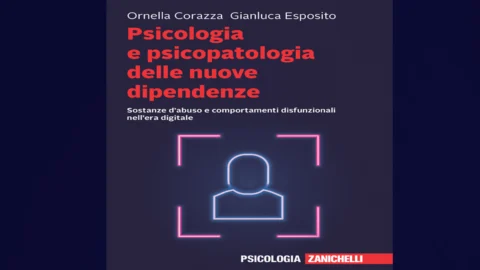
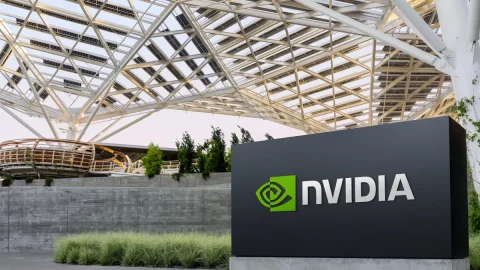


Molti anni fa pubblicai un opuscolo sul valore dei soldi e la gestione dell’occupazione e della forza lavoro. Allora era prematuro, ma oggi tremendamente attuale… “Il denaro di cesare”… vi sonsiglio di leggerlo.
(Capitoli principali Occupazione integrale, Leva civile, Formazione polifunzionale) Potete scaricarlo qui gratuitamente:
https://drive.google.com/open?id=1zqmSpQxwlb_XtEXNQgoGwnkUeDpq9-mc
Eventualmente acquistarlo qui:
https://books.google.it/books?id=0ykrDwAAQBAJ&pg=PP1&lpg=PP1 dq=il+denaro+di+cesare&source=bl&ots=IsIwAsISTZ&sig=ACfU3U2xmdn2fDIP7Dl5Gxk7RUJRx5OWYg&hl=it&sa=X&ved=2ahUKEwiemIHop_ToAhUTV8AKHbofCQc4FBDoATACegQIDBAr#v=onepage&q=il%20denaro%20di%20cesare&f=false
Oppure in Amazon sotto il medesimo titolo