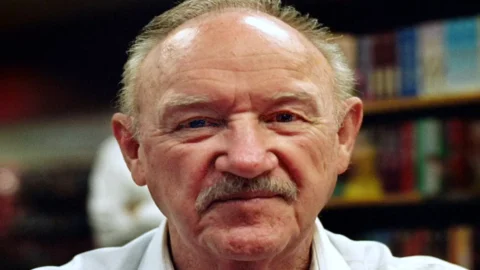Se cedono i tiranti
In lingua inglese sono usciti due libri importanti di due intellettuali molto diversi tra loro, ma accomunati dalla capacità di analizzare, di osservare e di raccontare le vicende del nostro tempo oltre il pensiero dominante e convenzionale sia che questo appartenga a una visione del mondo sia che appartenga a quella concorrente. C’è una grandissima necessità di gettare dei tiranti tra questi due territori che stanno andando alla deriva in direzioni opposte. La necessità di saldare questa faglia, così come fece Erasmo, è forse l’imperativo delle menti più brillanti e illuminate del nostro tempo. Sto parlando di due persone che è difficile incasellare anche in una professione o in una disciplina sociale. Sto parlando di Francis Fukuyama e Kwame Anthony Appiah. Proprio per schematizzare al massimo il primo potrebbe essere inscritto nell’area del pensiero, diciamo, neoconservatore che si origina con le riflessioni di Burke sulla rivoluzione francese, mentre il secondo potrebbe stare nella grande corrente dell’illuminismo nella sua variante più cosmopolita. Ma nessuno dei due disdegna di attingere spunti, riflessioni idee e soluzioni dall’altro campo.
“Diamine! ci saranno delle idee buone nell’altro campo? Vogliamo giudicarle sulla base del loro valore e non dell’appartenenza di chi le esprime!”, viene da commentare! È quello che pensa anche Thomas Friedman, uno delle più importanti firme del giornalismo mondiale, editorialista nel New York Times, autore di bestseller e fustigatore indefesso di Trump, quando si esprime così: “La mia posizione politica è molto eclettica. Nel mio libro [Grazie per essere arrivato tardi, Mondadori] spiego che, per alcune cose, appoggio la sinistra di Bernie Sanders. Penso che l’assistenza sanitaria deve essere a carico dello Stato. Allo stesso tempo sono d’accordo con gli editoriali del “Wall Street Journal”, perché concordo con l’abolizione tutte le tasse sulle imprese per sostituirle con una tassa sulle emissioni di CO2, una tassa sulle armi, una tassa sullo zucchero e una piccola tassa sulle transazioni finanziarie”.
Non è un viaggio per niente agevole attraversare i confini senza attirarsi i proiettili dei guardiani di frontiera. Ne sa qualcosa Hannah Arendt quando con il suo La banalità del male, malgrado la fondatezza delle sue tesi, fu colpita dal furore identitario della sua stessa comunità, compreso quello degli amici più intimi. Un tratto che i film della Von Trotta sulla filosofa tedesca ricostruisce molto bene
Il “master concept” della storia
Ma torniamo al mix teorico – che somiglia più a un moderno mash-up – di Fukuyana– che ha un po’ irritato il critico del liberal “The New Yorker” nel recensire il suo libro. Fukuyama è convinto che il servizio nazionale sanitario all’europea e la leva militare obbligatoria siano collanti sociali indispensabili per evitare la deriva delle identità e la tenuta della coesione sociale. Fukuyama individua nell’identità e nella volontà di riconoscimento il “master concept” della storia. Questo concetto non spiega soltanto i fenomeni attuali come Vladimir Putin, Osama bin Laden, Xi Jinping, Black Lives Matter, #MeToo, i matrimoni gay, l’ISIS, la Brexit, il ritorno dei nazionalismi europei, i movimenti anti-immigrazione, la politica identitaria nei campus, e l’elezione di Trump, ma spiega anche quelli del passato come la Riforma Protestante, la Rivoluzione francese e russa, il comunismo cinese, il movimento dei diritti civili e quello delle donne, il multiculturalismo, e, anche, il pensiero di Lutero, Rousseau, Kant, Marx, Nietzsche, Freud e Simone de Beauvoir . Tutto ciò ha una matrice comune, la Repubblica di Platone. Non è un bel mash-up, no?
Questa capacità di spaziare nella storia, nella filosofia, nelle religioni, nella geopolitica globale, nella psicologia di massa, nelle scienze per rintracciare degli antenati ai fenomeni del nostro tempo, spiegati così nel lungo periodo, è una delle caratteristiche salienti dei pensatori più brillanti della generazione successiva a Fukuyama che trova delle espressioni eccelse in intellettuali come Yuval Noah Harari o Malcolm Gladwell.
Kwame Anthony Appiah appartiene allo stesso stampo dello storico israeliano e del sociologo canadese. Come i suoi colleghi è cresciuto intellettualmente in un contesto specifico, è poliglotta, è cosmopolita ed è profondamente radicato in due culture, quella africana e quella europea. Il suo è quindi un osservatorio unico per giudicare i fenomeni del nostro tempo in cui il “master concept” dell’identità – che Appiah rinomina “essenzialismo” – è tornato a dominare i comportamenti pubblici.
Chi è Michael Ignatieff
Su questi due libri è intervenuto Michael Ignatieff che proviebe da uno degli ultimi territori della democrazia liberale che ancora conta qualcosa. Per molti anni Ignatieff è stato il leader del Partito Liberale canadese che è tornato al governo del grande Stato nordamericano nel 2015 sotto la leadership di Justin Trudeau. Ignatieff è stato il leader del Partito liberale e capo del gabinetto ombra dal 2008 al 2011 sotto il governo conservatore Stephen Harper. Il Canada è oggi il più interessante laboratorio politico del liberalismo del futuro e Ignatieff ha dato un contributo importante a questo progetto, sebbene sotto la sua direzione il Partito Liberale abbia subito la più grande sconfitta elettorale della sua storia.
Storico di formazione ha insegnato a Cambridge, Oxford, Harvard e Toronto. Ha molta familiarità con i media: ha lavorato in BBC, diretto un documentario Blood and Belonging: Journeys into the New Nationalism che ha ricevuto molti riconoscimenti, così come il libro che porta lo stesso titolo. Ha scritto un libro di memorie, Russian Album, e il suo romanzo, Scar Tissue, è entrato nella lista del Booker Prize del 1994.
Siamo quindi lieti di offrirvi il commento di Ignatieff a questi due importanti contributi sulla politica dell’identità e sulle sue ripercussioni sulle democrazie liberali.
Le possibile conseguenze del furore identitario
La politica dell’identità sta facendo a pezzi la democrazia moderna. C’è qualcosa di insaziabile nel nella ricerca di una qualche identità. Vogliamo essere riconosciuti come uguali, ma vogliamo anche essere considerati come individui unici. Vogliamo che le identità di gruppo – come le donne, gli omosessuali, le minoranze etniche – siano riconosciute come uguali, ma vogliamo anche che siano riparati i torti che questi gruppi hanno subito nel corso del tempo. Non si capisce come una moderna democrazia possa soddisfare all’unisono tutte queste richieste – in cui tutti gli individui sono considerati uguali, la loro unicità rispettata come qualcosa di speciale e le rivendicazioni del loro gruppo riconosciute e soddisfatte. Qualcosa può rompersi, e ciò che potrebbe cedere è la capacità stessa della società democratica liberale di stare insieme. Qualcosa deve avvenire e quello che può accadere e il venir meno della capacità di coesione sociale delle democrazie moderne.
Questa è, in estrema sintesi, la diagnosi di Francis Fukuyama sulla crisi dell’identità che affligge la moderna democrazia liberale. Fukuyama, un prolifico teorico sociale della Stanford University, è meglio conosciuto come autore di La fine della storia e L’ultimo uomo (1992). In realtà non ha mai detto che la storia fosse finita con la caduta del comunismo. Ciò che era finito era la visione marxista di una transizione rivoluzionaria a una società collettivista. Lungi dall’essere un trionfante apologeta della democrazia liberale, asserì che, senza la competizione di utopie alternative, il sistema democratico avrebbe affrontato un futuro desolante. Il suo nuovo libro Identity rimane critico sulla capacità delle democrazie liberali moderne di raccogliere la sfida dell’identità che minacciano di distruggerle.
L’analisi e i rimedi di Fukuyama
Il populismo della destra, scrive Fukuyama, ha alimentato i risentimenti di coloro che sono stati esclusi dall’avvento delle élite accreditate che dominano i media, l’alta finanza e le università. I populisti di sinistra hanno alimentato il risentimento delle minoranze, mentre non fanno alcuno sforzo per riunirle alla maggioranza bianca, dalla quale di fatto si sono separate. Né può la celebrazione liberale delle diversità ricomporre la frattura sociale con una retorica di vittimizzazione. La diversità può essere un aspetto dell’esistenza, ma diventa un valore in comune solo se le persone diverse vivono effettivamente insieme. Invece nelle città multiculturali del XXI secolo – Los Angeles, Londra, Toronto – non vivono insieme, vivono fianco a fianco, in quartieri auto-segregati per razza, lingua, religione ed etnia.
Se la politica dell’identità sta polarizzando le società democratiche fino al punto di non ritorno, qual è la via d’uscita? I rimedi di Fukuyama includono il servizio obbligatorio di leva, sia militare che civile, in modo che i giovani imparino a lavorare con persone di origini diverse per costruire insieme delle azioni e dei progetti. “Il servizio di leva obbligatorio sarebbe una forma contemporanea di repubblicanesimo classico, una forma di democrazia che ha mostrato di saper incoraggiare la virtù e l’entusiasmo pubblici dei cittadini piuttosto che il perseguimento dei loro interessi e dei loro bisogni individuali”, scrive in un passo del libro.
Oltre al servizio di leva, Fukuyana difende con ardore una nozione molto controversa – quella che i tedeschi chiamano un Leitkultur –, cioè una cultura guida, a cui tutti i nuovi arrivati dovrebbero aderire e che dovrebbero apprendere per diventare cittadini. Un altro collante sociale decisivo è il sistema sanitario nazionale che unisce tutti i cittadini di una comunità, indipendentemente dalle loro identità. L’America ha certamente bisogno di un sistema sanitario finanziato con fondi pubblici, ma i paesi che hanno l’assistenza sanitaria nazionale, come il Canadà e la Gran Bretagna, non sono sfuggiti alla polarizzazione dell’identità.
Una vera politica di identità nazionale richiederebbe molto di più che investire in beni pubblici condivisi. Richiederebbe anche politiche che amplino le opportunità delle persone e riducano le disuguaglianze tramite la tassazione dell’eredità e dei patrimoni. Una campagna comune contro le disuguaglianze economiche, che attraversano le nostre identità razziali, di genere e etniche, potrebbe riunirle meglio di altre cose. Franklin Roosevelt ci riuscì, ma ricordiamo cosa ha affrontato: la resistenza dei privilegiati è destinata ad essere feroce.
I rimedi di Fukuyama possono essere sintomatici del problema di cui stiamo discutendo: troppo conservatore per i liberal e i progressisti, troppo statalista per i conservatori. Ma c’è qualcosa che ha senso in essi: l’istinto per la politica dell’identità è un sintomo della decadenza della democrazia e una deviazione dal vero compito di questa. Che è quello di unire, coalizzare i gruppi nello sforzo di superare le differenze, rafforzare i beni pubblici condivisi, ricostruire i gradini delle opportunità economiche e valorizzare la comune identità umana.
La teoria dell’essenzialismo di Kwame Anthony Appiah
Il filosofo Kwame Anthony Appiah porta a questo dibattito un forte sensibilità nei confronti delle frottole che raccontiamo a proposito delle nostre personali narrazioni di identità. Il suo stesso background esemplifica perfettamente le complessità che spesso neghiamo, ad esempio, quando utilizziamo tipologie razziali di “bianco” e “nero”. Il nonno di Appiah era Sir Stafford Cripps, cancelliere del governo laburista di Clement Attlee dal 1945 al 1951. La figlia di Cripps sposò il padre di Appiah, un leader tribale degli Asanti, che si unì al movimento indipendentista di Kwame Nkrumah nel Ghana coloniale. Appiah è compiaciuto della confusione che deriva quando le persone non riescono a “piazzare” qualcuno come lui che è a suo agio sia in Ghana e che in una contea inglese.
Come afferma in un libro elegante e ironico, The Lies That Bind, che ha scritto dopo una Reith Lecture per la BBC nel 2016, la confusione che il suo status provoca nelle persone deriva da un errore cruciale che egli chiama “essenzialismo”. Non esiste un’identità essenziale chiamata “nero” o “bianco”, più di quanto non ci sia nel significato binario di “genere”. L’identità è una bugia che ci imprigiona quando le permettiamo di prendere campo, ma, allo stesso tempo, rimane un’altrettanta bugia quando supponiamo di essere liberi di scegliere a piacimento le nostre identità.
Le storie di Appiah sull’identità servono a illuminare la complessa interazione tra ciò che ereditiamo e ciò che noi stessi elaboriamo.
Il codice open source della identità religiosa
L’identità religiosa, scrive, non è fissata dalla dottrina, ma è un dialogo interiore, sempre in evoluzione, tra fede e dubbio. La madre di Appiah, di fede anglicana, una volta disse a William Temple, arcivescovo di Canterbury, che aveva difficoltà a credere in ciascuno dei 39 articoli che definiscono la religione anglicana. “Sì, è difficile da credere”, rispose, lasciando a sua madre il compito di capire, per il resto della sua vita, che il dubbio non era il nemico della fede, ma il suo costante compagno.
La sua identità cristiana lasciava spazio al dubbio, ma allo stesso modo, altri credenti credono che la loro fede non richieda loro alcun ripensamento. I fondamentalisti predicano un ritorno all’ortodossia scritturale per fissare un’identità scolpita nella pietra in modo che non venga scalfita dalla modernità. Ma le identità religiose si rifiutano di essere fossilizzate in questo modo. Le religioni sopravvivono, sostiene Appiah, proprio perché sono codice “open source”. Il Libro del Levitico dell’Antico Testamento può vietare l’omosessualità, ma i credenti gay cristiani ed ebrei hanno trovato modi, come dice Appiah, di interpretare tale ingiunzione. Infine, i credenti dal cuore grande non si preoccupano molto dei confini posti dall’ortodossia. Il padre di Appiah era un cristiano praticante, ma pensava che non ci fosse nulla di strano nel onorare i suoi antenati Asante una volta all’anno versando il Kaiser Schnapps (“il liquore dei re”) sui luoghi sacri di famiglia, una pratica che continua tuttora suo figlio.
Le bugie dell’essenzialismo
I nazionalisti, come i fondamentalisti religiosi, insistono sul fatto che esista un’essenza di nazionalità che ti identifica, come una vernice, con caratteristiche specifiche. In realtà, l’identità nazionale è una sorta di competizione continua nel definire chi e che cosa appartenga al “noi” nazionale. Nel 2016, Boris Johnson ha detto che la Brexit riguardava ” il diritto della gente di questo paese di stabilire il proprio destino”. Di quali persone, Appiah si chiede, sta parlando l’ex ministro degli esteri del Regno Unito? Non gli scozzesi, non gli irlandesi del nord, non i londinesi che hanno votato in modo schiacciante per rimanere. La Brexit ha messo a nudo tutte le differenze – regionali, di interessi, di reddito, di storia e di istruzione – su cui il nazionalismo britannico “essenzialista” vuole passare di sopra.
Per quanto riguarda la razza, Appiah smantella sia le categorie stabilite di “razza” sia quella scomunica morale universale – il “razzismo” – ricordandoci di un periodo in cui persone istruite credevano che tutti noi discendemmo da Adamo e si rifiutavano di vedere le caratteristiche “razziali” come marcatori irrevocabili di differenza. Il filosofo Leibniz, ad esempio, pensava che il linguaggio fosse un segno di identità più profondo della razza. Fu solo con l’avvento degli imperi europei e la sottomissione delle razze non bianche, afferma Appiah, che la nostra idea di identità razziale rimase intrappolata in una visione che confonde le differenze che, piuttosto, dovremmo attribuire alla storia, alla cultura – e all’imperialismo – con le differenze biologiche.
Anche le nostre differenze culturali vengono “essenzializzate”, con gli europei che credono di essere eredi di qualcosa chiamata “civiltà occidentale”, una di quelle bugie che impediscono di vedere ciò che l’Occidente deve alle altre culture. Quando diciamo che Aristotele, Platone e Socrate sono padri del canone occidentale, dimentichiamo che il greco e il latino si erano quasi del tutto estinti nell’Europa settentrionale del Medioevo e l’Europa recuperò il loro lavoro grazie alle traduzioni di studiosi arabi e islamici di Cordoba, Siviglia e Toledo.
Appiah è sprezzante delle controversie sulla “appropriazione culturale”, la convinzione, cioè, che quando le persone scrivono o agiscono con principi di altre culture, stiano effettuando in una sorta di furto. L’idea stessa di appropriazione interculturale è sbagliata, sostiene Appiah, perché considera la cultura come se fosse un oggetto di proprietà che appartiene a un solo gruppo. È come se i difensori dell’integrità culturale cercassero di applicare i regimi di proprietà intellettuale della grande industria farmaceutica. La cultura in realtà non appartiene a nessuno.
La meritocrazia non è una risposta
Quindi, come pensa Appiah si possa sfuggire dalla prigione dell’identità “essenzialista”? Una risposta, che sottopone a un attento esame, è l’idea di società meritocratica. Nel 1958 il sociologo britannico Michael Young ha sviluppato la visione di una tale società in cui il riconoscimento pubblico, lo status e il potere non sarebbero determinati dalla razza, dalla classe, dal genere o dalla cultura, ma dalle capacità personali, determinate dalle credenziali educative. L’università è diventata così il tempio di questa visione. Molte persone hanno acquisito una buona istruzione per sfuggire ai confini delle loro identità ereditarie.
L’ironia – che lo stesso Young vede – è che una società che crede di offrire le pari opportunità attraverso l’educazione ha finito per legittimare nuove disuguaglianze basate sulle quelle stesse credenziali. L’ideale meritocratico promette una fuga dalla politica dell’identità, ma alimenta solo le angosce dell’identità di chi ha abbandonato la scala meritocratica. Chi ha abbandonato gli studi e gli operai hanno spinto la Gran Bretagna alla Brexit e Donald Trump alla Casa Bianca. Una volta le università credevano di essere la risposta alle disuguaglianze di identità. Ora si rendono conto che fanno parte di quel problema.
La soluzione, che ci porterebbe davvero fuori dalla prigione della politica dell’identità e dalla falsa soluzione della meritocrazia, sarebbe quella di ignorare coscienziosamente ogni segno dell’identità – razza, classe, genere, studi, il destino – e concentrarsi solo sul temperamento e sul carattere quando assegniamo status, potere e prestigio. Un individualismo intransigente di questo tipo – che cerca coscientemente di vedere e valutare gli individui separatamente dalle loro identità di gruppo – potrebbe aiutarci a superare le richieste di riconoscimento e di riparazione che ci dividono così profondamente.
Siamo molto lontani da quest’utopia, ma è quella che ci hanno indicato John Stuart Mill e Martin Luther King e che sembra essere ancora la destinazione giusta.
Francis Fukuyama, The Demand for Dignity and the Politics of Resentment, Farrar, Straus and Giroux, pagine 240.
Kwame Anthony Appiah, The Lies That Bind: Rethinking Identity, Profile, pagine 256.