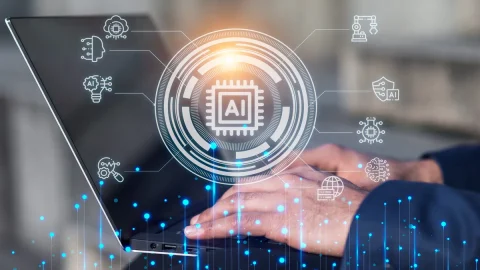In queste settimane, in cui è in corso la “prise du pouvoir” da parte della coalizione giallo-verde, ho letto – lo faccio ad ogni scadenza, ma questa volta ci ho messo più attenzione ed ho allargato l’orizzonte – i rapporti istituzionali sulla situazione del Paese. Ricordo i principali (che si aggiungono alla consultazione dei monitoraggi periodici sull’andamento del mercato del lavoro e del sistema pensionistico): il XVII Rapporto annuale dell’Inps, il Rapporto 2018 della Corte dei Conti sul coordinamento della spesa; l’ottavo Rapporto annuale sugli stranieri nel mercato del lavoro in Italia. Da ultimo, ho trovato interessante un recentissimo Inapppolicybrief (n.9 del 2018) sul ricorso al lavoro accessorio e domanda di lavoro discontinuo.
Leggendo questi documenti ho tratto un’impressione che ritengo utile condividere: è stato come se gli enti, i centri studi, i ricercatori che hanno elaborato questi rapporti lo abbiano fatto a futura memoria. In breve, per lasciare scritto ai posteri come andavano veramente le cose in Italia prima che il Grande Fratello giallo-verde riuscisse a passare soltanto le menzogne di regime. In sostanza, come se gli ultimi “giusti” rimasti ad occupare i loro incarichi, prima della ghigliottina dello spoils system de noantri, abbiano approfittato dei mesi della transizione per inserire, in bottiglie affidate alle onde del mare, le mappe dei luoghi segreti – sfuggiti alle devastazioni – in cui le generazioni future potranno reperire preziosi documenti contenenti la vera storia del loro Paese, prima delle invasioni e delle dominazioni barbariche.
La pubblicazione dell’Inapp (ex Isfol) si misura con uno dei temi – quello della c.d. precarietà – che maggiormente ha contribuito all’affermazione delle nuove teorie dominanti secondo le quali non contano i fatti, gli eventi e i processi, ma la percezione “democratica” che il popolo ha di essi. Lo studio esamina la consistenza dei rapporti di lavoro accessorio e discontinuo sulla struttura complessiva dell’occupazione in conseguenza degli effetti delle ricorrenti modifiche legislative degli ultimi anni, ispirate ora a politiche permissive ora a vere e proprie persecuzioni di carattere ideologico.
A seconda della differente ispirazione delle norme, le tipologie del lavoro discontinuo e accessorio allargano o restringono il loro ambito di intervento, si rincorrono, prendono il posto l’una delle altre. È una sorta di gioco dei quattro cantoni dove tocca ad una forma di volta in volta presa di mira a stare in mezzo, prima di tornare (si veda il caso dei voucher) in voga. Ma a conti fatti, il brief arriva a delle conclusioni che invitano a riflettere. L’evoluzione dell’utilizzo delle forme di lavoro discontinuo – sostiene il documento – evidenzia una reazione quasi immediata dei datori di lavoro a provvedimenti di limitazione da un lato e di liberalizzazione dall’altro, riducendone l’utilizzo nel primo caso e estendendolo nel secondo.
Soprattutto, avviene un travaso della domanda di lavoro discontinuo verso le forme relativamente meno regolate, che certamente in parte cela l’utilizzo di tali forme come rivestimento legale di lavoro irregolare o sommerso. Quanto però avvenuto dopo l’introduzione della tracciabilità dei voucher nell’ottobre del 2016, quando è aumentato l’utilizzo del lavoro a chiamata che pure prevede criteri di utilizzo stringenti e la tracciabilità sin dal 2012, porta a ritenere che esista una domanda di lavoro discontinuo per così dire genuina, cioè motivata da esigenze di carattere organizzativo-produttivo anziché dalla volontà di utilizzare strumenti legali per occultare lavoro sommerso.
È sintomatico infatti – il punto è importante – che sia prima della riforma del 2012, che limita l’utilizzo del lavoro a chiamata e al contempo liberalizza l’uso dei voucher, sia dopo l’abolizione di questi ultimi vi sia una base di domanda di lavoro discontinuo stimabile in almeno 10 milioni di ore al mese. Tale domanda ha esigenze distinte da quelle che legittimano l’utilizzo di contratti di lavoro a tempo determinato o in somministrazione, per i quali è prestabilito il monte orario di lavoro. Il policy maker può ritenere che le conseguenze del lavoro discontinuo per il lavoratore, correlate al potere unilaterale del datore di lavoro di stabilire se e quando la prestazione avrà luogo, siano inaccettabili.
Il rischio di tale posizione è che l’effetto travaso, che il policy brief di Inapp ha messo in evidenza, avvenga verso forme “povere” di lavoro autonomo, o verso il lavoro sommerso, privando in questo modo il lavoratore di tutele giuslavoristiche, sociali e previdenziali (che pure sono previste in tutte le fattispecie regolate). Un accostamento alternativo – ecco l’ardua sentenza che condanna certe discutibili teorie abolizioniste – consiste nel prendere atto dell’esistenza della domanda di lavoro discontinuo, e a ritenerla accettabile (solo) nella misura in cui le esigenze organizzative e produttive del datore di lavoro possano essere contemperate con quelle del lavoratore di ottenere certezza di un quantum di protezione. Tale posizione porta a considerare fondamentale ed ineludibile l’adozione di una rigorosa tracciabilità di qualsiasi forma di lavoro discontinuo.