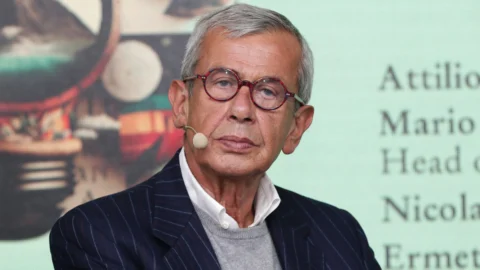Negli ultimi anni della sua vita, tra il 1870 e il 1880, Gustave Flaubert lavorò al Dictionnaire des idées reçues, un dizionario dei luoghi comuni che completava il Bouvard et Pécuchet, a sua volta studio tragicomico della superficialità e stupidità di tanti suoi contemporanei superinformati e sottoacculturati. Flaubert era affascinato e ossessionato dal chiacchiericcio pretenzioso e approssimativo e la sua perversione lo portò a leggere avidamente 1500 libri a suo stesso dire insulsi e insignificanti per riuscire a immergersi in quel modo di pensare. In questo senso Flaubert può ben essere considerato un anticipatore dell’histoire des mentalités proposta dalla scuola storiografica delle Annales. Non una storia del pensiero alto, ma un’analisi delle credenze diffuse.
Non c’è dubbio che tra le idee fatte dei nostri giorni cui Flaubert dedicherebbe attenzione c’è quella per cui la Cina ha già vinto (o è a un passo dal vincere). Ha già vinto nella tecnologia (5G, intelligenza artificiale, fintech), nell’economia (crescita doppia rispetto all’America e tripla rispetto all’Europa), nella politica (il modello neoconfuciano è più stabile ed efficace), nel soft power (la conquista dell’Africa, la nuova via della seta, l’unificazione dell’Eurasia) e nella capacità di visione strategica. Basta scorrere i siti internazionali di novità librarie e si noterà che non c’è un giorno in cui non esca un libro che ci spiega come la Cina sia il paese del futuro.
Altrettanto ampia, d’altra parte, è la bibliografia sul declino americano, sulla Finis Europae, su Silicon Valley che dorme sugli allori e non inventa più niente, sulla produttività in declino strutturale, su Trump che sfascia l’Occidente, sulle derive populiste (Is Democracy Dying? si chiede con angoscia la copertina di Foreign Affairs di giugno), sul debito che continua a crescere, sulle montanti malatttie dello spirito (xenofobia, nazionalismo, atomizzazione) che spariscono miracolosamente dall’orizzonte se si riprende a parlare di Cina.
Poi capita che, giusto per verificare, si vada a guardare come le grandi borse del mondo abbiano reagito in questi anni alla grande trasformazione in corso e ci si aspetta che, nella loro sapienza collettiva, i mercati non abbiano potuto che confermare e festeggiare il sorpasso cinese. E qui cominciano le sorprese.
Si va a confrontare la chiusura delle borse di un giorno qualunque come con quella del 12 luglio 2015, tre anni fa. La borsa americana è cresciuta da allora del 32.1 per cento. Il Dax dell’Europa in brillante ripresa è salito di un quarto, il 7.8 per cento. L’indice della borsa di Shanghai è sceso dell’11.8 per cento. Chi avesse investito 100 su New York si ritroverebbe con 132.1, se l’avesse fatto su Shanghai avrebbe oggi 88.2, una differenza di 43.9 punti. Qualcuno dirà, sì, ma il cambio? Niente, il cambio peggiora solo le cose dal momento che il dollaro si è apprezzato del 7.9 per cento in questi tre anni rispetto al renminbi, innalzando l’outperformance dell’America sulla Cina al livello piuttosto impressionante di 51.8 punti.
Si dirà che non vale, nel 2015 la borsa cinese è andata in bolla e poi è crollata, un anno disordinato, insomma, e poco rappresentativo. Andiamo allora indietro non di tre ma di cinque anni, al 12 luglio 2013, una fase abbastanza tranquilla per tutti. Lo Standard and Poor’s chiuse a 1680, ora è a 2787, un aumento del 65.9 per cento. Il Dax è cresciuto nel frattempo del 51.7 e Shanghai del 37.3.
Bella forza, si obietterà, le borse occidentali hanno avuto un forte rimbalzo dopo il disastro del 2008-2009 e questo falsa il confronto con la Cina, che durante la Grande Recessione non subì danni. Andiamo allora indietro di 10 anni, al 12 luglio 2008, giusto qualche settimana prima del crollo. Bene, da quel giorno fino a oggi Shanghai è salita dell’1.2 per cento, il Dax del 93.9 e New York del 121.2 per cento, esattamente cento volte di più della Cina (il cambio tra dollaro e renminbi era praticamente lo stesso di oggi).
Va bene, dirà ancora qualcuno, ma solo i pigri (e quelli che volevano evitare le commissioni di gestione) che hanno comprato gli Etf cinesi agganciati all’indice sono rimasti al palo. I fondi attivi, concentrandosi sui titoli cinesi legati ai consumi interni ed evitando i grandi carrozzoni a partecipazione pubblica, hanno dato buoni risultati, a volte ottimi. È vero, ma è un altro discorso.
Se consideriamo le borse come rappresentative delle economie sottostanti è più che giusto, in Cina, includere le società a partecipazione pubblica, un ampio settore dell’economia cinese che in questi anni ha continuato e continua tuttora a distruggere valore.
In pratica possiamo dire che la Cina ha oggi un’economia di dimensioni quasi triple rispetto a dieci anni fa (13 trilioni di dollari contro i 4.6 del 2007), ma la sua capitalizzazione di borsa (funzione della sua redditività di sistema) è rimasta invariata.
Alcuni traggono da questo l’idea di comprare oggi la Cina e vendere un’America sopravvalutata e a fine ciclo. Può essere, ma ricordiamoci del Giappone, un altro paese che a metà degli anni Ottanta veniva considerato il futuro padrone del mondo e un’altra borsa che per i due decenni successivi continuò a deludere.
La Cina ha imparato molte cose dal Giappone e ha finora evitato errori strategici che il Giappone commise, come il permettere bolle finanziarie e immobiliari prolungate, l’accumulare eccessivi surplus commerciali e il tollerare livelli di cambio disallineati con i fondamentali.
La Cina rischia oggi però di ripetere un altro errore giapponese, quello di sentirsi ormai superiore su tutti i piani rispetto all’America e, di conseguenza, di sottovalutarla. Come nota il sinologo Christopher Balding su Bloomberg, con la sua azione Trump sta prendendo a cannonate le fondamenta del modello economico della Cina, privandola di esportazioni e quindi di dollari. Certo, in teoria la Cina potrebbe rispondere svalutando (un po’ l’ha già fatto), ma andare oltre un certo limite significherebbe entrare in guerra non solo con l’America ma anche con l’Europa e, cosa ancora più pericolosa, rischierebbe di rimettere in moto su larga scala la fuga di capitali che abbiamo visto nel 2015 e che è costata un trilione di dollari di riserve (mai più recuperate) in poche settimane.
È per questo che, dietro la facciata compattamente nazionalista, cresce la pressione interna per trattare con l’America. È lo stesso fenomeno che abbiamo cominciato a vedere in Europa sulle auto. Se Europa (prima) e Cina (dopo) accetteranno di rendere più equilibrati i commerci Trump passerà alla storia non come un protezionista ma come un globalizzatore di nuova generazione. Con meno disavanzo americano, in compenso, il mondo avrà meno dollari e questo rischierà di aggravare la riduzione della liquidità globale di cui già stiamo avvertendo i primi segnali.
Nei prossimi mesi i mercati globali saranno ancora sostenuti dagli utili americani. Al netto delle guerre commerciali la borsa americana rimarrà la più solida. Solo se Europa e Cina andranno incontro all’America e faranno concessioni sui dazi le loro borse potranno fare meglio dell’America. Se prevarrà invece la linea del colpo su colpo altri danni saranno inevitabili.