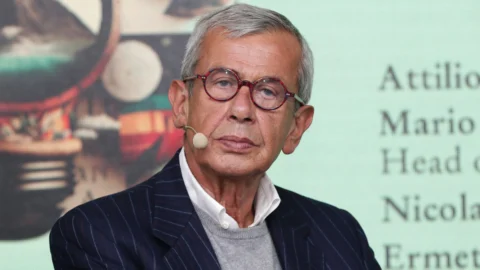L’Area Studi di Mediobanca ha completato le pubblicazioni sulle imprese, aggiornandole al 2015. Come d’uso, ha reso disponibile una massa di dati assai utile. E’ quindi possibile valutare lo stato finanziario della nostra grande industria in un momento particolarmente critico, distinto dal lato congiunturale da forti diversità nei tassi di sviluppo dei vari paesi e, dal lato strutturale, dall’incedere della cosiddetta quarta rivoluzione industriale. Quest’ultima richiederà investimenti e innovazioni spesso radicali nell’organizzazione produttiva. Saranno avvantaggiate le imprese dotate di autonomia finanziaria e di strutture patrimoniali solide, oltre che di “animal spirits” fatti di spiccate capacità innovative.
Ai fini del nostro check-up ho esaminato i dati dei nostri 14 maggiori gruppi industriali in base al capitale investito. Essi comprendono 4 gruppi a controllo pubblico e 10 a controllo privato. Questi 14 gruppi assorbono capitale per 443 miliardi di euro, 63% i pubblici (tra cui Enel ed Eni contano più di 9 decimi), 37% i privati (Exor/Agnelli conta qui per oltre i ¾). Ricordo che considero tra i privati alcuni importanti gruppi ceduti ad investitori esteri: Italcementi (ora facente capo alla tedesca Heidelberg), Pirelli & C. (controllata dalla Chem China) e Parmalat (facente capo alla francese Lactalis), mentre Exor pur avendo sede a Torino controlla aziende dell’automotive che hanno assunto la nazionalità olandese (Fca, Ferrari e Cnh). Userò come benchmark le multinazionali industriali europee i cui dati più recenti si riferiscono al 2013.
Prima osservazione: i settori capital intensive sono sempre competenza dei gruppi pubblici dove gli attivi tangibili per dipendente sono pari a 1,50 milioni di euro contro gli 0,30 dei privati e gli 0,39 della media europea. I nostri gruppi pubblici segnano pure una bassa produttività del capitale; la % di valore aggiunto sul capitale investito (attivo tangibile) è pari al 14% contro il 25% dei privati e il 29% della media europea. I dati sul valore aggiunto per dipendente mostrano ovviamente una storia diversa, con i pubblici a quota 238 mila euro contro i 79 mila dei privati e i 114 mila delle multinazionali europee. Prima conclusione: le nostre grandi imprese hanno ancora una identificazione pubblica e sono sbilanciate sui settori che assorbono molto capitale. Soffrono di un deficit di produttività, dovuto essenzialmente al livello del valore aggiunto che risente del basso impegno nell’innovazione. Per raggiungere la media europea, in base ai dati dell’indagine R&S sulle multinazionali, dovremmo aumentare le spese di ricerca e sviluppo del 70%. La distanza da Francia e Germania è superiore, rispettivamente 80% e 150%.
Passando alla struttura patrimoniale, notiamo i nostri 14 “campioni” in una seconda importante sofferenza: la bassa dotazione di mezzi propri. A questa si aggiunge il fatto che una quota importante degli attivi è costituita da “immateriali”, ovvero, ragionando in termini finanziari, da “nulla di concreto”: la quota di intangibles è del 21% per i privati e del 12% per i gruppi a controllo pubblico. La media europea è pari al 21% e pertanto i nostri privati parrebbero in linea se non fosse che il loro patrimonio netto è insufficiente. Il patrimonio netto tangibile (cioè il valore del patrimonio dichiarato in bilancio depurato di questi intangibles) sommato alle altre risorse a m/l scadenza è pari ad appena il 37,6% del capitale investito contro il 58,1% dei pubblici e la media europea del 52,9%.
Per i privati il rapporto tra intangibles e patrimonio netto “dichiarato” in bilancio è pari all’89,8% e ciò significa che su 10 euro conferiti dagli azionisti, 9 sono impiegati in attività nulle, improduttive. Con buona pace dei revisori contabili i quali ovviamente debbono aver trovato ragioni sufficienti per consentire al management di mantenere questi valori iscritti all’attivo dei bilanci delle imprese. Se volessimo fare una classifica in base alla quota di patrimonio rappresentata da intangibles troveremmo valori superiori al 50%, nell’ordine, per i gruppi Exor (119,8%), Luxottica (93%), Cofide (63,4%) e Prysmian (50,7%). L’inadeguatezza dei mezzi rischiati dai controllanti è notoriamente il male antico del capitalismo italiano che preferisce usare i capitali delle minoranze e i debiti finanziari. I gruppi pubblici nel loro insieme appaiono assai più provveduti, ma solo per effetto dell’Eni (intangibles pari al 4,5% appena del patrimonio netto nominale); molto più elevate le percentuali di Leonardo (162,9%) ed Enel (53,2%). Del tutto ragionevoli infine gli indici dei gruppi di dimensione minore (Barilla 47,6%, Finmar 36,2%, Prada 30,2%) il cui peso sul totale è però limitato. Aggiungo che nelle imprese del Quarto capitalismo (qui non considerate) questo fenomeno è praticamente sconosciuto e ciò le rende assai più solide di questi grandi “campioni”.
Sintesi: le nostre grandi imprese soffrono di basso impegno nell’innovazione e di scarsa dotazione di mezzi propri, e quindi non paiono del tutto preparate a sostenere le criticità citate all’inizio. Nel caso in cui i 10 gruppi a controllo privato volessero adeguarsi al grado di patrimonializzazione delle multinazionali europee, a parità di capitale investito, si evidenzierebbe un fabbisogno pari a 17 miliardi di euro. Si tratta di un dato aggregato calcolato a titolo puramente indicativo, dato che alcuni dei gruppi privati italiani risultano già adeguati alla media europea (Prada, Cofide, Barilla). Un impegno comunque veramente notevole che in alcuni casi modificherebbe gli assetti proprietari. A mio parere andrebbe affrontato ponendo in atto politiche di revisione delle strutture produttive e innovando i beni offerti al mercato: una nuova grande ristrutturazione industriale! Il Governo ha recentemente varato un programma di forte incentivazione agli investimenti innovativi: sta ora agli industriali decidere se hanno la volontà e le competenze per accettare questa nuova sfida o se è preferibile cedere all’estero quello che rimane di “grande”.