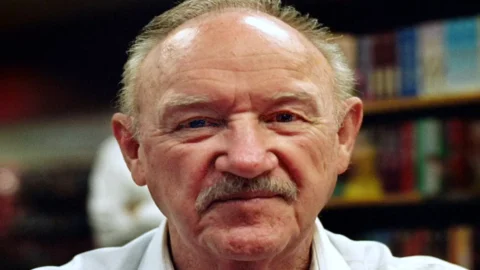FALSI MITI E LEZIONI PER L’INDUSTRIA DEL XXI SECOLO
La lezione fondamentale che emerge dalla nostra analisi è che il futuro della manifattura nelle economie mature dipenderà dalla capacità di gestire la diversità multidimensionale in un’economia globale. La fusione tra Fiat e Chrysler, come ogni altra fusione, è un esercizio certosino che cerca di combinare elementi molto diversi in un corpo unico e ben funzionante. Questa è la condi-zione di ogni attività globale. Ed è la condizione dell’industria contemporanea che opera in un caleidoscopio di culture, mercati, tecnologie, istituzioni e geografie. Tutti questi differenti elementi di diversità, che un gruppo globale deve integrare, portano a definire strategie che spesso sono in contrasto con molti luoghi comuni che caratterizzano il dibattito sul futuro dell’industria.
Negli ultimi due decenni si è messa fortemente in discussione la possibilità di un futuro sostenibile per la manifattura in eco-nomie mature, con costi proibitivi rispetto alle nuove economie industriali emergenti. Di recente però, anche grazie allo sviluppo della manifattura in Germania e alla ripresa negli Stati Uniti, è maturata una convinzione sempre più diffusa che l’industria abbia una resilienza molto più forte di quanto si prevedesse e che anzi diverse attività industriali, che erano state trasferite verso economie a basso costo del lavoro, stiano tornando verso i paesi avanzati. L’aumento dei salari e i movimenti delle valute hanno gradualmente ridotto i vantaggi di costo della Cina e di altre economie emergenti. E il calo del costo dell’energia con la scoperta dello shale gas ha favorito la creazione di nuovi posti di lavoro manifatturieri negli Stati Uniti.
«Oggi siamo probabilmente più competitivi globalmente di quanto siamo stati negli ultimi trent’anni», sostiene Jeff Immelt, l’amministratore delegato della General Electric. «La quota degli addetti della manifattura negli Stati Uniti passerà dal 9% al 30% del totale? Non credo. Ma ci sarà un aumento costante di occupazione in questo settore nei prossimi anni? Credo di sì». Diversamente, secondo alcuni commentatori scettici, come il capo economista di Goldman Sachs, Jan Hatzius, la rinascita della manifattura negli Stati Uniti «sembra piuttosto una novella che un fatto, ossia è un fenomeno ciclico più che strutturale».
Ottimisti o pessimisti che siano, questi mutevoli luoghi comuni si basano spesso su falsi miti che l’analisi di Fiat Chrysler aiuta a mettere in discussione. Il futuro dell’industria nei paesi industriali è possibile, ma si basa su strategie e scelte molto precise che è bene avere molto chiare. Il primo falso mito è che il principale parametro di costo sia il salario e che l’unico modo per competere con i paesi emergenti sia abbassare la remunerazione e limitare altri benefici del lavoro. Certamente tutte le nuove economie industriali hanno mosso i primi passi da attività ad alta intensità di lavoro (abbigliamento, calzature ecc.) e mano d’opera abbondante e a basso costo ha garantito un formidabile vantaggio competitivo iniziale. Se a ciò si aggiungono regole meno stringenti, minori vincoli ambientali, una difesa più limitata dei diritti di proprietà intellettuale, abbondanti sussidi pubblici ed un mercato interno in rapida espansione, abbiamo abbastanza elementi per spiegare la spettacolare crescita della manifattura in paesi come la Corea del Sud, Singapore e più tardi la Cina e l’India.
Teorie e studi empirici di commercio internazionale e geografia economica mettono in evidenza invece come la localizzazione delle attività industriali segua vie complicate che possono solo in parte essere influenzate dal costo di fattori di produzione come il lavoro, da tasse basse o da regole poco stringenti. Elementi come la dimensione del mercato, le economie di scala, i costi di trasporto, le preferenze dei consumatori, le economie di agglomerazione, le conoscenze tecnologiche interagiscono con il costo dei fattori nel determinare la geografia delle attività industriali. Questo vale soprattutto per attività integrate geograficamente come tipicamente è l’automobile. Questa combinazione di elementi genera nel tempo vantaggi competitivi che sono difficili da smantellare e sono dunque profondi.
Vantaggi che dipendono dalla disponibilità sul territorio di servizi, infrastrutture e forza lavoro specializzata. Per questa ragione si continuano a produrre automobili negli Stati Uniti, in Germania o in Italia; l’Italia, la Germania e gli Stati Uniti continuano ad essere i maggiori esportatori di macchinari industriali; molte imprese in industrie tradizionali come il tessile riescono comunque a sopravvivere in paesi ad alto costo del lavoro come l’Italia o la Francia. Insomma, le economie mature non possono fondare la propria competitività sul basso costo del lavoro o su un deterioramento delle condizioni dei lavoratori. La ristrutturazione dell’industria dell’auto americana nel 2009 ha anche implicato tagli considerevoli ai salari e ai benefici per i lavoratori delle Big Three. Ma, come abbiamo visto, questi avevano raggiunto livelli insostenibili, anche in confronto ad altri produttori sul territorio americano. Anche se la concorrenza dai paesi emergenti certamente mette sotto pressione i lavoratori delle economie industriali, ciò non implica e non può implicare un deterioramento significativo nelle condizioni dei lavoratori. La competitività in questi paesi deve essere rafforzata riducendo l’incidenza del costo del lavoro in altri modi, soprattutto aumentando la produttività ed il valore aggiunto dei prodotti finiti.
Il secondo falso mito è che ci sia una semplice strategia low cost sostenibile per la sopravvivenza della manifattura nei paesi avanzati. Contenere i costi è ovviamente fondamentale. Nella produzione automobilistica, normalmente questa preoccupazione si traduce in un’ossessione per la scala. Come abbiamo visto, questo è uno dei razionali fondamentali di FCA: abbattere i costi fissi attraverso una crescita dei volumi. Senza l’accordo né Fiat né Chrysler avevano molte possibilità di sopravvivere da sole per insufficienza di scala. Non basta aumentare le automobili costruite. È necessario razionalizzare la gamma dei prodotti offerti accorpandoli in famiglie sufficientemente omogenee da condividere molti elementi in comune, senza tuttavia sacrificare la differenziazione richiesta dal mercato. Come già fatto da molti concorrenti, Fiat e Chrysler insieme possono ottenere scala e varietà di modelli adeguate razionalizzando e combinando le piattaforme.
Ma anche scala e varietà da sole non bastano. Occorre qualità, quello che permette ad un’azienda di generare maggiore valore aggiunto, vendendo più auto ad un dato prezzo o facendo pagare un prezzo maggiore per un dato costo di produzione. Come Chrysler, Fiat e molti altri produttori hanno imparato sulla propria pelle, non c’è prezzo abbastanza basso a compensare la cattiva qualità di un’automobile. La compressione dei costi non funziona se implica bassa qualità e poca varietà in un contesto in cui gli investitori devono poter essere ripagati e i lavoratori devono poter mantenere standard di vita adeguati in un quadro regolatorio sofisticato (in termini di norme ambientali, regolamentazione dei prodotti, politica della concorrenza ecc.). Mettere in atto questa strategia alta è essenziale per imprese che operano in economie mature. Una strategia bassa, che riduca drasticamente i costi senza investimenti adeguati in qualità, sarebbe un suicidio, costantemente superata al ribasso da imprese dei paesi emergenti. Il che determinerebbe inevitabilmente la chiusura o il trasferimento di buona parte delle attività industriali nei paesi a basso costo del lavoro. Le imprese che perseguono una strategia «bassa» con successo, come Renault con Dacia, basano le loro produzioni low cost nei paesi emergenti. Certo, in molti settori, dove è possibile frammentare la produzione geograficamente e costruire catene del valore globali, è anche possibile che la produzione di alcuni componenti o l’assemblaggio vengano delocalizzati. Ma questa opzione spesso consente di mantenere e rafforzare le attività a più alto valor aggiunto nei paesi avanzati.
Il terzo falso mito è che la macchina sostituirà completamente l’uomo e che solo fabbriche completamente automatizzate sopravviveranno in paesi ad alto costo del lavoro. Per ora le macchine non possono sostituire completamente gli uomini. Come abbiamo visto, anche nella produzione di automobili, uno dei settori con il più elevato contenuto di tecnologia. Ovviamente c’è stata un’automazione fortissima dai tempi delle fabbriche-città come Mirafiori o River Rouge della Ford, ma l’assemblaggio delle automobili continua comunque a richiedere diverse operazioni manuali che le macchine non sono in grado di replicare. Precisamente perché c’è un limite all’automazione (ed alla compressione dei salari), le industrie nei paesi ad alto reddito devono trovare altri modi per migliorare la produttività del lavoro indipendentemente dalla tecnologia e dalle macchine. L’esperienza del World Class Manufacturing e di altre versioni di lean production dimostrano che la riorganizzazione del flusso di lavoro nelle linee di comando e di montaggio può generare risparmi di costo colossali. Questi processi valorizzano la componente umana del lavoro di fabbrica, assegnano agli operai compiti cognitivi oltre che esecutivi e rendono il lavoro delle fabbriche dei paesi maturi meno facilmente sostituibile da quelle dei paesi emergenti. Naturalmente questo processo richiede una revisione radicale dei contratti di lavoro e delle relazioni industriali.
In Italia, sulla pressione delle istanze Fiat questi sono stati rivisti in una direzione che è potenzialmente favorevole a qualunque tipo di attività industriale. Il quarto ed ultimo falso mito riguarda la politica economica e l’idea che per sostenere la manifattura sia necessario preservare lo status quo. Abbiamo visto chiaramente nel caso dell’automobile che durante crisi e recessioni, soprattutto se prolungate come quelle degli ultimi anni, c’è naturalmente la preoccupazione per chi decide la politica economica di evitare la perdita irreversibile della massa critica industriale e dei vantaggi competitivi «profondi» per non trovarsi fuori dai giochi al momento dell’eventuale ripresa. Molto spesso questa preoccupazione si traduce nell’obiettivo di mantenere a tutti i costi i livelli occupazionali di ogni singola impresa anche nel breve periodo. Questo approccio, per quanto comprensibile, perde di vista il fatto che non tutte le imprese, anche in uno stesso settore e anche nello stesso momento storico, hanno lo stesso destino. Ridurre capacità in eccesso chiudendo attività deboli e inefficienti, per quanto doloroso, può servire a ridimensionare l’industria a livelli contingenti compatibili con la domanda finale e con i guadagni di produttività che tecnologia e innovazione, anche organizzativa, permettono di raggiungere. Questo è un processo che può essere salutare, in quanto libera risorse per una futura crescita più vigorosa.
Detto questo il compito della politica economica non è facile. È evidente che nelle fasi di crisi intensa (e appunto nel breve periodo) ci sia un problema di sostegno dei lavoratori e delle attività colpiti. Ma nel lungo periodo l’obiettivo centrale deve essere la transizione verso attività economiche sostenibili a condizioni di mercato e non il sostegno ad ogni costo dell’esistente. Questa è stata la linea guida della politica economica americana di fronte alle difficoltà delle Big Three durante la Presidenza Obama. Linea perseguita con un’efficienza e una rapidità non ripetibile nel contesto istituzionale italiano. I governi europei, al contrario, sono sempre stati più attenti a proteggere l’occupazione nel breve periodo evitando aggiustamenti dolorosi. Questo è il caso dell’utilizzo della Cassa Integrazione Guadagni straordinaria in Italia e della cassa in deroga, che tengono lavoratori senza lavoro attaccati alla loro impresa di appartenenza (spesso senza alcuna possibilità di ripresa) oltre ogni limite ragionevole o degli esborsi del governo francese per sostenere Peugeot-Citroën e Renault durante la crisi o della ricapitalizzazione della stessa PSA in questi ultimi mesi con fondi pubblici (oltre che con un nuovo partner cinese).
Così come gli interventi europei messi in atto nel 2008, all’esplodere della crisi finanziaria, sono stati essenzialmente di sostegno ai consumi e alla domanda, con interventi generali o addirittura mirati a specifici produttori, grazie all’introduzione di misure di emergenza in deroga alle regole EU sugli aiuti di Stato. Certamente, data la gravità della crisi, misure di sostegno della domanda sono state indispensabili. Ma allo stesso tempo l’aggiustamento verso una nuova e maggiore competitività è stato ritardato, non c’è stata una riduzione efficiente di capacità produttiva e non è chiaro quale sarà il panorama europeo quando la domanda, speriamo nel corso di quest’anno, ripartirà.
Un ragionamento articolato sul futuro della politica industriale va ben oltre lo scopo di questo libro. Il punto conclusivo qui è che la sostenibilità di mercato delle attività economiche definisce l’obiettivo e il limite di un’azione di politica economica mirata allo sviluppo industriale. Questa sostenibilità può venire meno temporaneamente per motivi eccezionali, come la crisi del 2009, e l’azione pubblica può aiutare in una fase di transizione. Ma alla fine bisogna fare i conti con il mercato. E nel mercato, di fatto, giocano anche le Nazioni e i loro governi. In un contesto in cui imprese sempre più globali possono scegliere dove e come produrre è indispensabile per un paese come il nostro poter offrire condizioni di competitività di contesto adeguate.Soprattutto nell’ottica di rafforzare un’industria ad alto valore aggiunto, c’è spazio per un’azione di politica economica che aiuti la salita lungo la scala del valore aggiunto. Questo significa fare cose ben note, nell’agenda di tutti i governi che si sono succeduti alla guida della nostra Repubblica (le famose riforme strutturali). Ma anche lavorare con le imprese per costruire e rafforzare quei vantaggi comparati profondi che, come abbiamo sostenuto in più parti di questo libro, sono poi quelli che determinano la fortuna di ogni territorio produttivo, al di là di vantaggi temporanei come un basso costo del lavoro o condizioni fiscali favorevoli. Infrastrutture, competenze e servizi non sempre possono essere offerti dal mercato. Quando sono indispensabili alla competitività industriale di un’economia matura, allora qui c’è davvero spazio per la mano pubblica.
In conclusione, l’avventura di questa unione transatlantica che ha dato luogo a FCA è ricca di lezioni, spunti di riflessione e criticità. Negli Stati Uniti è stata vissuta con crescente entusiasmo, come un ulteriore esempio della capacità, che lì sentono molto americana, di fare quadrato nei momenti di difficoltà per poi trovare una via d’uscita efficace. In Italia continua ad essere guardata con diffidenza, soprattutto per le basse ricadute immediate che l’operazione ha avuto qui ed uno scetticismo diffuso nei confronti di un’azienda a cui il paese spesso sente di aver dato più di quanto ha ricevuto.È possibile sopravvivere, generando profitti e posti di lavoro, senza grandi prodotti di massa come la Uno e la Punto? Riuscirà FCA ad assicurare la qualità e l’appetibilità dei nuovi prodotti necessarie alla rinascita della produzione italiana? Quanto conta la storia del marchio? Perché Marchionne dovrebbe riuscire a sfondare nei segmenti premium e luxury dove nessuno prima di lui è riuscito? Si tratta infatti di una partita in larga parte ancora da giocare. Ora per lo meno le regole del gioco sono più chiare: esiste una strategia industriale su cui l’azienda intende costruire il proprio futuro. La speranza è che questo libro abbia permesso di capire meglio il senso di questa strategia e possa quindi promuovere un dibattito sui suoi pregi e sui suoi difetti, per FCA, i suoi lavoratori e il paese nel suo insieme.