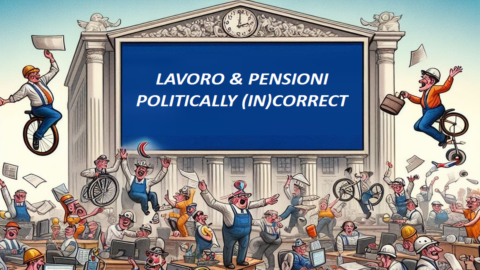La settimana scorsa, a un’asta di Sotheby’s, anche Norman Rockwell è stato proiettato, per una volta meritatamente, ai livelli più alti di quotazione. Il suo Saying Grace, il ritratto senza retorica di una famiglia che si raccoglie in preghiera prima di mangiare in un modesto ristorante, è stato venduto per 46 milioni di dollari.
Nei suoi anni più produttivi, dal New Deal ai primi Sessanta, Rockwell ha rappresentato nelle sue illustrazioni i valori di quella middle class che votava democratico in nome della libertà dal bisogno e che al tempo stesso conservava come prezioso il senso della famiglia, della religione e della patria.
All’epoca non si avvertiva del resto nessuna contraddizione tra il progressismo sociale e la difesa dei valori dei padri. La rottura avvenne improvvisamente nel 1963 e nei cinque anni che seguirono divenne profonda e irreversibile in tutto l’Occidente. Due libri affascinanti, Bowling Alone di Robert Putnam e Coming Apart di Charles Murray, descrivono in modo minuzioso e appassionato il precipitare di questa lacerazione, cui dobbiamo molti dei problemi di oggi, tra i quali, in America, l’incomunicabilità tra la cultura europeizzata delle coste e la Right Nation religiosa e jacksoniana dell’interno.
Rockwell sperimentò personalmente la rottura del 1963. Fino ad allora seguito e apprezzato da tutti, fu licenziato in quell’anno da Look, la rivista per cui disegnava le sue tavole, per avere proposto in modo considerato radicale il tema caldissimo della desegregazione razziale. La tavola si intitolava The Problem We All Live With e raffigurava il caso reale di una ragazzina nera che veniva accompagnata verso una scuola bianca dai federali mandati da Kennedy.
Ai giorni nostri Rockwell è vissuto da destra e da sinistra con struggente nostalgia e commozione perché ricorda a tutti i valori unificanti che fondarono e resero grande l’America e che oggi appaiono così tristemente lontani. È esattamente questa stanchezza che affiora per il mezzo secolo di guerra civile culturale, ideologica e politica a essere alla base della reazione sproporzionatamente positiva e perfino commossa per il piccolo accordo (ancora da ratificare in Congresso) che repubblicani e democratici hanno appena raggiunto sulla politica fiscale.
Non si festeggia il risultato in sé, che pure eviterà una nuova chiusura degli uffici pubblici e un’altra minaccia di default sul debito. Si tratta infatti di un tipico compromesso in cui tutti hanno ottenuto e rinunciato a qualcosa, assolutamente niente di alto o di grande. A stupire ed emozionare è il fatto che si sia lavorato insieme e silenziosamente per la prima volta da un tempo immemorabile, con la sola eccezione della breve parentesi dell’11 settembre.
Senza ricatti, senza demagogia, senza vincitori e senza vinti. Con un po’ di cinismo residuo, certo (il calcolo repubblicano è che per vincere le elezioni di midterm sarà sufficiente additare il pasticcio della riforma sanitaria), ma meno di quello cui ci eravamo tutti abituati. Se, come sembra, l’accordo sarà ratificato, vincendo l’opposizione delle ali radicali dei due partiti, la Fed avrà un potente argomento in meno per continuare a immettere 85 miliardi di liquidità al mese e comincerà a ridurre la dose di Quantitative easing prima di quel marzo 2014 che il consenso del mercato indicava fino a pochi giorni fa.
L’altro potente argomento in meno è che la creazione di nuovi posti di lavoro si sta stabilizzando sulle 200mila unità al mese, un livello che dovrebbe fare scendere il tasso di disoccupazione al 6.5 per cento già in primavera, molto prima di quello che si pensava. Per la Fed è sempre più difficile giustificare dosi massicce di stimolo con un’economia che, superata la parentesi mediocre del quarto trimestre in corso, è proiettata verso una crescita del 3 per cento nel prossimo anno, trainata dal boom dell’energia e da una produzione industriale dall’andamento decisamente brillante.
Per continuare a rinviare il tapering e non annunciarlo già mercoledì prossimo alle colombe, rimangono a questo punto solo due argomenti. Il primo è che la ripresa dell’edilizia, cui la Fed è da sempre particolarmente sensibile, è più fragile del previsto. Il secondo è che l’onda d’urto globale sui mercati finanziari, come si è visto nelle prove generali di tapering tra giugno e settembre, rischia di essere così forte da rimettere in discussione la propensione a consumare e a investire che con tanta fatica si stava riuscendo a far crescere.
La paura della Fed è comprensibile. Un’altra falsa partenza minerebbe seriamente la sua credibilità. D’altra parte aspettare altri mesi alimenterebbe la bolla delle borse e renderebbe ancora più difficile il ritorno a una parvenza di normalità monetaria. Ecco perché il Fomc cercherà di muoversi con prudenza e di coprirsi il più possibile le spalle.
Se rinvierà a gennaio il tapering, farà comunque capire che le condizioni per iniziarlo stanno maturando. Se romperà gli indugi, inizierà con una cifra quasi simbolica (5-10 miliardi) e la accompagnerà con una dichiarazione d’intenti sui tassi, che verranno indicati a zero più a lungo di quanto era stato annunciato finora. Il problema con cui tutti viviamo sui mercati, il tapering, è un problema annunciato.
È un passaggio obbligato, come lo sarà un giorno lontano quello, ancora più delicato, dell’abbandono dei tassi a zero. Il tapering fa parte della nostra condizione esistenziale, è ineludibile come la rottura del cordone ombelicale. A medio termine è un fatto molto positivo e significa che si può cominciare ad affrontare il mondo con le proprie forze. Nel breve può essere un trauma.
È molto interessante che, fino a questo momento, la prospettiva di un possibile tapering dietro l’angolo stia creando più problemi alle borse che ai bond. In teoria dovrebbe essere il contrario. Un’economia in accelerazione e un quadro politico più tranquillo dovrebbero essere esattamente quello che le borse desiderano. Si preoccupassero semmai i Treasuries, che la Fed acquisterà meno di adesso, e di riflesso tutto il reddito fisso globale.
Invece è il contrario (finora). La ragione è che i Treasuries erano già rassegnati a un percorso di rendimenti crescenti. In più, non va dimenticato il dono gradito di un anno in più di tassi a zero, prezioso per le scadenze a 5 anni e non trascurabile per quelle un po’ più lunghe. Le borse, invece, stavano già assaporando il rialzo di fine anno, cui segue tradizionalmente quello di gennaio.
C’era forse qualcosa di sfrontato e irritante nell’aspettarsi come dovuto un apprezzamento ulteriore dopo che gli indici erano già saliti quest’anno del 20-25 per cento, ma questo atteggiamento era di fatto condiviso anche da chi si preparava a vendere, ma aspettando ancora qualche settimana. In pratica, dunque, le borse si sono fatte trovare cariche e ipercomprate ed è comprensibile che stiano reagendo con un certo nervosismo.
I danni, nel breve, dovrebbero essere comunque limitati. Un rialzo verso i massimi è ancora possibile negli ultimi giorni dell’anno, soprattutto se il Fomc deciderà di rinviare un’altra volta la decisione fatale. Rinvio o no, il tapering continuerà ad aleggiare sui mercati per tutto il primo trimestre. Col tempo ci si farà l’abitudine, ma nel prossimo periodo ci saranno reazioni asimmetriche rispetto ai dati.
Quelli buoni susciteranno rialzi tiepidi, quelli deludenti saranno enfatizzati. Nulla vieta, naturalmente, che tutto vada bene, ma le probabilità di inciampare quando le attese sono così elevate non sono trascurabili. Utili sotto le attese, crisi del debito in qualche paese emergente, dati macro mediocri, vittorie elettorali di partiti euroscettici sarebbero gestibili senza troppo affanno in un mondo senza tapering, ma in un mondo con meno liquidità (anche se il Giappone compenserà il ritiro della Fed con una forte accelerazione del suo Qe) potranno creare più turbolenza.
Larry Fink di Blackrock ipotizza come perfettamente possibile e perfino auspicabile una correzione del 10-12 per cento, aggiungendo giustamente che un SP 500 a 1600 costituirebbe una formidabile occasione d’acquisto. Non è detto che i tempi siano già maturi, ma chi investe, nel gestirsi i rischi, deve tenere presente che il mercato non ha una correzione degna di questo nome dall’aprile 2011 e deve organizzarsi per affrontarla.
Uno stress test sul portafoglio, sulla strategia per i prossimi due-tre anni e sui propri nervi comincia a diventare opportuno, così come sarà utile preparare una lista della spesa di titoli ciclici non cari (le linee aeree americane e il Big Oil, che per inciso si compensano tra loro, potrebbero essere un esempio) per fare il pieno in caso di correzione.