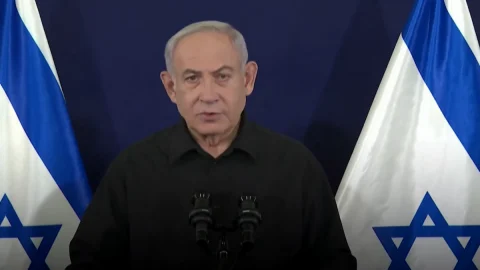“Vinceranno non c’è dubbio. Le donne iraniane non hanno paura più di niente, nemmeno dei proiettili”.
La chiameremo “Mahsa Amini”, in memoria della ragazza uccisa di botte dalla “Polizia Morale” di Teheran, il 15 settembre dello scorso anno, perché dal suo velo usciva una ciocca di capelli. Ma il suo nome è un altro e non possiamo rivelarlo per ragioni di sicurezza. Per lo stesso motivo non possiamo nemmeno dire dove si trova. Incontriamo la nostra amica “Mahsa Amini” in una casa rifugio di una città qualunque dell’Italia. L’abbiamo incontrata, grazie a un’amica carissima, qualche ora prima della celebrazione dell’8 marzo per parlare con lei proprio della festa delle donne.
La fa sorridere questa storia di mimose e di diritti? Lei che è scappata prima di tutto per salvare la propria vita e quella dei suoi figli, che cosa ne pensa?
“Neanche per sogno. So bene che cosa significa l’8 marzo. Non è solo una festa, ricorda delle morti, quelle di giovani donne sul posto di lavoro. Ho vissuto quasi dieci anni in Italia arrivandoci molto giovane. Quindi non è il primo 8 marzo che vivo nel vostro Paese e ho grande rispetto per questa giornata. Mi sono sempre commossa al pensiero di quelle operaie rimaste intrappolate nell’incendio della fabbrica di New York perché vi erano state rinchiuse dal padrone, dopo la loro richiesta di migliori condizioni di lavoro. E fino a quando ho potuto, ogni anno ho postato un pensiero per ricordare quelle povere anime. E’ un giorno importante, è giusto celebrarlo. Anche noi musulmani abbiamo una nostra festa della donna, ma è di tipo religioso, in onore della figlia di Maometto.”
La nostra “Mahsa Amini” è una donna iraniana fra le altre, non racconta la storia pubblica della violenza del suo Paese contro le donne, la incarna perfettamente. Quando è scoppiata la rivolta per Mahsa Amini, quella vera, lei era in Iran, tornata nel suo Paese insieme a un connazionale che aveva sposato in Italia, ma che solo giunto a “casa sua” aveva rivelato il vero volto di maschio violento, prepotente e manipolatore.
“Non ho partecipato alle manifestazioni, ero lontana da Tehran, ma ho seguito con gioia e apprensione quelle giovani donne e quei ragazzi che sfidavano il potere. Vinceranno, ne sono sicura. Devono vincere”.
E’ un atto di fede il suo, e anche il nostro; ma nel frattempo ragazze e ragazze in Iran finiscono in carcere, vengono bastonati, sono uccisi perché rivendicano il diritto di vivere una vita libera. I numeri parlano chiaro: secondo l’organizzazione Human Rights Activist News Agency, 530 sono stati i morti durante le manifestazioni da settembre a oggi, di cui 71 bambini; quasi 20mila sono stati gli arresti e 165 le città coinvolte nella protesta. Mentre più di un migliaio di studentesse provenienti da 58 scuole femminili, sparse in otto province, sono state ricoverate negli ultimi giorni per sintomi di avvelenamento da gas tossico, un mistero che sembra sempre di più una premeditata operazione di polizia per intimidire le ragazze.
Il regime ha deciso di reagire nel modo più duro.
E tutto per una ciocca di capelli. Quando sono stata in Iran nel 2007, l’avvocata premio Nobel per la Pace, Shirin Ebadi , poi costretta all’esilio dopo che le avevano torturato marito e sorella, mi aveva fatto notare che il velo era solo un simbolo, che non era quella l’imposizione più grave che subivano le iraniane. Non avevano diritto alla proprietà, non potevano andare all’estero senza il permesso di un uomo, non potevano esercitare mestieri come quello del giudice. Oggi però la rivolta è partita per una ciocca di capelli uscita dallo hjiab.
E’ così importante quel velo?
“E’ vero il velo è un simbolo, ma rappresenta tutte le violenze che abbiamo subito e subiamo. Non è più solo un accessorio, si deve partire da lì.”
La nostra amica ci ricorda che non lo aveva mai indossato in Italia e che quando è arrivata a Teheran ha dovuto tagliare i lunghi capelli riccissimi per riuscire a infilarli sotto il foulard.
Già, la sua storia: ci ritorna e ci spiega come una volta uscita dall’inferno ci è tornata di sua volontà ?
Eravamo arrivati in Italia con la mia famiglia, genitori e figli, dopo aver attraversato a piedi più di un Paese. Sì, siamo entrati da clandestini. Scappavamo perché lì da noi non c’era speranza per chi non si adeguava alla legge della Sharia. Mia madre soprattutto, non aveva mai accettato di “sparire” in quanto persona, come era richiesto dalla cultura dei religiosi. Ci ha educato fin da piccoli a essere uguali, figli maschi e figlie femmine. E ricordo bene come mise a posto uno dei miei fratelli quando si permise di criticare come ero vestita. “E’ libera di vestirsi come le pare, non ti immischiare”, gli disse. E’ stato il periodo più bello della mia vita: studiavo, avevo un sacco di amici, aiutavo chi arrivava dall’Iran per inserirsi. Poi il destino mi ha raggiunto”.
Le lacrime scendono in maniera tranquilla, senza scosse e lei continua a parlare non facendoci caso.
“Proprio durante uno di quegli incontri per inserire i nostri connazionali nella società italiana ho incontrato l’uomo che sarebbe diventato per oltre quindici anni il mio aguzzino. Il mio permesso di soggiorno stava per scadere, avevo bisogno di trovare un lavoro. Cominciai a cercare dappertutto e chiesi anche a “quella” persona se conoscesse qualcuno pronto ad assumermi. Si mostrò molto disponibile e affabile proponendomi però di lasciare la città dove vivevo e di seguirlo nella sua. Mancavano pochi giorni alla scadenza del mio permesso, sarei andata anche all’inferno pur di restare in Italia”.
Ne era innamorata? Lo seguì come un fidanzato?
“No, per almeno quattro anni siamo stati semplici coinquilini. Poi con il tempo accadde che, non avendo né la mia famiglia né i miei vecchi amici, le uniche persone che frequentavo erano lui e i suoi parenti. E furono proprio i suoi parenti che a un certo punto gli dissero che la nostra situazione andava regolata perché una donna e un uomo non possono vivere sotto lo stesso tetto per tanto tempo senza essere sposati. Per me si trattava di mettere solo una firma. Lo facemmo. Non ho nessun ricordo gradevole di quel periodo di fidanzamento che pure dovrebbe riscaldare il cuore di una ragazza. Dovetti fare tutto da sola, incartamenti, festa, fede, vestiti. Mia madre non era per niente d’accordo, mi diceva che quella persona non era adatta a me. Ma si sa, si cerca spesso di dimostrare che i genitori hanno torto. E io non ho fatto eccezione. Quindi per tornare alla domanda: ne ero innamorata? Non credo proprio. So solo che avevo bisogno di qualcuno che si occupasse di me e che lui sembrava gentile e disposto a farlo. Più tardi, almeno fino a quando siamo rimasti in Italia, credo di essermi perfino affezionata a lui. Sai, come ci si può affezionare a un gatto”.
Ride fra le lacrime e poi continua.
“Ricordo la prima volta che vidi il suo vero carattere. Avevo accettato di fare lavori umili per i primi tempi, sempre nella ristorazione: lavapiatti, cameriera, aiuto cuoco. Ma ne avevo abbastanza, volevo un lavoro migliore, avevo delle competenze, ero sicura di meritarlo. Quando glielo dissi mi fece la prima scenata: mi insultò ricordandomi di stare al mio posto. Era un primo segnale, ma invece di capirlo e lasciarlo, lo sfidai: trovai un posto migliore come responsabile in un negozio, con un vero contratto e glielo sbandierai sotto il naso. Poi fui assunta in un’azienda iraniana del settore petrolifero, nel reparto commerciale. Guadagnavo molto più di lui che era rimasto nel negozio di import-export e capivo che la cosa non gli faceva proprio piacere. Ma anche lì, non vidi nessun segnale di pericolo”.
Perché siete tornati in Iran?
“Eravamo rimasti disoccupati tutte e due dopo le sanzioni economiche a Teheran. La mia azienda aveva chiuso, i titolari del suo negozio avevano lasciato l’Italia. Lui non trovava nessun lavoro, io invece sì, ma non gli andavano mai bene. Arrivò il primo schiaffo e le prime cinghiate. Ero sconcertata, non capivo, non sapevo che fare. E nel frattempo i soldi del risparmio finivano. Fu allora che mi propose di tornare in Iran: forse lì sarebbe stato più facile per lui trovare lavoro. Gli dissi di sì e a mia madre, che mi scongiurava di non farlo, ricordandomi quanti sacrifici avevamo fatto per raggiungere l’Italia, rispondevo che mi mancava il mio Paese, che l’avevo lasciato da giovane e che volevo tornarci. Che follia.”
Arrivati in Iran che succede?
“Già in aereo mi aveva fatto la lezione: guarda che una donna in Iran segue suo marito e fa quello che gli dice lui, non è come in Italia dove hanno uguali diritti. Io non capivo cosa volesse dire e non ci feci caso. La nuova vita sembra partire bene. Nella mia città natale trovo subito lavoro presso un vecchio parente che ha bisogno di qualcuno che si occupi dei suoi negozi e io sono la persona adatta. Ma subito si presenta anche lui: vuole essere assunto nello stesso posto, per controllarmi. Il titolare cerca di fargli cambiare idea, poi cede. Dopo una settimana ci fa la proposta di andare insieme in un’altra città per gestire una serie di negozi: oltre a un buon salario, il vitto e l’alloggio erano gratis, ma la responsabile delle vendite e dell’organizzazione sarei dovuta essere io. Accettiamo e partiamo. In un primo tempo va tutto bene. Poi comincia a interferire nel mio lavoro: si presenta come il direttore, mi manda nel magazzino quando entra un uomo giovane. E soprattutto non sopporta che io sia apprezzata e che guadagni più di lui, anche in Iran. Un giorno, durante una lite, mi rompe un dito storcendomelo con violenza. Ai medici dice che mi era ferita alzando una grossa scatola. C’era anche il mio titolare. Nessuno crede a una parola. Ma nessuno può farci niente”.
Perché non riesce a lasciarlo?
“Bella domanda. Anche il mio titolare me la fece il giorno in cui mi vide in ospedale con il dito rotto. Allora mi propose di gestire tutti i suoi negozi nel resto del Paese, ma che lui non avrebbe più voluto vederlo. Quando glielo dissi diventò una belva e mi riempì di botte accusandomi di avere una relazione con il titolare. Lasciai il lavoro invece di lasciare lui”.
La storia non finisce qui. La nostra “Mahsa Amini” continua a subire e non reagire, nemmeno quando il marito le cosparge di benzina la spalla e le dà fuoco: le cicatrici sono ancora evidenti.
Sarebbe potuto andare così all’infinito se non fossero arrivati i figli. A quel punto erano le vite dei bambini che bisognava salvare, non solo la sua. E il giorno in cui il marito aggredisce il primogenito sbattendolo contro un muro, “Mahsa Amini” ricorda tutto quello che aveva imparato in Italia: il rispetto, l’indipendenza, la libertà.
O tradotto nelle parole del movimento delle ragazze e dei ragazzi del suo Paese: donne, vita, libertà.
Contatta così un centro antiviolenza italiano fra i più noti, viene ascoltata, e il meccanismo di salvataggio scatta. Deve solo riuscire a partire dall’Iran. Ma ha capito la lezione ed è scaltra. Riesce a farsi firmare dall’aguzzino i documenti per l’espatrio per se e per i figli, e finalmente parte.
L’ultimo ricordo è doloroso quanto il resto.
“Mancava un passo prima di entrare in aereo e non sono riuscita a farlo: ero pietrificata. E’ dovuta venire una hostess ad aiutarmi”.
Oggi anche la nostra “Mahsa Amini” festeggerà l’8 marzo. Lo dedicherà alle donne iraniane che sono ancora prigioniere, dello Stato e di troppi uomini-padroni . E lo facciamo anche noi.